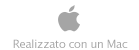|
| |
| |||||
|
|
DANIELE CESCHINIL VAJONT COME METAFORA DELLA «NAZIONE INFETTA»Dunque: indegnità, disprezzo per i cittadini, manipolazione di denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali, con i banchieri, connivenza con la mafia, alto tradimento in favore di una nazione straniera, collaborazione con la CIA, uso illecito di enti come il SID, responsabilità nelle stragi di Milano, Brescia e Bologna (almeno in quanto colpevole incapacità di punirne gli esecutori), distruzione paesaggistica e urbanistica dell'Italia, responsabilità della degradazione antropologica degli italiani (responsabilità, questa, aggravata dalla sua totale inconsapevolezza), responsabilità della condizione, come si usa dire, paurosa, delle scuole, degli ospedali e di ogni opera pubblica primaria, responsabilità dell'abbandono «selvaggio» delle campagne, responsabilità dell'esplosione «selvaggia» della cultura di massa e dei mass-media, responsabilità della stupidità delittuosa della televisione, responsabilità del decadimento della Chiesa, e infine, oltre a tutto il resto, magari anche distribuzione borbonica di cariche pubbliche ad adulatori.1. PER UNA DIVERSA SEMANTICA DEL DISASTRO Sarebbe vana la ricerca della notizia della tragedia del Vajont in un libro di storia dell'Italia repubblicana. E ciò a dispetto del fatto che si tratta del disastro più grave in termini assoluti che ha colpito la popolazione civile in Europa, almeno nel secondo dopoguerra. Sarebbe inutile una ricerca anche nel volume einaudiano dedicato al Veneto e uscito nel 1984. Gli unici che ne fanno menzione sono gli storici dell'economia, interessati evidentemente al tema della nazionalizzazione dell'energia elettrica e dello sviluppo in Italia tra gli anni cinquanta e sessanta1. Il giornalismo italiano ha tuttavia assunto il termine «Vajont» per definire disastri «naturali» largamente prevedibili, o comunque imputabili alla responsabilità dell'uomo. Ad esempio, la cronaca delle alluvioni degli anni novanta (in Piemonte nel novembre 1994 e in Campania nel maggio 1998), dovute al dissesto idrogeologico, ha ripetutamente richiamato la tragedia del 1963. Insomma, la parola Vajont e diventata un «luogo comune»2, evoca immediatamente la catastrofe, quasi come «Caporetto» la disfatta militare e «Corea» la sconfitta calcistica vergognosa e senza appello. L'uso estensivo e talvolta improprio di questi termini testimonia quanto il loro significato sia immediatamente compreso dall'opinione pubblica, anche in assenza di una conoscenza puntuale degli eventi che li hanno generati, spesso neppure dell'anno in crn sono accaduti. Quella del 9 ottobre 1963 da un lato ha molti punti in comune con altre tragedie precedenti e posteriori. Come non pensare, ad esempio, al crollo della diga del Gleno, tra le province di Bergamo e di Brescia, che il 1° dicembre 1923 provocò la morte di 259 persone3, oppure alla catastrofe di Stava del 19 luglio 1985 che spazzò via in pochi minuti la vita di 268 persone4, e ancora al disastro di Sarno e Quindici del maggio 1998? Anche in questi casi le responsabilità dell'uomo sono evidenti. Dall'altra possiede una sua unicità che le deriva dal contenere insieme tutti gli elementi che caratterizzano le catastrofi in epoca contemporanea: il rapporto tra politica ed economia, le pieghe di uno sviluppo senza pianificazione, il ruolo della stampa con le sue censure e autocensure, i risvolti giudiziari, la memoria pubblica dell'evento, il ruolo attivo dei sopravvissuti nel testimoniare il loro essere tali. Tuttavia, mi risulta difficile adottare in maniera indistinta la categoria di «disastro» per tentare di spiegare il peso che il Vajont ha nella storia dell'Italia repubblicana. Almeno come è stato fatto da alcuni studiosi anglosassoni in un volume uscito nel 2002 e dedicato ai disasters dall'Unità ai giorni nostri5. Pur nella diversita degli approcci, nel volume si parla di disastro, sciagura, disgrazia, tragedia, strage, catastrofe, emergenza, passando dalle sconfitte coloniali di Dogali e Adua alle epidemie di colera e malaria, dal terremoto di Messina a Caporetto, dalla strage di piazza Fontana a quella di Bologna, dai terremoti del Belice, del Friuli e delFIrpinia all'alluvione di Sarno. È evidente che sotto il profilo metodologico siamo di fronte a un volume eclettico, che adotta la categoria del disastro in maniera impropria o perlomeno troppo estensiva. Mi pare invece maggiormente stimolante immaginare, in sede di premessa, una sorta di «semantica del disastro» che includa esplicitamente il ruolo attivo dell'uomo nella costruzione dell'evento. Con il Vajont non siamo di fronte a un evento irrazionale, ma perfettamente intelligibile nelle sue cause, nelle sue dinamiche e nelle sue conseguenze. Gli attori del Vajont hanno dei nomi e delle responsabilità che, per chi li avesse voluti conoscere, erano già noti ben prima del 1963. Le Commissioni d'inchiesta - governativa e parlamentare - e il processo non hanno fatto altro che certificare, pur con tinte diverse, quanto già era ampiamente documentato e scritto. Ecco perché il Vajont può essere considerato un disastro «al cubo». Non è il numero delle vittime - comunque spaventoso - a renderlo tale, quanto il consapevole concorso di colpa di più soggetti. Se nelle ore immediatamente successive all'evento Tina Merlin si parla di «disastro» riferendosi alla scena che si presenta ai suoi occhi, con le notizie ancora incerte su ciò che è avvenuto, poi utilizza esplicitamente il termine «genocidio», quando chiama in causa le responsabilità della SADE. Parola forte che in questo caso non implica colpa o dolo, ma una criminale premeditazione nell'aver portato avanti un'impresa contro le leggi della natura e la volontà degli uomini. Non si tratta di uno sfogo dettato dalle emozioni del momento, perché il genocidio della montagna e dei suoi abitanti e stato costruito lentamente negli anni, perizia dopo perizia, concessione dopo concessione, senza che nessuno intervenisse se non per zittire le isolate voci che avvertivano del pericolo. Ma nel lungo periodo - tenendo conto anche delle successive vicende giudiziarie e della rimozione che è intervenuta a livello pubblico per molti anni - il termine «tragedia» risulta quello più appropriato per descrivere in maniera compiuta il Vajont. Non enfatizzerei nemmeno il fatto che si tratta di una «tragedia annunciata», piuttosto che si tratta di una «tragedia italiana» che si spiega alla luce del modo tutto particolare di intendere il rapporto che deve esistere tra istituzioni - a tutti i livelli - e cittàdini, tra governanti e governati. 2. ALL'EPOCA DEI BARONI Lo sviluppo economico in Italia ha comportato degli oneri enormi e non solo per l'anomalia di un capitalismo fondato sul principio di privatizzare i profitti e socializzare le perdite che, a ben vedere, potrebbe essere anche il male minore. Piuttosto per i costi sociali e ambientali direttamente proporzionali al disinteresse di coloro che hanno operato le scelte strategiche dell'economia italiana nel secondo dopoguerra: le classi dirigenti nazionali e locali in tutte le loro articolazioni statali e parastatali, il capitalismo pubblico e l'industria privata. Nasce da un patto non scritto tra questi attori politici ed economici uno sviluppo senza pianificazione e, nella migliore delle ipotesi, una tendenza a programmare senza tener conto degli effetti che le dinamiche del capitalismo avranno sulla società e sull'ambiente. Intorno alla metà degli anni cinquanta il dibattito sulle nazionalizzazioni parte dalla premessa della coesistenza tra industria pubblica e industria privata (economia a due settori) e dalla necessità di rompere tutte le situazioni di monopolio che impediscono da un lato una reale concorrenza economica, dall'altro una trasparenza delle istituzioni democratiche. Nel caso del settore elettrico - considerato un servizio pubblico essenziale, di per sè strategico e, nella sua struttura, del tutto inadeguato a rispondere alle esigenze dello sviluppo industriale - la nazionalizzazione non si dovrebbe risolvere con la semplice sostituzione di una serie di baronìe private con una baronìa pubblica, e prioritario sarebbe il suo inserimento in un sistema di pianificazione economica. Sono gli «amici del "Mondo"» - tra gli altri, Leopoldo Piccardi, Ugo La Malfa, Eugenio Scalfari e, con maggiore convinzione, Ernesto Rossi - a promuovere una serie di discussioni sul tema. Per l'editore Laterza escono in quegli anni La lotta contro i monopòli (1955), Atomo ed elettricità (1957), Le baronìe elettriche (1960) e, infine, il volume di Rossi, Elettricità senza baroni (1962), con un'ampia introduzione di Piccardi8. Le resistenze dei maggiori «feudi elettrici» riuniti nell'ANiDEL sono enormi e quando diventano politicamente maturi i tempi per la nazionalizzazione, le società tenteranno di rimandare sine die la loro capitolazione, ad esempio proponendo un improbabile coinvolgimento dell'IRI nella gestione del settore. È in questo contesto che viene preparata la tragedia del Vajont. Il suo «corto circuito» è che tutta la vicenda della costruzione della diga, fino all'esito finale, corrisponde agli anni del 'boom economico'. L'Italia del miracolo, con la sua fame di energia, ha spinto i baroni verso lo sfruttamento di ogni valle per la produzione di elettricità. A questo si aggiunga la necessità di completare in fretta le opere, comunque prima della nazionalizzazione per realizzare un maggiore guadagno sull'indennizzo. Siamo quindi di fronte a una delle conseguenze di uno sviluppo inteso come elemento per ottimizzare i profitti, senza curarsi della volontà (o anche solo del coinvolgimento nelle decisioni) delle comunità della valle e dei rischi per il territorio e la popolazione che lo abita. La tragedia del Vajont è quindi esemplare anche per il rapporto fra centro e periferia, tra Roma ed enti locali, e propone il tema delle scelte negoziate e condivise. Il legame tra potere politico e potentati economici è evidente negli anni cinquanta rispetto al «sacco» edilizio in città come Roma, Napoli, Palermo. «Capitale corrotta=nazione infetta». È l'11 dicembre 1955 quando Manlio Cancogni denuncia dalle pagine di un magazine appena nato, «L'Espresso», la speculazione edilizia a Roma favorita dalla Giunta democristiana di Salvatore Rebecchini. Non siamo di fronte a scelte strategiche per lo sviluppo del Paese, ma a connivenze neanche tanto celate tra amministratori e «palazzinari» che si arricchiscono a dismisura creando intere borgate dal nulla. Cancogni ha aperto un varco - a sue spese - nel fortino popolato di pianificatori delle periferie e di sventratori delle città storiche, quegli stessi che sono presi di mira da un altro fustigatore dell'urbanistica moderna, Antonio Cederna. Dalle pagine de «Il Mondo» di Pannunzio, il fondatore di Italia Nostra conduce per quindici anni una solitaria battaglia contro i «vandali in casa» ovvero proprietari e mercanti di terreni, speculatori di aree fabbricabili, imprese edilizie, società immobiliari industriali commerciali, privati affaristi chierici e laici, architetti e ingegneri senza dignità professionale, urbanisti sventratori, autorità statali e comunali impotenti o vendute, aristocratici decaduti, villani rifatti e plebei, scrittori e giornalisti confusionari o prezzolati, retrogradi profeti del motore a scoppio, rètori ignorantissimi del progresso in iscatola9. Nell'anno del Vajont il cinema italiano partorisce uno dei suoi più importanti film d'impegno civile, Le mani sulla città, scritto da Enzo Forcella, Raffaele La Capria ed Enzo Provenzale, per la regia di Francesco Rosi. La città è la Napoli violentata dalle amministrazioni clientelari di Achille Lauro e Silvio Gava, le mani sono quelle di un consigliere comunale di destra che allo stesso tempo è anche uno speculatore immobiliare senza scrupoli: grazie alla sua spregiudicatezza riuscirà a diventare assessore all'edilizia, modificare il piano regolatore e ridisegnare lo sviluppo urbanistico della città. Sempre nell'anno del Vajont viene affossato il progetto di legge di un coraggioso ministro dei Lavori pubblici, il democristiano Fiorentino Sullo, che vorrebbe introdurre un percorso virtuoso in materia urbanistica, attraverso l'individuazione delle aree da edificare, il loro esproprio, l'urbanizzazione a carico degli enti pubblici e, infine, la ricessione ai privati con diritto di superficie; in sostanza la proprietà del suolo sarebbe rimasta pubblica e il diritto a edificare trasformato in una concessione, in modo da sottrarre il territorio alle speculazioni immobiliari11. Nonostante la riforma sia una delle richieste dei socialisti per entrare formalmente «nella stanza dei bottoni», Sullo con le elezioni alle porte e le pressioni della stampa conservatrice e dei gruppi di potere che demonizzano la nuova legge come un attentato alla proprietà privata - viene sconfessato pubblicamente dal suo stesso partito; non se ne farà nulla e i successivi interventi normativi saranno dei compromessi al ribasso - che salvaguarderanno i privilegi della legge urbanistica del 1942 - nati in una fase in cui il centrosinistra, dopo il «tintinnìo di sciabole» dell'estate del 1964, ha scelto deliberatamente di intraprendere la via di un riformismo a scartamento ridotto12. La timida legge-ponte varata nel 1967 - peraltro ulteriormente indebolita da un anno di moratoria - è diretta conseguenza dei disastri ambientali dell'anno precedente: la frana di Agrigento del luglio 1966 e le alluvioni di Firenze e Venezia del novembre successivo. Nel primo caso finiscono sotto accusa l'abusivismo edilizio, l'affarismo urbanistico eretto a forma di governo del territorio e la condotta amministrativa delle locali classi dirigenti democristiane13. Le conclusioni della relazione di Michele Martuscelli, incaricato dal Ministero dei lavori pubblici di compiere un'accurata inchiesta, sono inequivocabili: "Gli uomini in Agrigento hanno errato, fortemente e pervicacemente [...], nella veste di responsabili della cosa pubblica e di privati speculatori. Il danno di questa condotta, intessuta di colpe coscientemente volute, di atti di prevaricazione compiuti e subìti, di arrogante esercizio del potere discrezionale, di spregio della condotta democratica, e incredibile per la città di Agrigento. Enorme nella sua stessa consistenza fisica e ben difficilmente valutabile in termini economici, diventa incommensurabile sotto l'aspetto sociale, civile e umano14."L'arrivo della Commissione d'inchiesta ad Agrigento ha i contorni della scoperta di un mondo capovolto, sorto in maniera quasi inconsapevole senza che nessuno se ne sia accorto. Un mondo irriconoscibile difficile da immaginare anche nella Sicilia della metà degli anni sessanta: "All'improvviso, all'uscita dall' ultima curva, nella luce accecante, gelatinosa di quel pomeriggio afoso, gli si para davanti, in cima alla collina franosa, la città ignota. Ferma, ferma, ma cos'è quella? Agrigento. Agrigento?3. «NOTIZIE FALSE E TENDENZIOSE, ATTE A TURBARE L'ORDINE PUBBLICO» Nell'Italia degli anni cinquanta la libertà di stampa e «una seccatura da poco» dal momento che i giornali sono finanziati dai gruppi industriali e non si azzardano «a prendere una posizione decisa contro i grandi baroni, che possono far nominare e licenziare i ministri e che sostengono il Governo in carica, anche se il più delle volte lo sostengono come la corda regge l'impiccato»16. La stampa continua a essere controllata dai grossi gruppi industriali. È del 1953 la sinergia tra l'Eridania e la Italcementi di Carlo Pesenti per la concentrazione di grandi testate come «Il Giornale d'Italia», «Il Resto del Carlino», «La Nazione» e «La Notte», e non certo «per dar lavoro a qualche diecina di intellettuali o per formare l'educazione politica del popolo italiano»17. Cominciano anche a venire meno gli editori puri, quelli che possono sopravvivere solamente con le proprie testate, con la conseguenza che l'autonomia dell'informazione dal potere economico diventa un miraggio. Un sasso nello stagno del conformismo e del servilismo della stampa lo getta nel giugno 1959 Enzo Forcella, con un ritratto ironico e amaro del giornalismo politico, che non gode dei vantaggi del potere, perché ne è immerso come in una «atmosfera delle recite in famiglia, con protagonisti che si conoscono fin dall'infanzia, si offrono a vicenda le battute, parlano una lingua allusiva e, anche quando si detestano, si vogliono bene»18. Insomma, i giornalisti hanno una consonanza quasi antropologica con il potere, lo assecondano, frequentano gli stessi salotti e finiscono per farne parte. E i millecinquecento lettori di Forcella, gli unici che contano anche se la tiratura del giornale è di 300.000 copie, sanno essere anche magnanimi, non alzano mai la voce più del dovuto, ma quanto basta per indurre il notista a sviluppare ed esercitare l'autocensura. Ne esce un quadro disarmante sulla subalternità della stampa al potere: la cronaca dei quotidiani nei giorni della tragedia del Vajont ne e una triste conferma19. Nell'ottobre del 1997, pochi giorni dopo la messa in onda dell'orazione di Marco Paolini, sollecitato da un lettore Indro Montanelli rispondeva in una delle sue Stanze del «Corriere della Sera» alla denuncia di sciacallaggio verso i morti che l'attore aveva ricordato: "Quella trasmissione io non l'ho vista e quindi non ho sentito il monologo che mi tira in ballo e che - mi dicono - era molto efficace. Non ho motivo di dubitarne. Ma forse ne ho qualcuno per dubitare della sua imparzialità se è vero che l'autore si è limitato a citare una mia frase, isolandola dal contesto del mio articolo: un metodo con cui si può dimostrare qualsiasi cosa. [...] Perché scrissi questo? Perché eravamo in piena battaglia pro e contro la nazionalizzazione dell'industria elettrica, e mi ripugnava che quel disastro venisse strumentalizzato per alimentare la campagna contro le società private, ad una delle quali - la Sade, se ricordo bene - l'impianto del Vajont apparteneva. Effettivamente poi l'inchiesta - che durò anni ed è tuttora contestata - appurò che la diga era stata costruita contro il parere di alcuni (di alcuni, non di tutti) geologi che avevano segnalato il rischio del distacco di un pezzo di montagna, e costò a qualche dirigente dei castighi certamente inadeguati all'entità del disastro, ma non a responsabilità che risultarono tali solo fino a un certo punto. Ma se oggi mi ritrovassi di fronte a un cataclisma (che Dio non voglia) del genere, strumentalizzato a fini politici, come lo fu quello, ripubblicherei tal quale quell'articolo che invocava la solidarietà di tutto il Paese al di sopra e contro le divisioni ideologiche. Non ho nulla di cui pentirmi e da ritrattare. La mia regola e sempre quella: quando si accendono i roghi, si sta dalla parte delle streghe, non dei pirofori20."A dirla tutta, la battaglia sulla nazionalizzazione si era di fatto già conclusa, il dibattito semmai riguardava le modalità d'indennizzo delle vecchie società elettriche. Omissiva e reticente nonostante l'evidenza, la puntualizzazione di Montanelli dopo trentacinque anni appariva ancora con 1 ' ua non tanto dal suo proverbiale anticomunismo, quanto dall'idiosincrasia verso l'incontro tra giornalismo politico e giornalismo d'inchiesta. La tematica non appassionava di certo Montanelli, ma poteva un cronista condurre un'inchiesta scrivendo su un giornale di partito? Detto diversamente, denunciare pubblicamente il pericolo che i paesi della valle correvano in conseguenza della costruzione della diga, poteva solo essere disfattismo? Quello di Tina Merlin non era considerate giornalismo d'inchiesta, anche se nella sostanza lo era: gli articoli della giornalista de «L'Unità» erano stati derubricati a pezzi di cronaca politica, e lei stessa scontava due difetti, essere donna ed essere comunista. Ora doveva fare ammenda per essere stata la «Cassandra» del disastro. Sono proprio la campagna di Tina Merlin e le interpellanze dei parlamentari comunisti a rendere incomprensibile l'accusa di speculazione politica, soprattutto a distanza di molti anni. Non riconoscerlo non è solo cinico ma segno di disonestà intellettuale. Quella del PCI non era stata nient'altro che una battaglia politica condotta, anche nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, con senso di responsabilità, a cominciare dalla richiesta d'istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta. Alla Camera si levò subito alta la protesta dei comunisti per voce del deputato padovano Franco Busetto, che rifiutava l'idea del fatalismo e del qualunquismo «di un'Italia divenuta un sordido Paese in cui tutto può accadere e in cui 2 mila cittàdini, fra i quali 500 bambini, possono morire in pochi minuti senza che qualcosa cambi»22. Ma quella del dissenso, o anche solo del cordoglio, era «un'Italia da rimuovere» come i blocchi stradali dei superstiti del Vajont nel dicembre del 1963 e nel febbraio successivo22. Qualche anno più tardi solo il processo avrebbe riportato la tragedia in primo piano: "Ormai il Vajont «non fa più notizia» per i grandi giornali d'informazione. Hanno raccolto forti somme di denaro. Le hanno distribuite agli orfani ai danneggiati, ai superstiti. Longarone sarà ricostruita, il governo l'ha promesso. La Commissione parlamentare d'inchiesta indaga. Il Magistrato sta svolgendo il suo lavoro. Si volta pagina. Insistere su questo tema, continuare a scrivere in chiave di lutto, di distruzioni, di dolore, annoierebbe chiunque.4. PAROLE CHIAVE La tragedia del Vajont possiede una singolarità: è possibile sezionarla, scomporla in tanti segmenti che poi, presi uno a uno, riescono a restituire un quadro complessivo dell'intera vicenda. La magistrale arringa dell'avvocato Sandro Canestrini al processo dell'Aquila - siamo nel settembre 1969 - costituisce un testo di rara lucidità, in particolare quando sottolinea le implicazioni nel disastro di un'intera classe dirigente: atto d'accusa tremendo che rimane a futura memoria, forse addirittura di più delle sentenze che alla fine si scontano. L'arringa, per come è congegnata, costituisce la vera condanna. La lettura di quel testo permette di individuare una serie di parole chiave e di sintagmi che spiegano il Vajont in ogni sua parte, lo rendono comprensibile anche a chi ne sente parlare per la prima volta: politica, economia, morale, genocidio, strage di Stato, mito della tecnica, scienza a servizio del potere, natura, fatalità, colpa. "L'uomo della strada, che conosce luoghi e date di nascita, camera, gusti, abitudini, avventure coniugali ed extraconiugali di tutte le stelle del cinema, dei campioni di calcio e dei canzonettisti più in voga non sa neppure che faccia abbiano, anzi neppure conosce i nomi delle poche decine di persone dalle cui decisioni molto spesso dipende in Italia l'occupazione o il licenziamento di decine di migliaia di lavoratori, i prezzi dei generi di più largo consumo, lo sviluppo o il ristagno dell'economia di intere regioni, la formazione dell'opinione pubblica attraverso i giornali, la Rai e la tv, i nostri rapporti con l'estero ed anche la nomina dei ministri: niente sa, insomma, su quelli che sono i veri «padroni del vapore»25."Il processo dimostra come politica ed economia in Italia siano legate a doppia mandata, di più «come la politica sia economia e come la legge del profitto determini scelte politiche»26. Oppure come non le determini, sminuendo la cosa pubblica a mero braccio servente del potere economico. L'altro concetto importante connesso alle collusioni tra politica ed economia, è quello morale, del rapporto fra potere ed etica della responsabilità: «Chi si mette al servizio di interessi disumani perché contro l'umanità, è complice di un genocidio, come è stato un genocidio quello del Vajont, e la qualificazione morale è fuori dubbio»27. Ma in riferimento al Vajont, è legittimo parlare di «strage di Stato»? Credo lo sia nella misura in cui si possa rinvenire una responsabilità diretta o indiretta delle istituzioni nella «preparazione» della tragedia. Negli anni della strategia della tensione, spezzoni dello Stato, nel tentativo di sovvertire l'ordinamento democratico, favoriscono le stragi o non fanno nulla per disinnescarle; non solo, ma si adoperano fin da subito per coprire le responsabilità e depistare le indagini. Nel caso del Vajont vi erano state omissioni, connivenze, contributi finanziari che avevano permesso la costruzione e il completamento della diga favorendo unicamente la SADE a discapito dell'interesse pubblico (peraltro anche di quello economico), perfino dopo la nazionalizzazione: "D'ora in poi quanto accadrà sul Vajont porterà anche la firma diretta dello Stato. Non solo, come prima, in quanto controllore, ma in quanto proprietario. Di un manufatto pericoloso, che conosce poco e male perché gli è stata nascosta la verità, non l'ha voluta conoscere, si è fidato del monopolio e dei suoi tecnici e consulenti illustri, ha coltivato e tollerato dentro i suoi ministeri uomini corrotti e doppiogiochisti. Uno Stato onesto verso i suoi cittàdini non avrebbe dovuto prendere in consegna un impianto avariato come questo del Vajont che non era ancora giunto, proprio per questo, alla fase di collaudo e quindi alla certezza del suo buon funzionamento. Probabilmente in nessun altro posto del mondo ciò sarebbe accaduto se non, come in Italia, per complicità e corruzione politica. [...] La Sade non e arrivata al traguardo della nazionalizzazione col manufatto finito, ma vuole finirlo almeno per il momento in cui si faranno i conti. Perduti gli ultimi contributi per costruirlo tende a farselo almeno pagare alla consegna. Ormai il rischio è dimezzato per quanto riguarda l'incolumità pubblica, anzi, non è più suo28."Se è vero che la SADE era uno «Stato nello Stato», allora, come scrivono i socialisti in un documento di minoranza della Commissione parlamentare d'inchiesta, lo Stato è apparso un simulacro di potere, una fabbrica automatica di autorizzazioni, di permessi, di assentimenti, di concessioni; è sembrato come un mosaico incomposto di poteri, l'uno dissociato o limitato o conteso dall'altro, che invano ha cercato di contrastare, anzi, che neanche ha tentato di contrapporsi al blocco di potere, esso sì compatto e deciso nel perseguimento dei propri obiettivi, rappresentato dal concessionario29. Anche Canestrini sembra in qualche modo sottintendere che la strage abbia molto a che fare con lo Stato, ma la vera questione è un'altra. Al netto delle responsabilità, che forma, natura e ruolo ha lo Stato? Può lo Stato condannare se stesso? Dove finisce lo Stato che costruisce, difende, assolve o condanna il disastro e dove inizia lo Stato dei cittàdini? "Lo Stato è qui tutto insieme: giudice, vittime ed imputati. Nuove contraddizioni, nuovo naufragio: si chiede giustizia allo Stato attraverso questo Tribunale dello Stato ma lo Stato, a quale Stato darà ragione? Allo Stato Enel, alla Sade 'Stato nello Stato', allo Stato dei cittàdini, a quale Stato dei due diversi ed opposti tipi di Stato che l'avvocatura dello Stato rappresenta in un contrasto insanabile? Ma tant'è, ogni incenso deve essere bruciato, ogni sacrificio deve essere compiuto in nome di un feticcio quale è la teoria della continuità dello Stato, di quella continuità di sistemi economici e politici che la storia superficiale sembra smentire ma che in realtà è [...] il filo rosso conduttore nonostante le contraddizioni anche spaventose della storia vera del nostro Paese30."Questo principio investe quindi anche la scienza e la tecnica al servizio del potere politico e di quello economico, ovvero che si prostituiscono a essi: "Qui tutti gli imputati sono tecnici, legati a cordone ombelicale ai tecnici che non sono stati imputati, al comune servizio della classe dirigente. Della Sade è stato fatto un impero, da parte dei suoi dirigenti, e i funzionari suoi sono stati trasformati in cortigiani51."Il disastro non può rientrare nella casistica degli eventi naturali, o peggio delle fatalità, in definitiva delle tragedie spaventose come direbbe Indro Montanelli - «le carestie, le pestilenze, i cicloni, i terremoti». Il Vajont è cosa diversa dalla catastrofe naturale, e altro dall'evento eccezionale e imprevedibile: "Il Vajont non è la tragica eccezione al sistema, ma la conferma di esso: in questa vicenda veramente non è mai accaduto nulla di eccezionale. Solo, come spesso succede, c'era un rischio, prevedibile e previsto: ma anche ad Agrigento c'era il rischio che crollasse mezza città a causa dei lavori della speculazione edilizia; anche in Piemonte lo sfruttamento indiscriminato della montagna comportava il rischio dell'alluvione; anche in Sicilia la politica della casa così come concepita ed attuata portava il rischio che un terremoto non trovasse in quelle mura nessuna resistenza52."Tirare in ballo la natura significa negare razionalità all'evento catastrofico e rinunciare a priori a scoprirne le cause. Non c'è nulla di naturale nella frana del monte Toc, la fatalità non può essere contemplata e non occorre certo il processo per dimostrarlo. Ed è emblematico che, ancora nel 2000, in un volume di foto dell'archivio de «Il Gazzettino» - ai tempi della catastrofe il quotidiano legato alla Democrazia cristiana del Veneto - le immagini della tragedia del Vajont siano inserite nella sezione 'Vendette della natura' invece che in quella denominata 'Sciagure annunciate'. Che non sia una svista lo si evince dal testo delle didascalie delle prime due foto: «Nell'ottobre del 1963, il monte Toc si sfalda e precipita nel bacino artificiale del Vajont. L'ondata che ne segue supera la diga e precipita a valle, sull'abitato di Longarone, uccidendo in un attimo centinaia di persone». E in quella successiva che illustra «l'immensa mole del monte Toc, scivolato su se stesso, causa della sciagura»". Insomma, il disastro è attribuito al determinismo di una natura tanto «matrigna» da consentire alle montagne di spostarsi, «sfaldarsi» e «scivolare» (addirittura su se stesse). Se il Vajont ha insegnato qualcosa è stata la possibilità di escludere la fatalità e di introdurre il concetto di colpa, scoprirne la valenza. Non si tratta di cosa da poco viste le premesse e la potenza di fuoco di cui possono disporre - economicamente, politicamente e dal punto di vista mediatico - gli imputati. Il «lungo viaggio attraverso la colpa» si è trasformato così in un outing doloroso, ma necessario: "L'esperienza di quel processo ha comunque significato, nella parte più sensibile della classe politica ed amministrativa e anche nell'opinione pubblica, una cesura. Per la prima volta in Italia si coniugavano, non soltanto ritualmente, il sillogismo, o la dialettica, rapportati al codice penale ed alla scienza del diritto, della colpa. Ma allora, soprattutto nella Marienbad dedicata, nell'Aquila degli Abruzzi, alla dea della bilancia non appariva vilipeso, almeno nell'area ristretta, l'impegno a riscoprire quel senso di colpa che è senso della liberazione54."5. IL RITO DELLA MEMORIA: DALLA RIMOZIONE AL RACCONTO Di fronte alle grandi tragedie nazionali l'opinione pubblica italiana oscilla tra la solidarietà e la commiserazione, almeno fino al momento in cui non subentra l'indifferenza che conduce all'oblìo. Ciò dipende dall'incapacità di assumere un evento come qualcosa che appartiene - al netto degli aspetti emozionali - al proprio orizzonte, alle vicende del Paese in cui si vive. Tale anomalia vale sicuramente per le catastrofi naturali, ma in parte anche per quei momenti della storia dell'Italia repubblicana a loro modo periodizzanti: tra gli altri, almeno la strage di piazza Fontana, il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, le stragi di Palermo del 1992. Il Vajont non fa eccezione. La rimozione è intervenuta a più livelli, al punto che non siamo di fronte a una memoria nazionale. Non è colpa solamente della tragedia che colpisce quella determinata comunità peraltro periferica rispetto alle grandi trasformazioni di quegli anni ma di una mancata elaborazione delle vere cause di quell'evento. La storia del Vajont, oggi, è un puzzle di centinaia di storie. Si potrebbe iniziare anche dalla fine, da quella memoria che stenta perfino a essere univoca, perché poi i sopravvissuti il dramma lo metabolizzano in maniera diversa dalla generazione successiva35. Già a vent'anni dalla tragedia Tina Merlin ammetteva, con la stessa rabbia del 1963, che la memoria era ormai diventata un rito che durava lo spazio di un anniversario, ma annotava anche che era cresciuta una generazione che del Vajont non sapeva nulla e a cui quella storia doveva essere raccontata. Rimozione, oblìo e disinteresse avevano sostituito il cordoglio, quella tragedia non aveva insegnato nulla: "Ricordare il Vajont per me, oggi - scriveva nel 1983 -, significa testimoniare di un grande momento di impegno dei comunisti in difesa della gente. Anche se eravamo soli e la DC ci chiamava «sciacalli». Ed è pure la testimonianza di una sconfitta più generale, poiché il Vajont che doveva insegnare tante cose sul piano della democrazia e della politica, in realtà è stato poi considerato solo un incidente36." "C'è qualcosa in Italia che non trema, non perde colpi: è l'attenzione all'emergenza in cui viviamo. C'è qualcosa nel lento inabissarsi dell'audience televisiva che resiste oltre ogni più rosea speranza: la cronaca in diretta dell'attenzione e dell'emergenza. Tre milioni e mezzo di audience sono un assoluto trionfo per uno spettacolo che è durato tre ore, che si e retto su un monologo, che ha parlato di morte. Un successo per Marco Paolini che ha fatto di questa orazione civile una ragione di spettacolo ma soprattutto di vita. E che ha governato il programma con bravura pari solo all'intensità della sua testimonianza. [...]. «Vajont» resterà uno dei grandi eventi televisivi della stagione (anche se la regia tv non è stata del tutto all'altezza della proposta), un baluardo contro l'insipienza che tiranneggia il video. Un esempio di tv povera, ma ricca di contenuti e di emozioni. [...] Come interpretare questa nuova voglia di «sociale televisivo»? Forse gli italiani desiderano seguire più da vicino gli avvenimenti cruciali. Forse il clima ingenerato dal terremoto acuisce il senso di responsabilità. O, forse, questo lutto indaffarato che attraversa il video ci induce semplicemente a trasformare la paura in voluttà. La tv realista è un sogno capovolto in cui ci tuffiamo detronizzati dall'insensatezza di ciò che accade38."Ma c'è di più. Appropriandosi dei testi di Tina Merlin, delle sue emozioni e della sua passione civile, Paolini diventa un maieuta della memoria, senza per questo sembrare un pedagogo. Parlare del Vajont significa sdoganarlo dal rito degli anniversari e dei decennali, dalla memoria locale dei paesi colpiti e restituirlo alla memoria nazionale, anche di quella di coloro che nel 1963 non erano nati. 6. IL VAJONT CHE RITORNA I ricorrenti disastri «naturali» degli ultimi quarant'anni hanno periodicamente riproposto il ricordo del Vajont. Il suo destino è quello di essere in qualche modo rivissuto in altre realtà. Nei giorni successivi ai disastri i giornali propongono riquadri con l'elenco delle catastrofi precedenti dove il Vajont spicca come un nome sinistro dall'alto del suo numero di vittime. È singolare però che anche gli editoriali sulle cause abbiamo molti punti in comune, quasi a ribadire quanto quell'evento non abbia insegnato nulla. Anche se la dinamica del disastro di Stava del luglio del 1985 è molto diversa, la stampa del giorno successivo evoca la tragedia del 1963. "È stato come un secondo Vajont", è uno dei titoli interni de «la Repubblica» che pubblica anche il ricordo di Giorgio Bocca piombato a Longarone come cronista de «Il Giorno» per raccontare lo «spettacolo lunare» che si presentava anche ai giornalisti, ai moderni «monatti dal cuore di pietra»; Bocca che inizialmente aveva avvalorato l'idea del «nessuno ne ha colpa» e che aveva trovato sconcertanti i tempi e le modalità della «speculazione politica compiuta dai comunisti». "Ci risiamo! Le esperienze del Vajont, di Seveso, delle inondazioni e di tanti altri disastri non sono servite a nulla. Un'altra sciagura, prevedibile e quindi evitabile (non si parli di fatalità!), si è abbattuta sul nostro Paese provocando dolorosissimi lutti e ingenti danni alle cose. Immediatamente é venuto l'ordine di accertare le responsabilità, punire i colpevoli. Il Vajont insegna che in qualche anno sarà celebrato il processo, poi vi sarà il ricorso in appello e infine saranno irrogate alcune condanne, presumibilmente lievi, e saranno concesse parecchie assoluzioni. Saranno pochi a pagare per tutti, e ciò non varrà certo a lenire il dolore di chi ha perduto persone care, né a risarcire i danni. Pochi i condannati e non i veri responsabili di questo e degli altri disastri passati, presenti e futuri40."Da Stava all'alluvione del Piemonte del novembre del 1994. Il rito dell'informazione si ripete, come pure la ricerca delle cause che tuttavia sono autoevidenti. Per chi ne scrive da anni diventa faticoso, persino imbarazzante continuare a ribadire dove stanno le ragioni del disastro, quasi si trovasse a recitare un gioco delle parti: «Ho sempre sentito il peso temibile dell'espressione "era imprevedibilità", impiegata da uomini la cui ignoranza è imperdonabile, che cercano solo di coprire le proprie responsabilità. Perché, se l'uomo non può impedire tutto, può prevedere molto: e ben pochi sono i disastri di fronte ai quali non resta che chinarsi a piangere i morti». Questo scriveva anni fa il grande geologo francese Marcel Roubault, e questo si adatta più che mai all'Italia. Un'Italia vittima da quarant'anni a intervalli regolari, di alluvioni frane straripamenti, per l'ignavia dei politici e l'arretratezza dei pubblici amministratori: ai ricorrenti sussulti dell'opinione pubblica ha fatto riscontro la quasi totale indifferenza del mondo della cultura. E di fronte a tante rovine e a tanti lutti, chi torna a riflettere e a scrivere su questa tragica costante dell'Italia moderna prova pena e imbarazzo41."Ma qui la responsabilità è collettiva, non riguarda poche società chiaramente individuabili e perseguibili. Per questo arrivano gli avvisi di garanzia ai prefetti di Asti e di Alessandria, i provvisori capri espiatori per tacitare i danneggiati e l'opinione pubblica: La televisione democratica fatta per le grandi audience popolari è tenuta a dare la parola al popolo, alle vittime, a quelli appena scampati con la casa piena di fango. Ed essi naturalmente, sconvolti dal dolore e dalla paura, si sentono perseguitati dal fato e dal mondo, dal governo ladro e dai concittàdini fortunati esenti dalla catastrofe.Le colpe sono da ricercare nel ritardo generale del Paese in termini di cultura industriale anche se, in maniera qualunquista, sono attribuite a quella politica che non ha saputo programmare e prevenire queste catastrofi. Il Governo Berlusconi - che ha appena varato un discusso condono edilizio e un pacchetto di provvedimenti che allenta vincoli e tutele - assolve il cemento e accusa gli ambientalisti piemontesi che si sono opposti al dragaggio dei fiumi. Questi temi diventano terreno di continua polemica tra i partiti «terremotati» dalle vicende giudiziarie di quegli anni. La tragedia del 1963 rimane sullo sfondo di una battaglia politica dove entrano interessi economici, scelte strategiche, visioni diverse su quale modello di sviluppo deve avere l'Italia del terzo millennio. Ad esempio, nell'estate del 1996 il segretario di Rifondazione comunista Fausto Berdnotti evoca il Vajont per opporsi al programma di privatizzazioni avviato dal Governo Prodi43. Dal Piemonte a Sarno il passo è breve. Le cause del disastro sono l'urbanizzazione selvaggia, l'abusivismo edilizio, la distruzione dei boschi, la cementificazione degli alvei dei fiumi, il saccheggio ambientale che si è consumato per decenni: La fatalità, questa volta, non c'entra. Lalluvione che ha colpito la Campania con una devastante colata di fango, sommergendo interi paesi e inghiottendo la vita di tanti poveri cristi, non è una «calamità naturale», un evento imprevedibile e inevitabile, un fenomeno arcano prodotto dalla furia degli elementi. È stato, piuttosto, il risultato - questo sì, logico e conseguente - di una lunga catena di ritardi, errori e carenze, imputabili a precise responsabilità politiche e amministrative che chiamano in causa il governo nazionale, la Regione Campania e gli stessi Comuni delle zone interessate, per un'omissione collettiva di «atti d'ufficio»44.Responsabilità politiche e degli amministratori locali, ma anche dei cittàdini che hanno contribuito quotidianamente a peggiorare la situazione costruendo al di fuori di regole urbanistiche e di vincoli ambientali. Sono passati trent'anni dai fatti di Agrigento: La metastasi urbana, qui e altrove, è tale che non sai più come difenderla [...]. Nel caos abitativo di Sarno e di Quindici non si sa più che cosa si dovesse fare, se lo sgombero della gente sarebbe stato la sua salvezza o invece un'ecatombe, se era o non era possibile dare un allarme tempestivo. Il disastro urbanistico dell'area vesuviana è tale che un allarme è ormai fuori dalle umane decisioni: se lo dai troppo presto si crea un caos logistico di proporzioni immani; se lo dai tardi è la strage, dieci cento volte superiore a quella di Pompei o di Ercolano45.Come nel caso dell'alluvione del Piemonte, la televisione gioca un ruolo decisivo nel veicolare la cronaca della tragedia, coprendo l'evento nei suoi aspetti drammatici e nella triste contabilità delle vittime. Non è da meno la carta stampata, molto attenta anche alle storie dei sopravvissuti raccolte sul posto. Uno studio dei quotidiani di quei giorni dimostra i modelli e i codici utilizzati, le dinamiche del racconto e le pratiche discorsive, in una parola la retorica del disastro46. Il comune denominatore rimane il rapporto tra uomo e natura, tra sviluppo capitalistico e rispetto del territorio e delle persone che lo abitano. Anche perché - come ricordava Antonio Cederna - l'espressione «controllo del territorio» non può essere usata e abusata solo in riferimento alla lotta contro la criminalità47. È evidente che negli ultimi quarant'anni il territorio ha pagato un altro prezzo sull'altare dello sviluppo, ovvero la perdita della bellezza, che non è questione solamente di estetica ma di qualità della vita. Non vi è dubbio che un geografo sappia leggere le mutazioni della contemporaneità molto meglio di un sociologo o di uno storico. Studiando la «megalopoli padana» non come un territorio ma come un organismo vivo, Eugenio Turri ce ne ha dato una prova straordinaria. Il quadro d'insieme che ne viene fuori è, agli occhi del lettore, semplicemente sconfortante: l'assalto edilizio e urbanistico non ha solo compromesso immediabilmente l'ambiente tanto della pianura che della montagna, ma ha modificato le dinamiche di antropizzazione del territorio fino a stravolgere le forme d'interazione sociale48. L'unico rimedio, come suggeriscono altri due coraggiosi geografi, Francesco Vallerani e Mauro Varotto, al termine di un loro singolare e inquietante viaggio proprio attraverso il paesaggio della regione del Vajont - il Veneto contemporaneo tutto villette e capannoni, della campagna urbanizzata e degli orizzonti di cemento - sarebbe forse quello d'individuare delle strategie di sopravvivenza alla modernità49.
1 Rolf Petri, Dalla ricostruzione al miracolo economico, in Storia d'Italia, 5, La Repubblica. 1943-1963, a cura di Giovanni Sabbatucci e Vittorio Vidotto, Laterza, Roma-Bari 2004 (1995), p. 433. Per un quadro generale sulle dinamiche economiche, sociali e culturali di quel periodo, cfr. Guido Crainz, Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni cinquanta e sessanta, Donzelli, Roma 2005 (1996), pp. 87-162. |