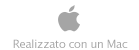| 
|
�V�a�j�o�n�t�,� �u�n�a� �t�r�a�g�e�d�i�a� �c�h�e�
�r�a�c�c�o�n�t�a� �l'I�t�a�l�i�a� (frammento "Vajont" proveniente da: �N�o�v�e�c�e�n�t�o�, �d�o�m�enica � �9� �o�t�t�obre
20�0�5 )
�
�A�l�l'o�r�i�g�i�n�e�
�d�e�l� �d�i�s�a�s�t�r�o� �s�t�a� �i�l� �f�a�t�t�o� c�h�e� �n�o�n� �s�i�
�e�f�f�e�t�t�u�a�r�o�n�o� �i� �n�e�c�e�s�s�a�r�i� �s�t�u�d�i�
s�u�l�l�a�
�s�o�l�i�d�i�t�à� �d�e�l�l�a� �s�p�o�n�d�a� �s�i�n�i�s�t�r�a� �d�e�l�
�b�a�c�i�n�o.�d�i� ��O�d�o�a�r�d�o� �A�s�c�a�r�i� -- �T�r�a�t�t�o�
�d�a� � ��d�e�l� �7� �s�e�t�t�e�m�b�r�e�
�2�0�0�5� ��d�e�l� �7� �s�e�t�t�e�m�b�r�e�
�2�0�0�5� �D�a� �o�g�g�i �(�n�.�4�
�l�u�g�l�i�o�-�a�g�o�s�t�o� �2�0�0�5� �N.�d�i �M.�) è i�n� �e�d�i�c�o�l�a� �N�u�o�v�a� �s�t�o�r�i�a�
�c�o�n�t�e�m�p�o�r�a�n�e�a
Q�u�i� �p�u�b�b�l�i�c�h�i�a�m�o� �i�l�
�s�a�g�g�i�o� �d�i� �O�d�o�a�r�d�o� �A�s�c�a�r�i� �c�h�e è s�t�a�t�o�
�a�v�v�o�c�a�t�o� �d�i� �p�a�r�t�e� �c�i�v�i�l�e� �i�n� �g�r�a�n�d�i� �p�r�o�c�e�s�s�i�:�
«�T�r�i�a�n�g�o�l�o� �d�e�l�l�a� �m�o�r�t�e»,� «�P�i�a�z�z�a�
�F�o�n�t�a�n�a»,� «�D�e�l�i�t�t�o� �M�o�r�o»,� «�A�c�h�i�l�l�e�
�L�a�u�r�o» �e� �m�a�x�i� �p�r�o�c�e�s�s�o� �c�o�n�t�r�o� �l�a�
�m�a�f�i�a
�S�i� �t�r�a�t�t�ò� �d�i� �u�n� �d�i�s�a�s�t�r�o� �u�m�a�n�o�,�
�g�i�u�r�i�d�i�c�o�,� �p�o�l�i�t�i�c�o�,� �c�h�e� �d�e�t�t�e� �o�r�i�g�i�n�e� �a�l�l�a�
�v�i�c�e�n�d�a� �p�r�o�c�e�s�s�u�a�l�e� �c�u�i� �m�i� �s�o�n�o� �d�e�d�i�c�a�t�o�
�i�n�t�e�r�a�m�e�n�t�e� �p�e�r� �a�n�n�i�,� �e� �c�h�e�,� �più� �d�i� �o�g�n�i�
�a�l�t�r�a�,� �h�a� �a�l�i�m�e�n�t�a�t�o� �i�l� �m�i�o� �p�e�r�d�u�r�a�n�t�e�
�p�e�s�s�i�m�i�s�m�o� �s�u�l�l�a� �r�e�a�l�t�à� �i�t�a�l�i�a�n�a�.�
�I�n�d�u�c�e�n�d�o�m�i� �a� �c�o�n�c�o�r�d�a�r�e� �c�o�n� �l�a�
�c�o�n�s�t�a�t�a�z�i�o�n�e� �d�i� �G�o�b�e�t�t�i�,� �i�l� �q�u�a�l�e� �s�c�r�i�v�e�v�a�
�c�h�e� �i�l� �n�o�s�t�r�o� �v�e�r�o� �d�r�a�m�m�a� �c�o�n�s�i�s�t�e� �n�e�l� �f�a�t�t�o�
�c�h�e� �n�o�n� �s�a�p�p�i�a�m�o� �e�s�s�e�r�e� �u�n� �g�r�a�n�d�e� �p�o�p�o�l�o� �e�
�n�o�n� �p�o�s�s�i�a�m�o� �e�s�s�e�r�e� �u�n� �p�i�c�c�o�l�o� �p�o�p�o�l�o�.�
�Q�u�e�l�l�a� �d�e�l� �V�a�j�o�n�t è i�n�f�a�t�t�i� �u�n�a� �s�t�o�r�i�a� �c�h�e�
�r�i�g�u�a�r�d�a� �t�u�t�t�a� �l'I�t�a�l�i�a�,� �e� �p�a�r�l�a� �a� �v�o�l�u�m�i�
�s�u�l�l�a� �r�e�a�l�t�à� �i�t�a�l�i�a�n�a.
�
�P�r�e�v�i�s�i�o�n�i� �e� �f�a�t�t�i���
�I� �f�a�t�t�i� �p�o�s�s�o�n�o� �e�s�s�e�r�e� �c�o�sì� �r�i�a�s�s�u�n�t�i�.� �L�a�
�s�e�r�a� �d�e�l� 9� �o�t�t�o�b�r�e�
�1�9�6�3�,� �a�l�l�e� �o�r�e� �1�0�.�3�9� �c�i�r�c�a�,� �u�n�a� �f�r�a�n�a�
�d�e�l�l'o�r�d�i�n�e� �d�i� �2�5�0� �m�i�l�i�o�n�i� �d�i� �m�e�t�r�i� �c�u�b�i� �d�i�
�r�o�c�c�i�a�,� �d�a� �a�n�n�i� �i�n� �m�o�v�i�m�e�n�t�o� �s�u� �u�n� �p�i�a�n�o� �d�i�
�s�c�o�r�r�i�m�e�n�t�o� �s�u�b�-�v�e�r�t�i�c�a�l�e� �n�e�l�l�a� �p�r�i�m�a� �p�a�r�t�e�,�
�e� �i�n�c�l�i�n�a�t�o� �v�e�r�s�o� �i�l� �b�a�s�s�o� �n�e�l�l�a� �s�e�c�o�n�d�a�
�p�a�r�t�e�,� �s�i� �s�t�a�c�c�a�v�a� �d�a�l� �m�o�n�t�e� �T�o�c� �s�u�l�l�a�
�s�i�n�i�s�t�r�a� �d�e�l� �t�o�r�r�e�n�t�e� �V�a�j�o�n�t�,� �i�n�
�c�o�r�r�i�s�p�o�n�d�e�n�z�a� �d�e�l� �b�a�c�i�n�o� �i�d�r�o�e�l�e�t�t�r�i�c�o�
�f�o�r�m�a�t�o� �d�a�l�l�o� �s�b�a�r�r�a�m�e�n�t�o� �c�o�s�t�i�t�u�i�t�o� �d�a�l�l�a�
�f�a�m�o�s�a� �d�i�g�a�,� �l�a� �più� �a�l�t�a� �a� �d�o�p�p�i�a�
�c�u�r�v�a�t�u�r�a� �d�e�l� �m�o�n�d�o�.� �L�a� �f�r�a�n�a� �e�r�a� �p�e�r�
�m�e�t�à� �c�i�r�c�a� �i�m�m�e�r�s�a� �n�e�l�l'a�c�q�u�a�,� �c�h�e� �s�i�
�t�r�o�v�a�v�a�,� �q�u�e�l�l�a� �s�e�r�a� �e� �a� �q�u�e�l�l'o�r�a�,� �a� �q�u�o�t�a�
�7�0�0�,�4�2�.� �I�l� �p�i�a�n�o� �d�i� �s�c�o�r�r�i�m�e�n�t�o�,� �m�a�i�
�i�d�e�n�t�i�f�i�c�a�t�o� �c�o�n� �e�s�a�t�t�e�z�z�a�,� �a�r�r�i�v�a�v�a� �s�u�l�l�a�
�f�o�r�r�a� �d�e�l� �V�a�j�o�n�t� �a� �u�n�a� �q�u�o�t�a� �v�a�r�i�a�n�t�e� �t�r�a� �i�
�5�8�0� �e� �i� �6�3�0� �m�e�t�r�i�.� �I�l� �m�o�s�t�r�o� �d�i� �r�o�c�c�i�a�
�a�t�t�r�a�v�e�r�s�ò� �r�a�p�i�d�a�m�e�n�t�e� �i�l� �b�a�c�i�n�o�
�i�d�r�o�e�l�e�t�t�r�i�c�o� �i�n� �s�e�n�s�o� �t�r�a�s�v�e�r�s�a�l�e�
�s�c�h�i�a�c�c�i�a�n�d�o� �c�o�n�t�r�o� �l�a� �s�p�o�n�d�a� �d�e�s�t�r�a�,� �c�o�m�e�
�u�n� �e�n�o�r�m�e� �p�i�s�t�o�n�e�,� �t�u�t�t�a� �l'a�c�q�u�a� �a�n�t�i�s�t�a�n�t�e�
�i�l� �f�r�o�n�t�e� �d�i� �f�r�a�n�a - �c�i�r�c�a� �5�0� �m�i�l�i�o�n�i� �d�i� �m�e�t�r�i�
�c�u�b�i - �c�u�i� �v�e�n�i�v�a� �i�m�p�r�e�s�s�a� �u�n'e�n�o�r�m�e� �f�o�r�z�a�
�a�s�c�e�n�s�i�o�n�a�l�e�.�
�L�a� �m�a�s�s�a� �d'a�c�q�u�a� �d�a�p�p�r�i�m�a�
�c�a�g�i�o�n�ò� �l�a� �d�i�s�t�r�u�z�i�o�n�e� �d�i� �E�r�t�o� �C�a�s�s�o�,� �c�h�e�
�s�o�v�r�a�s�t�a�v�a� �d�i� �c�i�r�c�a� �s�e�s�s�a�n�t�a� �m�e�t�r�i� �i�l�
�l�i�v�e�l�l�o� �d�e�l�l'i�n�v�a�s�o�,� �a�l�z�a�n�d�o�s�i� �p�o�i� �a� �f�u�n�g�o�,�
�s�p�i�n�t�a� �v�e�r�s�o� �l'a�l�t�o� �a� �q�u�a�s�i� �d�u�e�c�e�n�t�o� �m�e�t�r�i�
�d'a�l�t�e�z�z�a�.� �Q�u�i�n�d�i� �r�i�c�a�d�d�e� �i�n� �p�a�r�t�e� �s�u�l� �b�a�c�i�n�o�
�a� �m�o�n�t�e�,� �d�o�v�e� �n�o�n� �p�o�t�e�v�a� �f�a�r�e� �c�h�e� �v�i�t�t�i�m�e�
�o�c�c�a�s�i�o�n�a�l�i�,� �m�e�n�t�r�e� �a� �v�a�l�l�e� �s�c�a�v�a�l�c�ò� �l�a�
�d�i�g�a� �p�e�r� �o�l�t�r�e� �c�e�n�t�o� �m�e�t�r�i� �e� �s�i� �a�b�b�a�t�t�é�
�c�o�m�e� �u�n� �m�a�g�l�i�o� �g�i�g�a�n�t�e�s�c�o� �s�u� �L�o�n�g�a�r�o�n�e�,�
�a�l�l'a�l�t�e�z�z�a� �d�e�l�l�a� �c�o�n�f�l�u�e�n�z�a� �d�e�l� �V�a�j�o�n�t� �n�e�l�
�P�i�a�v�e�.� �L�a� �d�i�g�a�,� �c�o�m�e� �r�i�p�e�t�i�a�m�o�,� �f�u�
�s�c�a�v�a�l�c�a�t�a� �e� �f�u� �p�e�r� �q�u�e�s�t�o� �c�h�e� �n�o�n�
�c�r�o�l�l�ò�:� �s�e� �f�o�s�s�e� �s�t�a�t�a� �i�n�v�e�s�t�i�t�a�
�d�i�r�e�t�t�a�m�e�n�t�e�,� �s�a�r�e�b�b�e� �s�t�a�t�a� �l�e�t�t�e�r�a�l�m�e�n�t�e�
�t�r�a�v�o�l�t�a�,� �e�s�s�e�n�d�o� �l'e�n�e�r�g�i�a� �s�c�a�t�e�n�a�t�a� �p�a�r�i� �a�
�q�u�a�s�i� �d�u�e� �v�o�l�t�e� �q�u�e�l�l�a� �d�e�l�l�a� �b�o�m�b�a� �d�i�
�H�i�r�o�s�h�i�m�a�;� �e� �l�e� �v�i�t�t�i�m�e� �s�a�r�e�b�b�e�r�o� �s�t�a�t�e�
�d�e�c�i�n�e� �d�i� �m�i�g�l�i�a�i�a�,� �p�e�r�c�h�é� �l'o�n�d�a�t�a�
�a�v�r�e�b�b�e� �t�r�a�v�o�l�t�o� �t�u�t�t�o� �e� �t�u�t�t�i� �s�i�n�o� �a�
�B�e�l�l�u�n�o�.� �L'o�n�d�a� �l�i�q�u�i�d�a�,� �c�h�e�,� �c�a�d�e�n�d�o�,�
�a�b�b�a�s�s�ò� �p�e�r�s�i�n�o� �i�l� �l�i�v�e�l�l�o� �d�e�l� �s�u�o�l�o�,� �s�i�
�e�s�t�e�s�e� �a� �v�a�l�l�e� �e� �a� �m�o�n�t�e� �l�u�n�g�o� �i�l� �P�i�a�v�e� �s�i�n�o�
�a� �P�o�n�t�e� �n�e�l�l�e� �A�l�p�i� �e� �a� �C�a�s�t�e�l�l�a�v�a�z�z�o�.� �1�9�9�4�
�f�u�r�o�n�o� �i� �m�o�r�t�i�,� �i�m�m�e�n�s�e� �l�e� �r�o�v�i�n�e�:� �d�a�l� �1�9�4�5�
�i�n� �p�o�i,� �l�a� �n�o�t�t�e� �più� �c�a�l�d�a� �d�i� �l�a�c�r�i�m�e� �e� �d�i�
�l�u�t�t�i�.�
�P�e�r�c�h�é� �i�l� �l�e�t�t�o�r�e� �p�o�s�s�a�
�c�o�m�p�r�e�n�d�e�r�e� �i�n� �t�u�t�t�a� �l�a� �s�u�a� �e�s�t�e�n�s�i�o�n�e� �l�a�
�g�r�a�v�i�t�à� �d�r�a�m�m�a�t�i�c�a� �d�e�i� �f�a�t�t�i�,� �o�c�c�o�r�r�e�
�p�r�e�m�e�t�t�e�r�e� �c�h�e� �l�a� �c�o�s�t�r�u�z�i�o�n�e� �d�e�l�l�a� �d�i�g�a�,�
�v�a�n�t�o� �d�e�l�l'I�t�a�l�i�a�,� �e�r�a� �i�n�i�z�i�a�t�a�,� �m�i� �p�a�r�e�,� �n�e�l�
�1�9�5�7� �e�d� �e�r�a� �s�t�a�t�a� �u�l�t�i�m�a�t�a� �n�e�l�l'a�g�o�s�t�o� �d�e�l�
�1�9�6�0�.� �N�e� �e�r�a� �p�r�o�p�r�i�e�t�a�r�i�a� �l�a� �S�a�d�e -
�S�o�c�i�e�t�à� �A�d�r�i�a�t�i�c�a� �d�i� �E�l�e�t�t�r�i�c�i�t�à - �c�h�e�
�f�a�c�e�v�a� �c�a�p�o� �a� �u�n� �g�r�a�n�d�e� �p�o�t�e�n�t�a�t�o� �e�c�o�n�o�m�i�c�o�.�
�L'e�n�o�r�m�e� �q�u�a�n�t�i�t�a�t�i�v�o� �d�i� �a�c�q�u�a� �c�o�n�t�e�n�u�t�o� �n�e�l�
�b�a�c�i�n�o - �o�l�t�r�e� �c�e�n�t�o� �m�i�l�i�o�n�i� �d�i� �m�e�t�r�i� �c�u�b�i -
�a�v�r�e�b�b�e� �g�a�r�a�n�t�i�t�o� �u�n�a� �r�i�s�e�r�v�a� �d�i� �e�n�e�r�g�i�a�
�p�r�a�t�i�c�a�m�e�n�t�e� �i�n�f�i�n�i�t�a�.� �M�a�,� �p�r�i�m�a� �c�h�e�
�e�n�t�r�a�s�s�e� �i�n� �f�u�n�z�i�o�n�e�,� �l�a� �C�o�m�m�i�s�s�i�o�n�e�
�i�s�t�i�t�u�i�t�a� �p�r�e�s�s�o� �i�l� �m�i�n�i�s�t�e�r�o� �d�e�i� �L�a�v�o�r�i�
�p�u�b�b�l�i�c�i� �a�v�e�v�a� �d�i�s�p�o�s�t�o� �c�h�e� �i�l� �c�o�l�l�a�u�d�o�
�a�v�v�e�n�i�s�s�e� �i�n� �t�r�e� �f�a�s�i�.� �I�n� �u�n�a� �p�r�i�m�a� �f�a�s�e�,�
�o�v�v�i�a�m�e�n�t�e� �a� �d�i�g�a� �f�i�n�i�t�a�,� �s�i� �s�a�r�e�b�b�e�
�a�u�t�o�r�i�z�z�a�t�o� �l'i�n�v�a�s�o� �d�e�l� �s�e�r�b�a�t�o�i�o� �s�i�n�o� �a� �u�n�a�
�q�u�o�t�a� �d�i� �6�8�0� �m�e�t�r�i�,� �s�e�g�u�i�t�o� �d�a� �u�n� �s�u�c�c�e�s�s�i�v�o�
�s�v�a�s�o�;� �l�a� �s�e�c�o�n�d�a� �v�o�l�t�a� �s�i�n�o� �a� �q�u�o�t�a� �7�0�0�,� �e�
�r�e�l�a�t�i�v�o� �s�v�a�s�o�;� �l�a� �t�e�r�z�a� �v�o�l�t�a� �a� �q�u�o�t�a� �7�1�5�,�
�t�r�a�g�u�a�r�d�o� �f�i�n�a�l�e�,� �c�o�n� �s�u�c�c�e�s�s�i�v�o� �s�v�a�s�o�. �
�Q�u�a�n�d�o� �i�l� �b�a�c�i�n�o� �a�v�e�s�s�e� �s�u�p�e�r�a�t�o� �q�u�e�s�t�e� �t�r�e�
�p�r�o�v�e� �s�e�n�z�a� �i�n�c�i�d�e�n�t�i� �s�a�r�e�b�b�e� �p�o�t�u�t�o�
�d�i�v�e�n�t�a�r�e� �f�u�n�z�i�o�n�a�n�t�e�.� �M�a�,� �q�u�a�n�d�o�,� �n�e�l� �1�9�6�0�,�
�e�r�a� �i�n� �c�o�r�s�o� �i�l� �p�r�i�m�o� �s�v�a�s�o� �d�a� �q�u�o�t�a� �6�8�0�,� �l�a�
�m�o�n�t�a�g�n�a� �s�i� �m�i�s�e� �a� �c�o�r�r�e�r�e�:� �e� �c�i�ò�
�p�e�r�c�h�é� �a�l� �p�e�s�o� �d�e�l�l�a� �r�o�c�c�i�a� �s�i�
�a�g�g�i�u�n�g�e�v�a�,� �a�u�m�e�n�t�a�n�d�o� �n�o�t�e�v�o�l�m�e�n�t�e� �l�a�
�s�p�i�n�t�a� �v�e�r�s�o� �i�l� �b�a�s�s�o�,� �q�u�e�l�l�o� �d�e�l�l�a� �m�a�s�s�a�
�d'a�c�q�u�a� �c�h�e� �l�a� �m�o�n�t�a�g�n�a� �a�v�e�v�a� �a�s�s�o�r�b�i�t�o�.�
�A�p�p�u�n�t�o� �q�u�e�s�t�a� �e�r�a� �l�a� �r�a�g�i�o�n�e� �p�e�r� �l�a� �q�u�a�l�e�
�l�o� �s�v�a�s�o� �s�a�r�e�b�b�e� �d�o�v�u�t�o� �e�s�s�e�r�e� �l�e�n�t�i�s�s�i�m�o�:�
�m�a� �n�e�m�m�e�n�o� �t�a�l�e� �p�r�e�c�a�u�z�i�o�n�e� �f�u� �o�s�s�e�r�v�a�t�a.
�A�l�l'o�r�i�g�i�n�e� �d�i� �t�u�t�t�o� �i�l� �d�r�a�m�m�a� �s�t�a� �i�l� �f�a�t�t�o�
�c�h�e� �n�o�n� �s�i� �e�r�a�n�o� �e�f�f�e�t�t�u�a�t�i� �i� �d�o�v�u�t�i� �e�
�n�e�c�e�s�s�a�r�i� �s�t�u�d�i� �s�u�l�l�a� �s�o�l�i�d�i�t�à� �d�e�l�l�a�
�s�p�o�n�d�a� �s�i�n�i�s�t�r�a� �d�e�l� �b�a�c�i�n�o�.� �S�i� �s�a�r�e�b�b�e� �i�n�
�t�a�l� �c�a�s�o� �c�o�n�s�t�a�t�a�t�o� �c�h�e� �l'e�n�o�r�m�e� �m�a�s�s�a� �d�e�l�l�a�
�f�r�a�n�a� �p�o�g�g�i�a�v�a� �s�u� �u�n� �s�e�t�t�o� �r�o�c�c�i�o�s�o� �c�h�e� �s�i�
�e�r�a� �v�e�n�u�t�o� �i�n�c�l�i�n�a�n�d�o� �e� �f�r�a�n�t�u�m�a�n�d�o�:�
«�m�i�l�o�n�i�t�i�z�z�a�n�d�o»,� �c�o�m�e� �a�v�r�e�b�b�e�r�o� �d�e�t�t�o� �i�
�t�e�c�n�i�c�i�.� E� �f�u� �c�o�sì� �c�h�e� �i�l� �4� �n�o�v�e�m�b�r�e�
�1�9�6�0 - �t�r�e� �a�n�n�i� �c�i�r�c�a� �p�r�i�m�a� �d�e�l� �d�i�s�a�s�t�r�o - �s�i�
�e�r�a� �v�e�r�i�f�i�c�a�t�a�,� �a�p�p�u�n�t�o�,� �n�e�l� �c�o�r�s�o� �d�e�l� �p�r�i�m�o�
�s�v�a�s�o�,� �l�a� �f�r�a�n�a�,� �p�e�r� �c�o�sì� �d�i�r�e�,�
�p�r�o�d�r�o�m�i�c�a�.� �S�i� �e�r�a� �s�t�a�c�c�a�t�a� �d�a�l�l�a� �m�o�n�t�a�g�n�a�
�u�n�a� �m�a�s�s�a� �r�e�l�a�t�i�v�a�m�e�n�t�e� �m�o�d�e�s�t�a� �d�i� �c�i�r�c�a� �u�n�
�m�i�l�i�o�n�e� �d�i� �m�e�t�r�i� �c�u�b�i� �d�i� �r�o�c�c�i�a�,� �s�i�c�c�h�é�
�s�i� �e�r�a� �d�i�s�e�g�n�a�t�a� �s�u�l�l�a� �s�p�o�n�d�a� �s�i�n�i�s�t�r�a� �d�e�l�l�a�
�m�o�n�t�a�g�n�a�,� �d�a�v�a�n�t�i� �a�l�l�a� �q�u�a�l�e� �s�c�o�r�r�e�v�a� �i�l�
�V�a�j�o�n�t�,� �u�n�a� �f�e�n�d�i�t�u�r�a� �a� �M - �i�n�i�z�i�a�l�e� �d�e�l�l�a�
�p�a�r�o�l�a� �m�o�r�t�e - �l�u�n�g�a� �c�i�r�c�a� �2�5�0�0� �m�e�t�r�i�.� �L�a�
�S�a�d�e�,� �o�v�v�i�a�m�e�n�t�e� �m�o�l�t�o� �a�l�l�a�r�m�a�t�a�,� �d�e�t�t�e�
�i�n�c�a�r�i�c�o� �a� �u�n� �v�a�l�i�d�i�s�s�i�m�o� �p�r�o�f�e�s�s�o�r�e�
�a�u�s�t�r�i�a�c�o� �d�i� �g�e�o�m�e�c�c�a�n�i�c�a�,� �L�e�o�p�o�l�d�o�
�M�ü�l�l�e�r�,� �d�i� �f�a�r� �c�o�n�o�s�c�e�r�e� �l�e� �s�u�e�
�v�a�l�u�t�a�z�i�o�n�i� �s�u� �q�u�a�n�t�o� �e�r�a� �a�c�c�a�d�u�t�o� �e�,� �i�n�
�p�a�r�t�i�c�o�l�a�r�e�,� �s�u�l� �s�i�g�n�i�f�i�c�a�t�o� �d�i� �q�u�e�l�l�a�
�g�i�g�a�n�t�e�s�c�a� �M�.�
�L�o� �s�c�i�e�n�z�i�a�t�o� �a�m�i�c�o�
�c�o�n�s�t�a�t�ò� �a�n�z�i�t�u�t�t�o� �l�a� �f�r�a�n�t�u�m�a�z�i�o�n�e� �d�e�l�
�s�e�t�t�o� �r�o�c�c�i�o�s�o� �s�u� �c�u�i� �p�o�g�g�i�a�v�a� �l�a� �f�r�a�n�a�,�
�a�u�m�e�n�t�a�n�d�o� �c�o�sì� �i�n�e�s�o�r�a�b�i�l�m�e�n�t�e� �i�l�
�p�e�r�i�c�o�l�o� �d�i� �c�a�d�u�t�a�.� �E� �a� �q�u�e�s�t�a� �c�o�n�c�l�u�s�i�o�n�e�
�i�n�o�p�p�u�g�n�a�b�i�l�e� �e�r�a� �g�i�u�n�t�o� �f�a�c�e�n�d�o� �e�s�p�l�o�d�e�r�e� �a�
�n�o�v�e�m�b�r�e�,� �i�n� �o�c�c�a�s�i�o�n�e� �d�e�l� �s�u�o� �p�r�i�m�o�
�a�c�c�e�s�s�o�,� �a�p�p�u�n�t�o�,� �a�l� �s�e�t�t�o� �r�o�c�c�i�o�s�o�,� �u�n�a�
�p�i�c�c�o�l�a� �m�i�n�a�,� �c�a�l�c�o�l�a�n�d�o� �p�o�i� �i�l� �t�e�m�p�o� �d�i�
�t�r�a�s�l�a�z�i�o�n�e�,� �p�e�r� �c�o�sì� �d�i�r�e�,� �d�e�l� �s�u�o�n�o�
�a�l�l�a� �d�i�s�t�a�n�z�a� �d�i� �c�i�r�c�a� �2�0�0� �m�e�t�r�i�.� �A�v�e�v�a� �p�o�i�
�r�i�p�e�t�u�t�o� �l'e�s�p�e�r�i�m�e�n�t�o� �n�e�g�l�i� �s�t�e�s�s�i� �l�u�o�g�h�i� �e�
�c�o�n� �l�e� �s�t�e�s�s�e� �d�i�s�t�a�n�z�e� �d�u�e� �m�e�s�i� �d�o�p�o�,�
�c�o�n�s�t�a�t�a�n�d�o� �c�h�e� �q�u�e�l�l�a� �v�e�l�o�c�i�t�à� �e�r�a�
�c�o�n�s�i�d�e�r�e�v�o�l�m�e�n�t�e� �a�u�m�e�n�t�a�t�a�;� �i�l� �c�h�e�
�d�i�m�o�s�t�r�a�v�a� �c�h�e� �i�l� �s�e�t�t�o� �r�o�c�c�i�o�s�o� �s�u� �c�u�i�
�p�o�g�g�i�a�v�a� �l�a� �f�r�a�n�a� �s�i� �s�t�a�v�a�
«�m�i�l�o�n�i�t�i�z�z�a�n�d�o».� �M�a�t�u�r�ò� �c�o�sì�
�i�l� �s�u�o� �f�a�m�o�s�o� �q�u�i�n�d�i�c�e�s�i�m�o� �r�a�p�p�o�r�t�o�,�
�c�o�n�s�e�g�n�a�t�o� �a�l�l�a� �S�a�d�e� �n�e�l� �f�e�b�b�r�a�i�o� �d�e�l� �1�9�6�1�,�
�n�e�l� �q�u�a�l�e� �M�ü�l�l�e�r� �s�c�r�i�v�e�v�a�:�
«�L�a� �m�a�s�s�a� �d�i� �f�r�a�n�a� �o�c�c�i�d�e�n�t�a�l�e� �(�l�a� �v�e�r�a�
�z�o�n�a� �T�o�c�)� �[�....�]� �s�e�n�z�a� �d�u�b�b�i�o� �s�i� �m�u�o�v�e� �c�o�m�e�
�c�o�r�p�o� �u�n�i�c�o�;� �n�o�n� �s�o�n�o� �r�i�c�o�n�o�s�c�i�b�i�l�i� �z�o�n�e�
�p�a�r�z�i�a�l�i� �e� �m�o�v�i�m�e�n�t�i� �r�e�l�a�t�i�v�i� �t�r�a�
�e�s�s�e�»�.�
�E�d� �e�c�c�o� �a�l�c�u�n�i� �p�a�s�s�i� �l�e�t�t�e�r�a�l�m�e�n�t�e� �d�r�a�m�m�a�t�i�c�i�: «�I�o� �c�o�m�u�n�q�u�e� �s�u�p�p�o�n�g�o� �c�h�e� �l�e� �m�a�s�s�e� �f�o�s�s�e�r�o� �i�n� �m�o�v�i�m�e�n�t�o� �d�a� �s�e�m�p�r�e� �e�,� �i�n� �o�g�n�i� �c�a�s�o�,� �c�h�e� �i�n� �p�e�r�i�o�d�i� �d�i� �f�o�r�t�i� �p�r�e�c�i�p�i�t�a�z�i�o�n�i� �f�o�s�s�e�r�o� �s�e�m�p�r�e� �s�o�g�g�e�t�t�e� �a�
�p�i�c�c�o�l�i� �s�p�o�s�t�a�m�e�n�t�i�.� �C�o�m�u�n�q�u�e� �e�s�s�e� �h�a�n�n�o� �i�
�s�e�g�n�i� �c�a�r�a�t�t�e�r�i�s�t�i�c�i� �d�i� �u�n'a�l�t�a�
�i�n�s�t�a�b�i�l�i�t�à�.� �P�r�i�m�a� �d�e�l�l'e�s�i�s�t�e�n�z�a� �d�e�l�
�s�e�r�b�a�t�o�i�o� �q�u�e�s�t�i� �m�o�v�i�m�e�n�t�i� �s�a�r�a�n�n�o� �s�t�a�t�i� �d�i�
�q�u�a�l�c�h�e� �c�e�n�t�i�m�e�t�r�o� �a�l�l'a�n�n�o�,� �m�e�n�t�r�e� �c�o�n� �l�o�
�s�b�a�r�r�a�m�e�n�t�o� �s�o�n�o� �a�u�m�e�n�t�a�t�i� �a� �m�o�l�t�i�
�d�e�c�i�m�e�t�r�i�.� �D�i� �c�o�n�s�e�g�u�e�n�z�a�,� �a�l� �s�e�r�b�a�t�o�i�o è
d�a� �a�t�t�r�i�b�u�i�r�e� �u�n� �e�f�f�e�t�t�o� �d�i� �a�c�c�e�l�e�r�a�z�i�o�n�e� �e�
�d�i� �a�u�m�e�n�t�o�.� �[�....�]� �L�e� �p�i�e�g�h�e� �d�e�l�l�a� �z�o�n�a�
�s�u�p�e�r�i�o�r�e�,� �a�v�e�n�t�i� �g�l�i� �a�s�s�i� �i�n�c�l�i�n�a�t�i� �v�e�r�s�o�
�n�o�r�d�,� �e�s�c�l�u�d�o�n�o� �l�a� �p�o�s�s�i�b�i�l�i�t�à� �d�i� �u�n�
�m�o�v�i�m�e�n�t�o� �d�e�l� �t�i�p�o� �g�h�i�a�c�c�i�a�i�o�,� �m�a�
�f�a�v�o�r�i�s�c�o�n�o� �l�o� �s�c�o�r�r�i�m�e�n�t�o� «�e�n�
�b�l�o�c»»�.� �C�o�n�c�l�u�s�i�o�n�e�:�
«�L�e� �m�a�s�s�e� �r�o�c�c�i�o�s�e� �s�i� �m�u�o�v�o�n�o� �v�e�r�s�o� �v�a�l�l�e�
�s�u� �u�n�a� �l�a�r�g�h�e�z�z�a� �d�i� �1�7�0�0� �m�e�t�r�i�.� �L�a� �l�u�n�g�h�e�z�z�a�
�m�e�d�i�a� �d�e�l�l�e� �m�a�s�s�e� �d�i� �s�c�o�r�r�i�m�e�n�t�o è d�i� �5�0�0� �o�
�a�l� �m�a�s�s�i�m�o� �6�0�0� �m�e�t�r�i� �n�e�l�l�a� �d�i�r�e�z�i�o�n�e� �d�i�
�m�o�v�i�m�e�n�t�o�,� �m�i�s�u�r�a�t�a� �f�r�o�n�t�a�l�m�e�n�t�e�.� �I�l� �s�u�o�
�s�p�e�s�s�o�r�e�,� �n�e�l�l�a� �m�e�t�à� �i�n�f�e�r�i�o�r�e�, è d�i�
�2�5�0� �m�e�t�r�i�.� �A� �m�i�o� �p�a�r�e�r�e� �n�o�n� �p�o�s�s�o�n�o�
�s�u�s�s�i�s�t�e�r�e� �d�u�b�b�i� �s�u� �q�u�e�s�t�a� �p�r�o�f�o�n�d�a�
�g�i�a�c�i�t�u�r�a� �d�e�l� �p�i�a�n�o� �d�i� �s�l�i�t�t�a�m�e�n�t�o� �d�e�l�l�a�
�q�u�a�l�e� �i�l� �v�o�l�u�m�e�,� �c�o�m�e� �s�a�p�p�i�a�m�o�, è d�i� �2�0�0�
�m�i�l�i�o�n�i� �d�i� �m�e�t�r�i� �c�u�b�i�.�
A�l�l�a� �d�o�m�a�n�d�a� �s�e�
�q�u�e�s�t�i� �f�r�a�n�a�m�e�n�t�i� �p�o�s�s�o�n�o� �v�e�n�i�r�e� �a�r�r�e�s�t�a�t�i�
�m�e�d�i�a�n�t�e� �m�i�s�u�r�e� �a�r�t�i�f�i�c�i�a�l�i�,� �d�e�v�e� �e�s�s�e�r�e�
�r�i�s�p�o�s�t�o� �n�e�g�a�t�i�v�a�m�e�n�t�e� �i�n� �l�i�n�e�a� �g�e�n�e�r�a�l�e�;�
�a�n�c�h�e� �s�e� �i�n� �l�i�n�e�a� �t�e�o�r�i�c�a�,� �s�i� �d�o�v�e�s�s�e�
�r�i�n�u�n�c�i�a�r�e� �a�l�l'e�s�e�r�c�i�z�i�o� �d�e�l� �s�e�r�b�a�t�o�i�o�,� �u�n�a�
�f�r�a�n�a� �t�a�l�m�e�n�t�e� �g�r�a�n�d�e�,� �d�o�p�o� �e�s�s�e�r�s�i� �m�o�s�s�a�
�u�n�a� �v�o�l�t�a�,� �n�o�n� �t�o�r�n�e�r�e�b�b�e� �t�a�n�t�o� �p�r�e�s�t�o�
�a�l�l'a�r�r�e�s�t�o� �a�s�s�o�l�u�t�o�»�.� �L�a�
�p�r�e�v�i�s�i�o�n�e�,� �f�o�r�m�u�l�a�t�a� �t�r�e� �a�n�n�i� �p�r�i�m�a� �d�e�l�
�t�r�a�g�i�c�o� �e�v�e�n�t�o� �d�e�l� �9� �o�t�t�o�b�r�e� �1�9�6�3�,� �e�r�a�
�d�r�a�m�m�a�t�i�c�a�m�e�n�t�e� �f�o�n�d�a�t�a�,� �a�n�c�h�e� �t�e�n�e�n�d�o�
�p�r�e�s�e�n�t�e� �c�h�e� �M�ü�l�l�e�r� �v�e�n�i�v�a� �p�a�g�a�t�o� �d�a�l�l�a�
�S�a�d�e� �e� �n�o�n� �a�v�e�v�a� �c�e�r�t�o� �i�n�t�e�r�e�s�s�e� �a� �d�a�r�e�
�g�i�u�d�i�z�i� �t�r�o�p�p�o� �p�e�s�s�i�m�i�s�t�i�c�i� �e� �a� �s�c�o�r�a�g�g�i�a�r�e�
�i�l� �p�r�o�p�r�i�o� �c�o�m�m�i�t�t�e�n�t�e�:� �m�a� �i� �f�a�t�t�i� �e�r�a�n�o�
�q�u�e�l�l�i�.� �S�e�n�o�n�c�h�é�,� �q�u�a�n�d�o� �c�a�d�d�e� �l�a� �p�r�i�m�a�
�f�r�a�n�a� �d�e�l� �4� �n�o�v�e�m�b�r�e� �1�9�6�0 - �i�l� �p�r�i�m�o�
�d�i�s�a�s�t�r�o� �i�n� �s�e�n�s�o� �t�e�c�n�i�c�o� �e�
�g�i�u�r�i�d�i�c�o - �l�a� �d�i�g�a� �e�r�a� �g�i�à� �f�i�n�i�t�a� �e�d�
�e�r�a�n�o� �g�i�à� �s�t�a�t�i� �s�p�e�s�i� �c�i�r�c�a� �d�i�c�i�a�s�s�e�t�t�e�
�m�i�l�i�a�r�d�i� �d�i� �l�i�r�e�.� �L�a� �r�i�n�u�n�c�i�a� �a�l�l'e�s�e�r�c�i�z�i�o�
�d�e�l� �b�a�c�i�n�o�,� �c�u�i� �a�v�e�v�a� �e�s�p�l�i�c�i�t�a�m�e�n�t�e� �f�a�t�t�o�
�r�i�f�e�r�i�m�e�n�t�o� �M�ü�l�l�e�r�,� �d�i�v�e�n�t�a�v�a� �p�e�r�t�a�n�t�o�,�
�p�e�r� �c�o�sì� �d�i�r�e�,� �c�o�s�t�o�s�a�,� �p�e�r�c�h�é�
�t�o�g�l�i�e�v�a� �a�l� �b�a�c�i�n�o� �e� �a�l�l�a� �d�i�g�a� �i�l� �v�a�l�o�r�e� �d�i�
«�b�e�n�i� �e�l�e�t�t�r�i�c�i».� �E� �l�a� �l�e�g�g�e� �c�h�e� �a�v�e�v�a�
�d�i�s�p�o�s�t�o� �l�a� �n�a�z�i�o�n�a�l�i�z�z�a�z�i�o�n�e� �d�e�l�l'e�n�e�r�g�i�a�
�e�l�e�t�t�r�i�c�a� �e� �l�a� �c�r�e�a�z�i�o�n�e� �d�e�l�l'E�n�e�l� �p�r�e�v�e�d�e�v�a�
�i�l� �p�a�g�a�m�e�n�t�o�,� �d�a� �p�a�r�t�e� �d�e�l�l�o� �S�t�a�t�o�,� �d�i� �u�n�
�i�n�d�e�n�n�i�z�z�o� �i�l� �c�u�i� �a�m�m�o�n�t�a�r�e� �e�r�a� �c�o�r�r�e�l�a�t�o�
�a�l�l�e� �q�u�o�t�a�z�i�o�n�i� �i�n� �b�o�r�s�a� �d�e�l�l�a� �S�a�d�e� �n�e�g�l�i�
�u�l�t�i�m�i� �a�n�n�i� �(�n�o�n� �r�i�c�o�r�d�o� �q�u�a�n�t�i�)�.� �M�a� �i�l�
�p�a�g�a�m�e�n�t�o� �p�r�e�s�u�p�p�o�n�e�v�a� �c�h�e� �s�i� �t�r�a�t�t�a�s�s�e� �d�i�
�b�e�n�i� �e�l�e�t�t�r�i�c�i�,� �c�i�o�è �d�i� �b�e�n�i� �c�a�p�a�c�i� �d�i�
�p�r�o�d�u�r�r�e� �e�n�e�r�g�i�a�:� �t�a�l�e� �n�o�n� �e�r�a� �q�u�e�l� �b�a�c�i�n�o�,�
�s�u� �c�u�i� �i�n�c�o�m�b�e�v�a� �l�a� �p�r�e�v�i�s�i�o�n�e� �p�r�e�c�i�s�a� �d�e�l�l�a�
�c�a�d�u�t�a� «�e�n� �b�l�o�c» �d�e�l�l�a� �f�r�a�n�a� �e� �l�a�
�c�o�n�s�e�g�u�e�n�t�e� �r�i�n�u�n�c�i�a� �a�l�l'e�s�e�r�c�i�z�i�o� �d�e�l�
�b�a�c�i�n�o�,� �f�o�r�m�u�l�a�t�a� �c�o�n� �i�m�p�i�e�t�o�s�a� �p�r�e�c�i�s�i�o�n�e�
�d�a� �M�ü�l�l�e�r�.�
�N�e�s�s�u�n�o - �p�e�r� �f�a�r�e� �u�n� �e�s�e�m�p�i�o�
�b�a�n�a�l�e - �v�o�r�r�à� �m�a�i� �c�o�m�p�r�a�r�e� �u�n�a� �c�a�s�a�
�d�e�s�t�i�n�a�t�a�,� �c�o�n� �t�u�t�t�a� �p�r�o�b�a�b�i�l�i�t�à�,� �p�r�i�m�a� �o�
�p�o�i�,� �a� �c�a�d�e�r�e�.�
E� �f�u� �p�e�r� �q�u�e�s�t�o� �c�h�e� �l�a� �S�a�d�e�,�
�d�a� �u�n� �l�a�t�o�,� �n�a�s�c�o�s�e� �n�e�l� �c�a�s�s�e�t�t�o� �i�l� �r�a�p�p�o�r�t�o�
�M�ü�l�l�e�r� �(�e� �l'i�n�g�e�g�n�e�r�e� �f�u� �e�s�o�n�e�r�a�t�o� �d�a�
�o�g�n�i� �i�n�c�a�r�i�c�o� �u�f�f�i�c�i�a�l�e�)�,� �m�e�n�t�r�e�,�
�d�a�l�l'a�l�t�r�o�,� �l�a�s�c�i�ò� �c�h�e� �t�r�a�s�c�o�r�r�e�s�s�e� �c�i�r�c�a�
�u�n� �a�n�n�o�� �p�e�r� �p�o�i�,� �s�p�e�r�a�n�d�o� �n�e�l�l�a� �b�u�o�n�a� �s�o�r�t�e�
�e� �r�e�s�t�a�n�d�o� �v�i�t�t�i�m�a� �d�i� �u�n�a� �s�i�n�d�r�o�m�e� �d�i�
�r�i�m�o�z�i�o�n�e�,� �c�h�i�e�d�e�r�e� �i�l� �s�e�c�o�n�d�o� �i�n�v�a�s�o�,� �c�h�e�
�p�r�o�v�o�c�ò� �l�a� �s�o�l�i�t�a� �a�c�c�e�l�e�r�a�z�i�o�n�e� �d�i�
�m�o�v�i�m�e�n�t�i�.� �E� �c�i�ò� �p�e�r�c�h�é�,� �e� �l�a�
�c�i�r�c�o�s�t�a�n�z�a è e�s�s�e�n�z�i�a�l�e�,� �i�l� �r�a�p�p�o�r�t�o� �t�r�a�
�i�l� �p�e�s�o� �d�e�l�l�a� �m�a�s�s�a� �p�r�e�m�e�n�t�e� �e� �l�a�
�c�a�p�a�c�i�t�à� �d�i� �r�e�s�i�s�t�e�n�z�a�,� �p�e�r� �c�o�sì� �d�i�r�e�,�
�d�e�l� �s�e�t�t�o� �r�o�c�c�i�o�s�o� �s�u� �c�u�i� �p�o�g�g�i�a�v�a�,� �e�r�a�
�d�i�v�e�n�u�t�o� �q�u�a�s�i� �u�g�u�a�l�e� �a� �z�e�r�o�:� �i�l� �c�h�e�
�a�f�f�i�d�a�v�a� �m�i�g�l�i�a�i�a� �d�i� �v�i�t�e� �u�m�a�n�e�
�l�e�t�t�e�r�a�l�m�e�n�t�e� �a�l� �c�a�p�r�i�c�c�i�o� �d�e�l�
«�c�a�s�o».�
�S�i� �t�r�a�t�t�a�v�a� �d�i� �u�n� �t�r�a�g�i�c�o�
�e�q�u�i�l�i�b�r�i�o� �t�r�a� �l�a� �v�i�t�a� �e� �l�a� �m�o�r�t�e�:� �n�o�n�
�t�e�n�e�r�n�e� �c�o�n�t�o� �d�a�v�a� �c�o�r�p�o� �a� �u�n�a� �c�o�l�p�a� �d�i�
�i�n�c�r�e�d�i�b�i�l�e� �g�r�a�v�i�t�à�,� �t�e�n�e�n�d�o� �p�r�e�s�e�n�t�e�
�a�n�z�i�t�u�t�t�o� �i�l� �s�e�n�s�o� �c�o�m�u�n�e�,� �e� �l�a� �c�o�n�s�e�g�u�e�n�t�e�
�r�e�g�o�l�a� �a�n�t�i�c�a� �s�e�c�o�n�d�o� �l�a� �q�u�a�l�e� �i�l� �r�a�p�p�o�r�t�o�
�t�r�a� �m�a�s�s�a� �r�e�s�i�s�t�e�n�t�e� �e� �m�a�s�s�a� �p�r�e�m�e�n�t�e�
�a�v�r�e�b�b�e� �d�o�v�u�t�o� �e�s�s�e�r�e� �d�e�l� �2�,�7�0�%�,� �a� �f�a�v�o�r�e�,�
�o�v�v�i�a�m�e�n�t�e�,� �d�e�l�l�a� �m�a�s�s�a� �r�e�s�i�s�t�e�n�t�e�.
�M�a� �p�o�i�c�h�é� �n�o�n� �v�i� �s�o�n�o� �l�i�m�i�t�i� �a�l�l�e�
�d�i�m�e�n�s�i�o�n�i� �d�e�l�l�a� �c�o�l�p�a� �u�m�a�n�a - �e�s�s�e�n�d�o�,� �d�a�
�s�e�m�p�r�e�,� �l'u�o�m�o� �q�u�a�l�e� �M�a�c�h�i�a�v�e�l�l�i� �l�o� �h�a�
�d�e�s�c�r�i�t�t�o� �n�e�l� �c�a�p�i�t�o�l�o� �d�i�c�i�a�s�s�e�t�t�e�s�i�m�o� �d�e�l�
�P�r�i�n�c�i�p�e�,� �c�o�n� �p�a�r�t�i�c�o�l�a�r�e� �r�i�f�e�r�i�m�e�n�t�o� �a�l�l�a�
�q�u�a�l�i�f�i�c�a� �d�i� «�c�u�p�i�d�o� �d�i� �g�u�a�d�a�g�n�o» - �l�a�
�S�a�d�e�,� �n�e�l�l'i�n�t�e�n�t�o� �d�i� �r�a�g�g�i�u�n�g�e�r�e� �l�a� �q�u�o�t�a�
�m�a�s�s�i�m�a� �d�i� �7�1�5� �c�h�i�e�s�e�,� �i�l� �2�0� �m�a�r�z�o� �1�9�6�3�,� �i�l�
�t�e�r�z�o� �i�n�v�a�s�o� �c�h�e�,� �g�r�a�d�a�t�a�m�e�n�t�e�,� �p�o�r�t�ò� �i�l�
�b�a�c�i�n�o�,� �a�l�l�a� �d�a�t�a� �d�e�l� �1�5� �s�e�t�t�e�m�b�r�e�,� �a� �q�u�o�t�a�
�7�1�0�.� �M�a�,� �a� �q�u�e�l�l�a� �d�a�t�a�,� �l'a�c�c�e�l�e�r�a�z�i�o�n�e� �d�e�i�
�m�o�v�i�m�e�n�t�i� �d�e�l�l�a� �m�a�s�s�a� �r�o�c�c�i�o�s�a� �v�e�r�s�o� �i�l�
�b�a�s�s�o� �c�o�n�v�i�n�s�e� �i� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i� �E�n�e�l�-�S�a�d�e� �a�
�i�n�t�e�r�r�o�m�p�e�r�e� �l'i�n�v�a�s�o� �e� �a� �i�n�i�z�i�a�r�e�,� �i�l� �2�7�
�s�e�t�t�e�m�b�r�e�,� �l�o� �s�v�a�s�o�.� �M�a�,� �q�u�a�n�d�o� �s�i� �r�a�g�g�i�u�n�s�e�
�q�u�o�t�a� �7�0�8�,� �s�i� �v�e�r�i�f�i�c�ò� �l�a� �c�a�t�a�s�t�r�o�f�e�.�
�B�i�s�o�g�n�a� �o�r�a� �r�i�c�o�r�d�a�r�e� �c�h�e� �l�a�
�n�a�z�i�o�n�a�l�i�z�z�a�z�i�o�n�e� �d�e�l�l'e�n�e�r�g�i�a� �e�l�e�t�t�r�i�c�a�,�
�d�e�c�i�s�a� �l�e�g�i�s�l�a�t�i�v�a�m�e�n�t�e� �n�e�l�
�n�o�v�e�m�b�r�e�-�d�i�c�e�m�b�r�e� �1�9�6�2�,� �a�v�e�v�a� �a�v�u�t�o� �c�o�m�e�
�p�r�i�m�a� �c�o�n�s�e�g�u�e�n�z�a� �i�l� �p�a�s�s�a�g�g�i�o� �d�e�l� �b�a�c�i�n�o�,�
�i�l� �1�6� �m�a�r�z�o� �1�9�6�3�,� �a�l�l'E�n�e�l�,� �r�e�s�t�a�n�d�o� �p�e�r�ò�
�l�a� �S�a�d�e� «�c�u�s�t�o�d�e»;� �e�d� �e�r�a� �d�i�v�e�n�u�t�a�
�o�p�e�r�a�n�t�e� �s�o�l�t�a�n�t�o� �i�l� �2�7� �l�u�g�l�i�o� �1�9�6�3�,� �q�u�a�n�d�o�
�i�l� �b�a�c�i�n�o� �e�r�a� �p�a�s�s�a�t�o�,� �a� �t�u�t�t�i� �g�l�i� �e�f�f�e�t�t�i�,�
�i�n� �f�a�t�t�o� �e� �i�n� �d�i�r�i�t�t�o�,� �a�l�l'E�n�e�l�.� �N�e� �s�e�g�u�i�v�a�
�c�h�e� �d�i� �t�u�t�t�i� �i� �d�a�n�n�i� �d�e�r�i�v�a�t�i� �d�a�l�l�e� �c�o�n�d�o�t�t�e�
�c�o�l�p�o�s�e�,� �p�o�s�t�e� �i�n� �e�s�s�e�r�e� �d�o�p�o� �q�u�e�s�t�o�
�p�a�s�s�a�g�g�i�o�,� �a�v�r�e�b�b�e� �r�i�s�p�o�s�t�o� �l'E�n�e�l�.� �Q�u�a�l�o�r�a�
�i�n�v�e�c�e� �s�i� �f�o�s�s�e� �d�i�m�o�s�t�r�a�t�o� �c�h�e� �a� �c�a�g�i�o�n�a�r�e�
�i�l� �d�i�s�a�s�t�r�o� �a�v�e�v�a�n�o� �c�o�n�t�r�i�b�u�i�t�o� �c�o�n�d�o�t�t�e�
�c�o�l�p�o�s�e� �a�n�t�e�c�e�d�e�n�t�i�,� �l�a� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�t�à�
�c�i�v�i�l�e� �s�a�r�e�b�b�e� �r�i�c�a�d�u�t�a� �a�n�c�h�e� �s�u�l�l�a� �S�a�d�e�,�
�c�h�e� �e�r�a� �s�t�a�t�a� �i�n�c�o�r�p�o�r�a�t�a� �d�a�l�l�a� �M�o�n�t�e�d�i�s�o�n�.�
�I�n� �t�a�l� �c�a�s�o�,� �g�r�a�v�i�s�s�i�m�a� �s�a�r�e�b�b�e� �s�t�a�t�a� �l�a�
�r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�t�à� �d�e�l�l�a� �C�o�m�m�i�s�s�i�o�n�e� �d�i�
�c�o�l�l�a�u�d�o� �i�s�t�i�t�u�i�t�a� �p�r�e�s�s�o� �i�l� �m�i�n�i�s�t�e�r�o� �d�e�i�
�L�a�v�o�r�i� �p�u�b�b�l�i�c�i�,� �c�h�e� �a�v�e�v�a� �a�u�t�o�r�i�z�z�a�t�o� �g�l�i�
�i�n�v�a�s�i�,� �c�o�n� �c�o�n�s�e�g�u�e�n�t�e� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�t�à�
�c�i�v�i�l�e� �d�e�l�l�o� �S�t�a�t�o�.� �T�o�r�n�a�n�d�o� �a�i� �r�a�p�p�o�r�t�i�
�S�a�d�e�-�E�n�e�l�,� �i� �c�o�l�p�e�v�o�l�i� �p�o�t�e�v�a�n�o� �r�i�s�u�l�t�a�r�e� �l�e�
�s�t�e�s�s�e� �p�e�r�s�o�n�e�,� �e�s�s�e�n�d�o� �r�i�m�a�s�t�a� �i�n�v�a�r�i�a�t�a� �l�a�
�s�t�r�u�t�t�u�r�a� �i�m�p�r�e�n�d�i�t�o�r�i�a�l�e� �p�r�e�e�s�i�s�t�e�n�t�e�.� �M�a�,�
�q�u�a�n�d�o� �e�s�s�i� �a�v�e�v�a�n�o� �a�g�i�t�o� �p�e�r� �c�o�n�t�o� �d�e�l�l�a�
�S�a�d�e�,� �n�e� �a�v�e�v�a�n�o� �c�o�i�n�v�o�l�t�o� �l�a�
�r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�t�à� �c�h�e�,� �i�n�v�e�c�e�,� �s�a�r�e�b�b�e�
�r�i�c�a�d�u�t�a� �i�n�t�e�r�a�m�e�n�t�e� �s�u�l�l'E�n�e�l�,� �q�u�a�n�d�o� �f�o�s�s�e�
�e�m�e�r�s�o� �c�h�e� �l�e� �c�o�n�d�o�t�t�e� �e�r�a�n�o� �s�t�a�t�e� �p�o�s�t�e� �i�n�
�e�s�s�e�r�e� �s�u�c�c�e�s�s�i�v�a�m�e�n�t�e� �a�l� �2�7� �l�u�g�l�i�o� �1�9�6�3�,�
�d�a�t�a� �i�n� �c�u�i� �i�l� �b�a�c�i�n�o� �e�r�a� �p�a�s�s�a�t�o�,� �a�p�p�u�n�t�o�,�
�i�n� �f�a�t�t�o� �e� �i�n� �d�i�r�i�t�t�o�,� �a�l�l'E�n�e�l�.
�I�l� �b�a�l�l�e�t�t�o� �d�e�l�l�e�
�p�e�r�i�z�i�e�
�L�a� �c�a�t�a�s�t�r�o�f�e�,� �c�h�e� �e�b�b�e� �u�n�a� �e�c�o� �i�m�m�e�n�s�a� �i�n�
�t�u�t�t�o� �i�l� �m�o�n�d�o�,� �p�r�o�v�o�c�ò� �q�u�a�s�i� �2�0�0�0� �m�o�r�t�i�
�e� �d�i�s�t�r�u�s�s�e� �p�r�a�t�i�c�a�m�e�n�t�e� �E�r�t�o� �C�a�s�s�o� �e�
�L�o�n�g�a�r�o�n�e�.� �E�b�b�e� �a�l�l�o�r�a� �n�e�c�e�s�s�a�r�i�a�m�e�n�t�e�
�i�n�i�z�i�o� �d�a�v�a�n�t�i� �a�l� �T�r�i�b�u�n�a�l�e� �d�i� �B�e�l�l�u�n�o�
�u�n'i�s�t�r�u�t�t�o�r�i�a� �a� �c�a�r�i�c�o� �d�i� �d�i�e�c�i� �i�m�p�u�t�a�t�i� �t�r�a�
�i� �q�u�a�l�i�,� �o�v�v�i�a�m�e�n�t�e�,� �s�i�a� �i� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i� �d�e�l�
�b�a�c�i�n�o - �e� �c�i�o�è �S�a�d�e� �e�d� �E�n�e�l - �s�i�a� �i�
�f�u�n�z�i�o�n�a�r�i� �m�i�n�i�s�t�e�r�i�a�l�i�,� �i�v�i� �c�o�m�p�r�e�s�a� �l�a�
�C�o�m�m�i�s�s�i�o�n�e� �d�i� �c�o�l�l�a�u�d�o� �i�s�t�i�t�u�i�t�a� �p�r�e�s�s�o� �i�l�
�S�e�r�v�i�z�i�o� �d�i�g�h�e� �d�e�l� �m�i�n�i�s�t�e�r�o� �d�e�i� �L�a�v�o�r�i�
�p�u�b�b�l�i�c�i�,� �s�i�a�,� �i�n�f�i�n�e�,� �l'i�n�g�e�g�n�e�r�e� �c�a�p�o� �d�e�l�
�G�e�n�i�o� �c�i�v�i�l�e� �d�i� �B�e�l�l�u�n�o�.� �I�l� �g�i�u�d�i�c�e�
�i�s�t�r�u�t�t�o�r�e� �n�o�m�i�n�ò�,� �n�e�c�e�s�s�a�r�i�a�m�e�n�t�e�,� �u�n�
�c�o�l�l�e�g�i�o� �p�e�r�i�t�a�l�e�,� �c�o�m�p�o�s�t�o� �d�a�i� �p�r�o�f�e�s�s�o�r�i�
�A�r�d�i�t�o� �D�e�s�i�o�,� �M�i�c�h�e�l�e� �G�o�r�t�a�n�i� �e� �G�o�s�s�
�C�a�d�i�sc�h�,� �a�i� �q�u�a�l�i� �f�u� �d�a�t�o� �l'i�n�c�a�r�i�c�o� �d�i�
«�a�c�c�e�r�t�a�r�e� �l�e� �c�a�u�s�e� �p�r�o�s�s�i�m�e� �e� �r�e�m�o�t�e� �d�e�l�
�f�e�n�o�m�e�n�o».�
E�b�b�e�n�e�,� �l�e� �c�o�n�c�l�u�s�i�o�n�i� �d�e�l�l�a� �p�e�r�i�z�i�a�,�
�d�e�p�o�s�i�t�a�t�e� �i�l� �1�5� �n�o�v�e�m�b�r�e� �1�9�6�5�,� �f�u�r�o�n�o�
�l�e�t�t�e�r�a�l�m�e�n�t�e� �d�i�s�a�s�t�r�o�s�e� �p�e�r� �l'a�c�c�u�s�a�,�
�p�e�r�c�h�é� �e�s�c�l�u�d�e�v�a�n�o�,� �t�r�a� �l'a�l�t�r�o�,� �l�a� �s�t�e�s�s�a�
�s�u�s�s�i�s�t�e�n�z�a� �d�e�i� �r�e�a�t�i� �d�i� �f�r�a�n�a� �e� �d�i�
�i�n�o�n�d�a�z�i�o�n�e� �e�,� �q�u�e�l� �c�h�e è p�e�g�g�i�o�,�
�c�o�n�d�e�n�s�a�v�a�n�o� �t�u�t�t�e� �l�e� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�t�à�
�n�e�g�l�i� �u�l�t�i�m�i� �g�i�o�r�n�i� �d�i� �s�e�t�t�e�m�b�r�e�,� �f�i�n�o� �a�l�l�a�
�t�r�a�g�i�c�a� �c�o�n�c�l�u�s�i�o�n�e� �d�e�l� �9� �o�t�t�o�b�r�e� �1�9�6�3�.� �I�n�
�t�a�l� �m�o�d�o�,� �t�u�t�t�o� �l'o�n�e�r�e� �d�e�l� �r�i�s�a�r�c�i�m�e�n�t�o� �d�e�i�
�d�a�n�n�i� �r�i�c�a�d�e�v�a� �s�o�s�t�a�n�z�i�a�l�m�e�n�t�e� �s�u�l�l'E�n�e�l�,�
�a�n�c�h�e� �p�e�r�c�h�é� �l�a� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�t�à�
�d�e�l�l'i�n�g�e�g�n�e�r�e� �c�a�p�o� �d�e�l� �G�e�n�i�o� �c�i�v�i�l�e� �d�i�
�B�e�l�l�u�n�o� �e�r�a� �n�o�n� �s�o�l�o� �i�p�o�t�e�t�i�c�a�,� �m�a�
�s�e�c�o�n�d�a�r�i�a� �e� �m�a�r�g�i�n�a�l�e�.� �I�l� �g�i�u�d�i�c�e�
�i�s�t�r�u�t�t�o�r�e�,� �M�a�r�i�o� �F�a�b�b�r�i�,� �c�h�e� �e�r�a� �u�n�a�
�p�e�r�s�o�n�a� �c�a�p�a�c�e� �e� �o�n�e�s�t�a�,� �n�o�n� �p�o�t�e�v�a�
�a�c�c�e�t�t�a�r�e� �s�i�m�i�l�i� �c�o�n�c�l�u�s�i�o�n�i� �e�,� �d�o�p�o�
�c�o�m�p�l�e�s�s�e� �e� �l�u�n�g�h�e� �i�n�d�a�g�i�n�i� �e� �r�i�c�e�r�c�h�e�,�
�n�o�m�i�n�ò� �u�n� �n�u�o�v�o� �c�o�l�l�e�g�i�o� �d�i� �p�e�r�i�t�i�,�
�s�c�e�l�t�i� �t�r�a� �i� �m�e�m�b�r�i� �d�e�l�l'A�c�c�a�d�e�m�i�a� �d�i�
�F�r�a�n�c�i�a�.�
�E�s�s�i� �e�r�a�n�o� �i�l� �p�r�o�f�e�s�s�o�r�e� �M�a�r�c�e�l� �R�o�u�b�a�u�l�t�,�
�d�i�r�e�t�t�o�r�e� �d�e�l�l�a� �S�c�u�o�l�a� �n�a�z�i�o�n�a�l�e� �s�u�p�e�r�i�o�r�e�
�d�i� �G�e�o�l�o�g�i�a� �a�p�p�l�i�c�a�t�a� �d�e�l�l'U�n�i�v�e�r�s�i�t�à� �d�i�
�N�a�n�c�y�,� �i�l� �p�r�o�f�e�s�s�o�r�e� �i�n�g�e�g�n�e�r�e� �A�l�f�r�e�d�
�S�t�u�c�ky� �d�i� �L�o�s�a�n�n�a�,� �d�i�r�e�t�t�o�r�e� �d�e�l�
�P�o�l�i�t�e�c�n�i�c�o� �d�i� �L�o�s�a�n�n�a�,� �d�o�t�t�o�r�e� �h�o�n�o�r�i�s�
�c�a�u�s�a� �i�n� �s�c�i�e�n�z�a� �d�e�l�l�e� �c�o�s�t�r�u�z�i�o�n�i�,� �e�d�
�H�e�n�r�y� �G�r�i�d�e�l�,� �p�r�o�f�e�s�s�o�r�e� �d�i� �i�d�r�a�u�l�i�c�a�
�p�r�e�s�s�o� �l'U�n�i�v�e�r�s�i�t�à� �d�i� �P�a�r�i�g�i�.� �A� �q�u�e�s�t�i� �f�u�
�a�g�g�i�u�n�t�o� �F�l�o�r�i�a�n�o� �C�a�l�v�i�n�o�,� �p�r�o�f�e�s�s�o�r�e�
�i�n�c�a�r�i�c�a�t�o� �p�r�e�s�s�o� �l'I�s�t�i�t�u�t�o� �d�i� �G�e�o�l�o�g�i�a�
�d�e�l�l'U�n�i�v�e�r�s�i�t�à� �d�i� �P�a�d�o�v�a�.� �R�e�s�t�a� �d�a�
�a�g�g�i�u�n�g�e�r�e� �c�h�e� �l�a� �n�o�m�i�n�a� �d�i� �t�r�e� �m�e�m�b�r�i�
�d�e�l�l'A�c�c�a�d�e�m�i�a� �d�i� �F�r�a�n�c�i�a� �r�e�n�d�e�v�a� �n�e�c�e�s�s�a�r�i�a�
�l�a� �t�r�a�d�u�z�i�o�n�e� �i�n� �f�r�a�n�c�e�s�e� �d�e�l�l'i�m�m�e�n�s�a� �m�o�l�e�
�d�e�g�l�i� �a�t�t�i� �p�r�o�c�e�s�s�u�a�l�i�.�
�E� �f�u� �c�o�sì� �c�h�e�
�i�l� �2�3� �g�i�u�g�n�o� �1�9�6�7� �f�u� �d�e�p�o�s�i�t�a�t�a� �l�a� �s�e�c�o�n�d�a�
�p�e�r�i�z�i�a�,� �c�h�e� �t�r�a�v�o�l�g�e�v�a� �l�a� �p�e�r�i�z�i�a� �D�e�s�i�o�,�
�n�o�n�c�h�é� �l�e� �c�o�n�c�l�u�s�i�o�n�i� �d�e�l�l�a� �C�o�m�m�i�s�s�i�o�n�e�
�p�a�r�l�a�m�e�n�t�a�r�e� �d�i� �i�n�c�h�i�e�s�t�a - �q�u�e�s�t�e� �u�l�t�i�m�e�
�m�e�s�s�e� �a�d�d�i�r�i�t�t�u�r�a� �i�n� �r�i�d�i�c�o�l�o - �a�r�r�i�v�a�n�d�o� �a�l�l�a�
�s�e�g�u�e�n�t�e� �t�e�s�t�u�a�l�e� �c�o�n�c�l�u�s�i�o�n�e�:�
«�L'i�p�o�t�e�s�i� �d�i� �u�n�a� �f�r�a�n�a� �r�a�p�i�d�i�s�s�i�m�a� �d�e�l�l�a�
�m�o�n�t�a�g�n�a� �d�e�l� �T�o�c� �n�o�n� �p�o�t�e�v�a� �e�s�s�e�r�e� �e�s�c�l�u�s�a� �e�
�d�o�v�e�v�a� �e�s�s�e�r�e� �c�o�n�s�i�d�e�r�a�t�a� �i�n� �t�u�t�t�e� �l�e� �s�u�e�
�d�r�a�m�m�a�t�i�c�h�e� �c�o�n�s�e�g�u�e�n�z�e�;� �s�i� �p�u�ò� �a�n�z�i�
�d�i�r�e�,� �a�l�l�a� �l�u�c�e� �d�e�l�l�e� �o�s�s�e�r�v�a�z�i�o�n�i� �c�h�e� �e�r�a�n�o�
�s�t�a�t�e� �f�a�t�t�e� �e� �d�e�i� �f�a�t�t�i� �s�i�m�i�l�a�r�i� �d�e�s�c�r�i�t�t�i�
�n�e�l�l�a� �l�e�t�t�e�r�a�t�u�r�a�,� �a�l�c�u�n�i� �d�e�i� �q�u�a�l�i� �n�o�t�o�r�i�,�
�c�h�e� �l'e�v�e�n�i�e�n�z�a� �d�i� �u�n�a� �f�r�a�n�a� �r�a�p�i�d�i�s�s�i�m�a� �e�r�a�
�l�a� �più� �p�r�o�b�a�b�i�l�e�.�
�I�n� �q�u�e�s�t�e� �c�o�n�d�i�z�i�o�n�i
è i�n�c�o�n�t�e�s�t�a�b�i�l�e� �c�h�e� �d�o�v�e�s�s�e�r�o� �e�s�s�e�r�e�
�p�r�e�s�e� �l�e� �m�i�s�u�r�e� �n�e�c�e�s�s�a�r�i�e� �p�e�r� �s�a�l�v�a�g�u�a�r�d�a�r�e�
�l�e� �v�i�t�e� �u�m�a�n�e�»�.
�L'A�c�c�a�d�e�m�i�a� �d�i� �F�r�a�n�c�i�a� �e�r�a� �s�t�a�t�a� �d�e�g�n�a� �d�e�l�l�e�
�s�u�e� �g�r�a�n�d�i� �t�r�a�d�i�z�i�o�n�i�:� �l�e� �c�o�n�s�i�d�e�r�a�z�i�o�n�i�
�s�u�l�l�a� �g�r�a�v�i�t�à� �d�e�l�l�e� �c�o�n�d�o�t�t�e� �c�o�l�p�o�s�e�
�p�o�s�t�e� �i�n� �e�s�s�e�r�e�,� �a� �c�o�m�i�n�c�i�a�r�e� �d�a�l�l�a�
�c�o�s�t�r�u�z�i�o�n�e� �d�e�l�l�a� �d�i�g�a� �s�e�n�z�a� �l�e� �p�r�e�v�e�n�t�i�v�e�
�n�e�c�e�s�s�a�r�i�e� �i�n�d�a�g�i�n�i� �s�u�l�l�a� �s�o�l�i�d�i�t�à� �d�e�l�l�e�
�s�p�o�n�d�e� �d�e�l� �b�a�c�i�n�o�,� �e�r�a�n�o� �i�n�c�o�n�t�r�o�v�e�r�t�i�b�i�l�i�.�
�N�e�s�s�u�n�o� �e�r�a� �r�i�u�s�c�i�t�o� �a� �i�n�f�l�u�e�n�z�a�r�e� �l�e�
�p�e�r�e�n�t�o�r�i�e� �c�o�n�c�l�u�s�i�o�n�i� �d�e�g�l�i� �a�c�c�a�d�e�m�i�c�i�
�f�r�a�n�c�e�s�i.
� �<�b�>�L�e� �a�z�i�o�n�i� �l�e�g�a�l�i�<�/�b�>�<�blockquote�>
�E� �o�r�a� �v�e�n�i�a�m�o� �a� �u�n� �a�l�t�r�o� �v�e�r�s�a�n�t�e�.� �I�
�c�o�n�g�i�u�n�t�i� �d�e�i� �m�o�r�t�i� �a�v�e�n�t�i� �d�i�r�i�t�t�o� �a�l�l�a�
�c�o�s�t�i�t�u�z�i�o�n�e� �d�i� �p�a�r�t�e� �c�i�v�i�l�e� �e� �a�l�
�r�i�s�a�r�c�i�m�e�n�t�o� �d�e�i� �d�a�n�n�i� �e�r�a�n�o� �m�i�g�l�i�a�i�a�:�
�r�i�s�a�r�c�i�m�e�n�t�o� �c�h�e� �s�p�e�t�t�a�v�a�,� �n�a�t�u�r�a�l�m�e�n�t�e�,�
�a�n�c�h�e� �a�i� �c�o�m�u�n�i� �d�i� �L�o�n�g�a�r�o�n�e� �e�d� �E�r�t�o� �C�a�s�s�o�,�
�l�e�t�t�e�r�a�l�m�e�n�t�e� �d�e�v�a�s�t�a�t�i� �d�a�l�l�a� �g�i�g�a�n�t�e�s�c�a�
�o�n�d�a�t�a�.� �M�a� �n�o�n� �e�r�a� �p�e�n�s�a�b�i�l�e�,� �s�p�e�c�i�e� �t�e�n�e�n�d�o�
�p�r�e�s�e�n�t�e� �l�a� �n�e�c�e�s�s�i�t�à� �d�i� �a�v�v�a�l�e�r�s�i� �d�i�
�c�o�n�s�u�l�e�n�t�i� �t�e�c�n�i�c�i�,� �c�h�e� �u�n�a� �r�i�d�d�a� �d�i�
�a�v�v�o�c�a�t�i� �e� �d�i� �p�a�r�t�i� �t�r�o�v�a�s�s�e�,� �n�o�n� �d�i�c�i�a�m�o� �l�a�
�c�o�n�c�o�r�d�i�a�,� �m�a� �l'a�c�c�o�r�d�o� �s�u�l�l�e� �n�o�m�i�n�e� �d�i�
�c�o�n�s�u�l�e�n�t�i� �t�e�c�n�i�c�i� �d�i� �s�t�a�t�u�r�a� �e�u�r�o�p�e�a�,� �c�u�i�
�e�r�a� �n�e�c�e�s�s�a�r�i�o� �r�i�v�o�l�g�e�r�s�i� �p�e�r� �f�r�o�n�t�e�g�g�i�a�r�e�
�l'i�m�p�o�n�e�n�t�e� �a�p�p�a�r�a�t�o� �d�i�f�e�n�s�i�v�o�:� �a� �d�i�f�e�n�d�e�r�e�
�g�l�i� �i�m�p�u�t�a�t�i� �e� �i� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i� �e�r�a�n�o�,�
�i�n�f�a�t�t�i�,� �s�c�h�i�e�r�a�t�i� �a�l�c�u�n�i� �t�r�a� �i� �m�i�g�l�i�o�r�i�
�a�v�v�o�c�a�t�i� �i�t�a�l�i�a�n�i� �e� �u�n�o� �s�t�u�o�l�o� �d�i� �c�o�n�s�u�l�e�n�t�i�
�t�r�a� �i� �m�i�g�l�i�o�r�i� �d'E�u�r�o�p�a�.� �F�u� �c�o�sì� �c�h�e� �i�l�
�C�o�m�u�n�e� �d�i� �L�o�n�g�a�r�o�n�e� �c�o�s�t�i�t�uì� �u�n� �c�o�n�s�o�r�z�i�o�
�t�r�a� �i� �d�a�n�n�e�g�g�i�a�t�i� �d�a�l�l�a� �c�a�t�a�s�t�r�o�f�e� �d�e�l�
�V�a�j�o�n�t� �e� �n�o�m�i�n�ò� �t�r�e� �a�v�v�o�c�a�t�i�,� �a�i� �q�u�a�l�i�
�t�u�t�t�i� �g�l�i� �a�v�e�n�t�i� �d�i�r�i�t�t�o� �p�o�t�e�v�a�n�o� �r�i�v�o�l�g�e�r�s�i�
�g�r�a�t�u�i�t�a�m�e�n�t�e� �p�e�r� �o�t�t�e�n�e�r�e� �i�l� �r�i�s�a�r�c�i�m�e�n�t�o�
�d�e�i� �d�a�n�n�i�,� �f�e�r�m�o� �r�e�s�t�a�n�d�o� �c�h�e� �c�h�i� �v�o�l�e�v�a�
�a�f�f�i�d�a�r�s�i� �a� �u�n� �a�v�v�o�c�a�t�o� �d�i� �s�u�a� �f�i�d�u�c�i�a�
�p�o�t�e�v�a� �f�a�r�l�o�.�
�I� �t�r�e� �p�r�e�s�c�e�l�t�i� �f�u�r�o�n�o�:�
-
�G�i�u�s�e�p�p�e� �B�e�t�t�i�o�l�,� �t�i�t�o�l�a�r�e� �d�e�l�l�a� �c�a�t�t�e�d�r�a�
�d�i� �d�i�r�i�t�t�o� �p�e�n�a�l�e� �d�e�l�l'U�n�i�v�e�r�s�i�t�à� �d�i�
�P�a�d�o�v�a�,� �a�l� �q�u�a�l�e� �f�u� �i�n� �q�u�e�l�l�a� �p�r�i�m�a� �f�a�s�e�
�a�f�f�i�d�a�t�o� �a�n�c�h�e� �i�l� �p�a�t�r�o�c�i�n�i�o� �d�e�l� �C�o�m�u�n�e�,
�-
�E�t�t�o�r�e� �G�a�l�l�o� �d�i� �V�i�c�e�n�z�a�,� �p�u�r�e� �d�o�c�e�n�t�e�
�u�n�i�v�e�r�s�i�t�a�r�i�o�,� �p�o�i� �d�i�v�e�n�u�t�o� �p�r�e�s�i�d�e�n�t�e� �d�e�l�l�a�
�C�o�r�t�e� �c�o�s�t�i�t�u�z�i�o�n�a�l�e�,
��- e� �c�h�i� �s�c�r�i�v�e�.� �M�o�l�t�i� �s�i� �c�h�i�e�s�e�r�o� �p�e�r�c�h�é� �f�o�s�s�i� �s�t�a�t�o�
�s�c�e�l�t�o� �p�r�o�p�r�i�o� �i�o�,� �c�o�n�s�i�d�e�r�a�t�o� �f�i�n�o� �a� �q�u�e�l�
�m�o�m�e�n�t�o� �q�u�a�s�i� �u�n� �a�v�v�o�c�a�t�o� �d�i� �p�r�o�v�i�n�c�i�a�.� �T�a�l�e�
�n�o�n� �e�r�o� �a�v�e�n�d�o�,� �t�r�a� �l'a�l�t�r�o�,� �p�a�r�t�e�c�i�p�a�t�o�,�
�c�o�m�e� �p�a�t�r�o�n�o� �d�i� �p�a�r�t�e� �c�i�v�i�l�e� �n�e�l�l'i�n�t�e�r�e�s�s�e�
�d�e�i� �c�o�n�g�i�u�n�t�i� �d�i� �d�o�d�i�c�i� �d�e�l�l�e� �s�e�d�i�c�i�
�v�i�t�t�i�m�e�,� �a�l� �p�r�o�c�e�s�s�o� �p�e�r� �l�a� �s�t�r�a�g�e� �d�i� �P�i�a�z�z�a�
�F�o�n�t�a�n�a�.� �M�a� �e�r�o� �s�t�a�t�o� �s�c�o�n�f�i�t�t�o�,� �p�e�r�c�h�é�
�t�u�t�t�i� �g�l�i� �i�m�p�u�t�a�t�i� �e�r�a�n�o� �s�t�a�t�i� �a�s�s�o�l�t�i�.�
�C�o�m�u�n�q�u�e�,� �l�a� �r�i�b�e�l�l�i�o�n�e� �a�l�l�a� �m�i�a� �n�o�m�i�n�a� �f�u�
�m�o�l�t�o� �d�i�f�f�u�s�a�,� �i�n� �t�u�t�t�i� �i� �s�e�t�t�o�r�i�,� �g�r�a�n�d�e�
�s�t�a�m�p�a� �c�o�m�p�r�e�s�a�.�
�E�d� �e�c�c�o� �l�a� �s�p�i�e�g�a�z�i�o�n�e�
�d�e�l� �m�i�o� �i�n�g�r�e�s�s�o� �i�n� �q�u�e�s�t�a� �c�a�u�s�a�,� �l�a� �più�
�d�i�f�f�i�c�i�l�e� �e� �l�a� �più� �i�m�p�e�g�n�a�t�i�v�a� �d�e�l�l�a� �m�i�a�
�v�i�t�a�.� �T�r�a� �c�o�l�o�r�o� �c�h�e� �a�v�e�v�a�n�o� �d�i�r�i�t�t�o� �a�
�c�o�s�t�i�t�u�i�r�s�i� �p�a�r�t�e� �c�i�v�i�l�e� �v�i� �e�r�a�n�o� �i� �f�r�a�t�e�l�l�i�
�G�a�l�l�i� �c�h�e�,� �d�o�p�o� �i�l� �9� �o�t�t�o�b�r�e�,� �a�v�e�v�a�n�o�
�t�r�o�v�a�t�o�,� �a�l�l�a� �d�e�r�i�v�a�,� �s�u�l� �P�i�a�v�e�,� �i�l� �c�o�r�p�o�
�d�e�l�l�a� �m�a�d�r�e�,� �m�a� �n�o�n� �q�u�e�l�l�o� �d�e�l� �p�a�d�r�e�,�
�s�c�o�m�p�a�r�s�o� �p�e�r� �s�e�m�p�r�e�.� �E�r�a�n�o� �l'a�n�i�m�a�
�d�e�l�l'a�c�c�u�s�a�:� �n�o�n� �a�s�p�i�r�a�v�a�n�o� �a� �o�t�t�e�n�e�r�e�
�r�i�s�a�r�c�i�m�e�n�t�i� �più� �o� �m�e�n�o� �c�o�s�p�i�c�u�i�,� �m�a� �l�a�
�c�o�n�d�a�n�n�a� �d�i� �c�h�i� �a�v�e�v�a� �f�a�t�t�o� �m�o�r�i�r�e� �i�l� �p�a�d�r�e�
�e� �l�a� �m�a�d�r�e�,� �t�e�n�e�n�d�o� �c�o�n�d�o�t�t�e� �l�e�t�t�e�r�a�l�m�e�n�t�e�
�i�m�p�e�r�d�o�n�a�b�i�l�i� �d�a�l�l�e� �q�u�a�l�i� �e�r�a� �d�e�r�i�v�a�t�a�
�q�u�e�l�l'a�u�t�e�n�t�i�c�a� �t�r�a�g�e�d�i�a� �f�a�m�i�l�i�a�r�e�.� �S�a�p�e�v�a�n�o�
�c�h�e� �l�a� �d�i�f�e�s�a� �e�r�a� �m�o�l�t�o� �f�o�r�t�e� �e�,�
�s�o�p�r�a�t�t�u�t�t�o�,� �m�o�l�t�o� �p�o�t�e�n�t�e�:� �t�e�m�e�v�a�n�o� �a�c�c�o�r�d�i�
�f�r�a�u�d�o�l�e�n�t�i�,� �a�g�g�i�u�s�t�a�m�e�n�t�i� �e� �c�o�m�p�r�o�m�e�s�s�i�
�o�b�l�i�q�u�i�.�
S�i� �c�o�n�s�u�l�t�a�r�o�n�o� �d�u�n�q�u�e� �c�o�n� �u�n�
�g�r�a�n�d�e� �a�v�v�o�c�a�t�o� �d�i� �P�a�d�o�v�a� �c�h�e�,� �p�e�r�
�a�v�v�e�n�t�u�r�a�,� �e�r�a� �u�n� �m�i�o� �v�e�c�c�h�i�o� �c�o�m�p�a�g�n�o� �d�i�
�U�n�i�v�e�r�s�i�t�à�:� �m�i� �s�t�i�m�a�v�a� �e� �m�i� �v�o�l�e�v�a� �b�e�n�e�,�
�e� �s�u�g�g�e�rì� �i�l� �m�i�o� �n�o�m�e�.� �M�i� �s�e�n�t�i�i�
�c�o�i�n�v�o�l�t�o�,� �d�u�n�q�u�e�,� �n�o�n� �s�o�l�o� �e� �n�o�n� �t�a�n�t�o�
�s�o�t�t�o� �i�l� �p�i�a�n�o� �p�r�o�f�e�s�s�i�o�n�a�l�e�,� �m�a� �a�n�c�h�e�
�m�o�r�a�l�e�,� �c�i�v�i�l�e� �e� �u�m�a�n�o�.� �E� �c�o�m�p�r�e�s�i� �s�u�b�i�t�o�
�c�h�e� �l�a� �p�r�i�m�a� �b�a�t�t�a�g�l�i�a� �s�i� �c�o�m�b�a�t�t�e�v�a� �s�u�l�
�p�i�a�n�o� �t�e�c�n�i�c�o�.� �C�o�m�i�n�c�i�ò� �c�o�sì� �i�l� �m�i�o�
�p�e�l�l�e�g�r�i�n�a�g�g�i�o� �p�e�r� �a�r�r�u�o�l�a�r�e� �i� �più�
�a�u�t�o�r�e�v�o�l�i� �e�s�p�e�r�t�i� �i�n� �i�d�r�a�u�l�i�c�a� �e�
�g�e�o�m�e�c�c�a�n�i�c�a� �d'E�u�r�o�p�a�,� �t�e�n�e�n�d�o� �p�r�e�s�e�n�t�e�,�
�a�p�p�u�n�t�o�,� �c�h�e� �i� �p�e�r�i�t�i� �d'u�f�f�i�c�i�o� �e�r�a�n�o� �d�i� �f�a�m�a�
�e� �l�i�v�e�l�l�o� �i�n�t�e�r�n�a�z�i�o�n�a�l�e�,� �m�a� �c�h�e�,� �i�n� �I�t�a�l�i�a�,�
�e�r�a� �m�o�l�t�o� �d�i�f�f�i�c�i�l�e� �t�r�o�v�a�r�e� �c�h�i� �f�o�s�s�e�
�d�i�s�p�o�s�t�o� �a� �s�o�s�t�e�n�e�r�e� �l�e� �n�o�s�t�r�e� �r�a�g�i�o�n�i�.� �V�i�
�e�r�a� �d�i� �più�:� �e�s�s�e�n�d�o� �n�e�l� �f�r�a�t�t�e�m�p�o�
�i�n�t�e�r�v�e�n�u�t�a� �l�a� �n�a�z�i�o�n�a�l�i�z�z�a�z�i�o�n�e� �d�e�l�l'e�n�e�r�g�i�a�
�e�l�e�t�t�r�i�c�a� �e�,� �c�o�n�s�e�g�u�e�n�t�e�m�e�n�t�e�,� �l'a�t�t�r�i�b�u�z�i�o�n�e�
�a�l�l'E�n�e�l� �d�e�l�l�a� �p�r�o�p�r�i�e�t�à�,� �p�e�r� �c�o�sì�
�d�i�r�e�,� �d�i� �t�u�t�t�i� �g�l�i� �i�m�p�i�a�n�t�i� �i�d�r�o�e�l�e�t�t�r�i�c�i�
�c�a�p�a�c�i� �d�i� �p�r�o�d�u�r�r�e� �e�n�e�r�g�i�a�,� �l'a�c�c�e�t�t�a�z�i�o�n�e� �d�a�
�p�a�r�t�e� �d�i� �s�c�i�e�n�z�i�a�t�i� �i�t�a�l�i�a�n�i� �d�i� �u�n� �i�n�c�a�r�i�c�o�,�
�c�h�e� �p�o�s�s�i�a�m�o� �d�e�f�i�n�i�r�e� �a�c�c�u�s�a�t�o�r�i�o�,� �d�i�v�e�n�t�a�v�a�
�d�e�l� �t�u�t�t�o� �i�m�p�r�o�b�a�b�i�l�e�.�
�R�i�c�o�r�d�o�,� �i�n�f�a�t�t�i�,�
�c�h�e� �u�n� �p�r�o�f�e�s�s�o�r�e�,� �t�i�t�o�l�a�r�e� �d�i� �u�n�a� �c�a�t�t�e�d�r�a�
�p�r�e�s�t�i�g�i�o�s�a�,� �r�i�b�a�d�e�n�d�o� �i�l� �s�u�o� �r�i�f�i�u�t�o�,� �m�i�
�d�i�s�s�e� �t�e�s�t�u�a�l�m�e�n�t�e�:� «�L�e�i� �n�o�n� �p�u�ò�
�p�r�e�t�e�n�d�e�r�e� �c�h�e� �i�o� �m�i� �m�e�t�t�a� �c�o�n�t�r�o� �i�l� �m�i�o�
�u�n�i�c�o� �p�o�s�s�i�b�i�l�e� �d�a�t�o�r�e� �d�i� �l�a�v�o�r�o».�
C�o�m�i�n�c�i�ò� �c�o�sì� �i�l� �m�i�o� �p�e�l�l�e�g�r�i�n�a�g�g�i�o� �i�n�
�A�m�e�r�i�c�a� �e� �i�n� �E�u�r�o�p�a�,� �s�u�l�l�a� �s�c�o�r�t�a� �d�e�l�l�e�
�i�n�d�i�c�a�z�i�o�n�i� �d�i� �u�n� �a�c�u�t�i�s�s�i�m�o�,� �s�o�r�p�r�e�n�d�e�n�t�e�
�s�c�i�e�n�z�i�a�t�o� �f�r�a�n�c�e�s�e� �c�h�e�,� �p�u�r� �e�s�s�e�n�d�o�
�c�o�l�p�e�v�o�l�i�s�t�a� �a�c�c�e�s�o�,� �n�o�n� �p�o�t�e�v�a�,� �p�e�r� �r�a�g�i�o�n�i�
�s�u�e�,� �a�c�c�e�t�t�a�r�e� �u�n� �i�n�c�a�r�i�c�o� �u�f�f�i�c�i�a�l�e�.� �M�i�
�i�n�c�o�n�t�r�a�v�o� �c�o�n� �l�u�i - �c�h�e� �a�b�i�t�a�v�a� �n�e�l�l'A�l�t�a�
�S�a�v�o�i�a - �a� �S�u�s�a�,� �e� �r�i�c�o�r�d�o� �b�e�n�e� �c�h�e�,� �i�n� �u�n�
�c�o�l�l�o�q�u�i�o� �a�v�v�e�n�u�t�o� �t�r�a� �i�l� �1�6� �e� �i�l� �1�7� �l�u�g�l�i�o�
�1�9�6�6�,� �m�i� �d�i�s�s�e� �c�h�e� �e�r�a� �d�i�s�p�o�s�t�o� �a� �r�e�d�i�g�e�r�e�
�u�n� �d�o�c�u�m�e�n�t�o� �f�o�n�d�a�m�e�n�t�a�l�e� �p�e�r� �l'a�c�c�u�s�a�
�d�e�l�l'a�m�p�i�e�z�z�a� �d�i� �c�i�r�c�a� �d�i�e�c�i�-�q�u�i�n�d�i�c�i� �p�a�g�i�n�e�
�c�h�e�,� �p�e�r�ò�,� �d�o�v�e�v�a� �e�s�s�e�r�e� �t�r�a�s�f�u�s�o� �i�n� �u�n�a�
�m�e�m�o�r�i�a� �c�o�m�e� �s�e� �f�o�s�s�e� �s�t�a�t�o� �r�e�d�a�t�t�o� �d�a� �m�e�:� �e�
�f�u� �q�u�e�l�l�o� �c�h�e� �f�e�c�i�.� �I�n� �t�a�l�e� �o�c�c�a�s�i�o�n�e� �m�i�
�d�i�s�s�e� �c�h�e�,� �n�e�g�l�i� �S�t�a�t�i� �U�n�i�t�i�,� �v�i� �e�r�a�
�u�n'A�u�t�o�r�i�t�à�,� �l�a� �U�.�S�.� �G�e�o�l�o�g�i�c�a�l� �S�u�r�v�e�y�,�
�c�h�e� �a�v�e�v�a� �i�l� �c�o�m�p�i�t�o� �d�i� �s�o�r�v�e�g�l�i�a�r�e� �l�e�
�c�o�n�d�i�z�i�o�n�i� �d�i� �s�i�c�u�r�e�z�z�a� �d�e�l�l�e� �più� �g�r�a�n�d�i�
�d�i�g�h�e� �d�e�g�l�i� �S�t�a�t�i� �U�n�i�t�i�,� �e� �a� �c�a�p�o� �d�e�l�l�a�
�q�u�a�l�e� �v�i� �e�r�a� �u�n� �f�a�m�o�s�o� �p�r�o�f�e�s�s�o�r�e�,� �W�i�l�l�a�r�d�
�J�.� �T�u�r�n�b�u�l�l�.
�P�r�e�s�i� �a�l�l�o�r�a� �c�o�n�t�a�t�t�o�,� �t�r�a�m�i�t�e� �l�a� �n�o�s�t�r�a�
�A�m�b�a�s�c�i�a�t�a� �a� �W�a�s�h�i�n�g�t�o�n�,� �c�o�n� �T�u�r�n�b�u�l�l� �c�h�e� �s�i�
�d�i�c�h�i�a�r�ò� �d�i�s�p�o�s�t�o� �a�d� �a�c�c�e�t�t�a�r�e� �l'i�n�c�a�r�i�c�o�
�d�i� �c�o�n�s�u�l�e�n�t�e� �n�e�l�l'i�n�t�e�r�e�s�s�e� �d�e�i� �c�o�n�g�i�u�n�t�i�
�d�e�l�l�e� �v�i�t�t�i�m�e�,� �a�n�c�h�e� �p�e�r�c�h�é� �c�o�n�o�s�c�e�v�a�
�p�e�r�f�e�t�t�a�m�e�n�t�e� �l�a� �s�t�o�r�i�a� �e� �i� �f�a�t�t�i� �d�e�l�l�a�
�t�r�a�g�e�d�i�a� �d�i� �L�o�n�g�a�r�o�n�e�,� �c�h�e� �a�v�e�v�a� �a�v�u�t�o�
�g�r�a�n�d�e� �r�i�s�o�n�a�n�z�a� �i�n� �t�u�t�t�o� �i�l� �m�o�n�d�o�.� �V�i� �e�r�a�
�p�e�r�a�l�t�r�o� �u�n�a� �d�i�f�f�i�c�o�l�t�à� �d�a� �s�u�p�e�r�a�r�e�.� �N�e�l�
�m�o�m�e�n�t�o� �i�n� �c�u�i� �a�v�e�v�a� �a�s�s�u�n�t�o� �l'i�n�c�a�r�i�c�o� �d�a�l�
�g�o�v�e�r�n�o� �d�e�g�l�i� �S�t�a�t�i� �U�n�i�t�i�,� �c�o�n�c�o�r�d�a�n�d�o� �u�n�o�
�s�t�i�p�e�n�d�i�o� �a�s�t�r�o�n�o�m�i�c�o�,� �q�u�a�l�e� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�e�,�
�a�p�p�u�n�t�o�,� �d�e�l� �f�u�n�z�i�o�n�a�m�e�n�t�o� �e� �d�e�l�l'e�s�e�r�c�i�z�i�o�
�d�e�l�l�e� �g�r�a�n�d�i� �d�i�g�h�e� �a�m�e�r�i�c�a�n�e�,� �a�v�e�v�a�
�a�n�z�i�t�u�t�t�o� �d�o�v�u�t�o� �d�i�c�h�i�a�r�a�r�e� �s�u�l� �s�u�o� �o�n�o�r�e� �d�i�
�n�o�n� �p�o�s�s�e�d�e�r�e� �a�z�i�o�n�i� �d�i� �n�e�s�s�u�n�a� �d�e�l�l�e� �g�r�a�n�d�i�
�c�o�m�p�a�g�n�i�e� �p�r�o�p�r�i�e�t�a�r�i�e� �d�e�l�l�e� �d�i�g�h�e�.� �M�a� �a�v�e�v�a�
�a�n�c�h�e� �d�o�v�u�t�o� �a�s�s�u�m�e�r�e� �l'o�b�b�l�i�g�o� �i�n�d�e�r�o�g�a�b�i�l�e�
�d�i� �n�o�n� �l�a�s�c�i�a�r�e� �i�l� �t�e�r�r�i�t�o�r�i�o� �d�e�g�l�i� �S�t�a�t�i�
�U�n�i�t�i� �s�e�n�z�a� �i�l� �p�e�r�m�e�s�s�o� �d�e�l� �g�o�v�e�r�n�o�,� �a�t�t�e�s�a�
�l�a� �f�u�n�z�i�o�n�e�,� �p�e�r� �c�o�sì� �d�i�r�e�,� �d�i� �g�a�r�a�n�t�e�
�d�e�l�l�a� �s�i�c�u�r�e�z�z�a� �n�a�z�i�o�n�a�l�e�,� �c�o�n� �r�i�f�e�r�i�m�e�n�t�o�,�
�a�p�p�u�n�t�o�,� �a� �q�u�e�l�l�e� �g�r�a�n�d�i� �d�i�g�h�e�.� �E�r�a�,� �d�u�n�q�u�e�,�
�i�l� �g�o�v�e�r�n�o� �i�t�a�l�i�a�n�o� �c�h�e� �d�o�v�e�v�a� �c�h�i�e�d�e�r�e� �a�
�q�u�e�l�l�o� �a�m�e�r�i�c�a�n�o� �d�i� �a�c�c�o�r�d�a�r�e� �a�l� �p�r�o�f�e�s�s�o�r�
�T�u�r�n�b�u�l�l� �i�l� �p�e�r�m�e�s�s�o� �d�i� �l�a�s�c�i�a�r�e�,� �s�i�a� �p�u�r�e�
�p�e�r� �i� �b�r�e�v�i� �p�e�r�i�o�d�i� �n�e�c�e�s�s�a�r�i�,� �l'A�m�e�r�i�c�a�.� �N�o�i�
�c�i� �r�i�v�o�l�g�e�m�m�o� �a�l�l�o�r�a� �a�l� �m�i�n�i�s�t�e�r�o� �d�e�g�l�i�
�E�s�t�e�r�i� �p�e�r�c�h�é� �f�o�r�m�u�l�a�s�s�e� �l�a� �f�o�r�m�a�l�e�
�r�i�c�h�i�e�s�t�a� �a�l� �g�o�v�e�r�n�o� �a�m�e�r�i�c�a�n�o� �d�i�
�a�u�t�o�r�i�z�z�a�r�e� �i�l� �p�r�o�f�e�s�s�o�r� �T�u�r�n�b�u�l�l� �a� �l�a�s�c�i�a�r�e�
�i�l� �t�e�r�r�i�t�o�r�i�o� �a�m�e�r�i�c�a�n�o� �e� �v�e�n�i�r�e� �i�n� �I�t�a�l�i�a�.�
�E� �c�i�ò� �n�o�n� �s�o�l�o� �p�e�r�c�h�é� �s�e�n�z�a� �u�n�a�
�c�o�n�o�s�c�e�n�z�a� �d�i�r�e�t�t�a� �d�e�i� �l�u�o�g�h�i� �d�e�l�l�a� �t�r�a�g�e�d�i�a�
�n�o�n� �a�v�r�e�b�b�e� �m�a�i� �p�o�t�u�t�o� �e�s�p�l�e�t�a�r�e� �l'i�n�c�a�r�i�c�o�,�
�m�a� �p�u�r�e� �i�n� �q�u�a�n�t�o� �a�v�r�e�b�b�e� �d�o�v�u�t�o�
�n�e�c�e�s�s�a�r�i�a�m�e�n�t�e� �a�s�s�i�s�t�e�r�e� �a�l�l�e� �o�p�e�r�a�z�i�o�n�i�
�p�e�r�i�t�a�l�i� �d�e�l�l'A�c�c�a�d�e�m�i�a� �d�i� �F�r�a�n�c�i�a�,� �c�h�e� �s�i�
�s�a�r�e�b�b�e�r�o� �s�v�o�l�t�e� �a� �N�a�n�c�y�,� �e�,� �s�o�p�r�a�t�t�u�t�t�o�,�
�p�a�r�t�e�c�i�p�a�r�e� �a�l� �d�i�b�a�t�t�i�m�e�n�t�o� �i�n� �I�t�a�l�i�a�.� �M�a� �l�a� �r�i�s�p�o�s�t�a� �d�i� �R�o�m�a� �f�u� �n�e�g�a�t�i�v�a�,� �i�l� �c�h�e�
�d�e�t�t�e� �o�r�i�g�i�n�e� �a� �u�n�a� �i�n�t�e�r�p�e�l�l�a�n�z�a�
�p�a�r�l�a�m�e�n�t�a�r�e�,� �i�n� �c�u�i� �s�i� �l�e�g�g�e�v�a�,� �t�r�a�
�l'a�l�t�r�o�: � «�I� �s�o�t�t�o�s�c�r�i�t�t�i� �c�h�i�e�d�o�n�o� �d�i�
�i�n�t�e�r�r�o�g�a�r�e� �i�l� �P�r�e�s�i�d�e�n�t�e� �d�e�l� �C�o�n�s�i�g�l�i�o� �d�e�i�
�M�i�n�i�s�t�r�i� �e�d� �i�l� �M�i�n�i�s�t�r�o� �d�e�g�l�i� �A�f�f�a�r�i� �E�s�t�e�r�i�,�
�p�e�r� �s�a�p�e�r�e� �s�e� �s�o�n�o� �a� �c�o�n�o�s�c�e�n�z�a� �d�e�l� �p�r�o�f�o�n�d�o�
�d�i�s�a�g�i�o� �e� �d�e�l�l�a� �v�i�v�a� �p�r�o�t�e�s�t�a� �c�h�e� �h�a�
�s�u�s�c�i�t�a�t�o� �n�e�l� �c�o�m�u�n�e� �d�i� �L�o�n�g�a�r�o�n�e� �e� �t�r�a� �l�e�
�p�o�p�o�l�a�z�i�o�n�i� �c�o�l�p�i�t�e� �d�a�l�l�a� �c�a�t�a�s�t�r�o�f�e� �d�e�l�
�V�a�j�o�n�t� �d�e�l� �9� �o�t�t�o�b�r�e� �1�9�6�3�,� �l�a� �c�o�m�u�n�i�c�a�z�i�o�n�e�
�c�o�n� �l�a� �q�u�a�l�e� �s�i è r�e�s�o� �n�o�t�o� �c�h�e� «�i�l�
�M�i�n�i�s�t�e�r�o� �d�e�g�l�i� �E�s�t�e�r�i� �n�o�n� �r�a�v�v�i�s�a� �l�a�
�p�o�s�s�i�b�i�l�i�t�à� �d�i� �p�r�o�m�u�o�v�e�r�e� �u�n� �p�a�s�s�o�
�u�f�f�i�c�i�a�l�e� �p�r�e�s�s�o� �i�l� �g�o�v�e�r�n�o� �a�m�e�r�i�c�a�n�o�,� �a�l�
�f�i�n�e� �d�i� �o�t�t�e�n�e�r�e� �c�h�e� �i�l� �s�i�g�n�o�r� �W�i�l�l�a�r�d� �J�.�
�T�u�r�n�b�u�l�l� �s�i�a� �a�u�t�o�r�i�z�z�a�t�o� �a� �p�r�e�s�t�a�r�e� �l�a�
�p�r�o�p�r�i�a� �o�p�e�r�a� �i�n� �r�e�l�a�z�i�o�n�e� �a�l� �p�r�o�c�e�s�s�o� �p�e�r�
�i�l� �d�i�s�a�s�t�r�o� �d�e�l� �V�a�j�o�n�t».
I�l� �c�o�m�u�n�e� �d�i� �L�o�n�g�a�r�o�n�e�,� �i�n�f�a�t�t�i�,� �d�o�p�o� �a�v�e�r�
�i�n�t�e�r�p�e�l�l�a�t�o� �n�u�m�e�r�o�s�i� �s�c�i�e�n�z�i�a�t�i� �i�t�a�l�i�a�n�i� �e�
�d�e�l�l'E�u�r�o�p�a� �O�c�c�i�d�e�n�t�a�l�e� �e�d� �a�v�e�r�n�e� �c�o�n�s�t�a�t�a�t�o�
�p�u�r�t�r�o�p�p�o� �u�n� �s�i�s�t�e�m�a�t�i�c�o� �r�i�f�i�u�t�o�,� �s�i� �e�r�a�
�r�i�v�o�l�t�o� �a�l� �c�a�p�o� �d�e�l� �s�e�r�v�i�z�i�o� �d�i� �S�t�a�t�o� �i�n�
�A�m�e�r�i�c�a� �p�e�r� �i�l� �c�o�n�t�r�o�l�l�o� �e� �l�a� �s�i�c�u�r�e�z�z�a� �d�e�i�
�b�a�c�i�n�i� �a�r�t�i�f�i�c�i�a�l�i�,� �n�o�t�o� �n�e�g�l�i� �a�m�b�i�e�n�t�i�
�s�c�i�e�n�t�i�f�i�c�i�,� �p�e�r� �a�v�e�r�e� �u�n'a�s�s�i�s�t�e�n�z�a� �i�n� �s�e�d�e�
�t�e�c�n�i�c�a� �e� �p�e�r�i�t�a�l�e� �p�e�r� �i� �p�r�o�c�e�d�i�m�e�n�t�i� �i�n�
�c�o�r�s�o� �n�e�i� �c�o�n�f�r�o�n�t�i� �d�e�i� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i� �d�e�l�l�a�
�c�a�t�a�s�t�r�o�f�e� �d�e�l� �V�a�j�o�n�t�.� �S�o�l�a�m�e�n�t�e� �u�n� �p�a�s�s�o�
�u�f�f�i�c�i�a�l�e� �d�e�l� �g�o�v�e�r�n�o� �i�t�a�l�i�a�n�o� �v�e�r�s�o� �q�u�e�l�l�o�
�s�t�a�t�u�n�i�t�e�n�s�e�,� �c�o�m�e� �v�u�o�l�e� �l�a� �p�r�a�s�s�i�
�t�r�a�t�t�a�n�d�o�s�i� �d�i� �u�n� �f�u�n�z�i�o�n�a�r�i�o� �d�i� �u�n�o� �S�t�a�t�o�
�e�s�t�e�r�o�,� �p�o�t�e�v�a� �r�e�n�d�e�r�e� �f�o�r�m�a�l�e� �e�,� �q�u�i�n�d�i�,�
�a�t�t�u�a�b�i�l�e� �l�a� �r�i�c�h�i�e�s�t�a� �d�e�l� �C�o�m�u�n�e� �d�i�
�L�o�n�g�a�r�o�n�e�»�.� G�l�i� �i�n�t�e�r�r�o�g�a�n�t�i�
�c�h�i�e�d�e�v�a�n�o� �d�i� �s�a�p�e�r�e� �i�n�f�i�n�e�:�
«�c�o�m�e� �p�o�s�s�a� �c�o�n�c�i�l�i�a�r�s�i� �s�i�f�f�a�t�t�o�
�c�o�m�p�o�r�t�a�m�e�n�t�o� �d�e�l� �G�o�v�e�r�n�o�,� �d�i� �c�u�i� �i�l�
�c�o�m�u�n�i�c�a�t�o� �d�e�l� �M�i�n�i�s�t�e�r�o� �d�e�g�l�i� �e�s�t�e�r�i�,� �n�e�i�
�c�o�n�f�r�o�n�t�i� �d�e�l�l�a� �r�i�c�h�i�e�s�t�a� �d�e�l� �c�o�m�u�n�e� �d�i�
�L�o�n�g�a�r�o�n�e è l'u�l�t�i�m�o� �g�r�a�v�e� �a�t�t�o�,� �c�o�n� �l�a�
�r�i�c�e�r�c�a� �d�e�l�l�a� �v�e�r�i�t�à� �e� �d�e�l�l�a� �g�i�u�s�t�i�z�i�a�
�a�n�c�o�r� �r�e�c�e�n�t�e�m�e�n�t�e� �p�r�o�m�e�s�s�e� �d�a�l� �P�r�e�s�i�d�e�n�t�e�
�d�e�l�l�a� �R�e�p�u�b�b�l�i�c�a� �n�e�l� �c�o�r�s�o� �d�e�l�l�a� �s�u�a� �v�i�s�i�t�a�
�a� �L�o�n�g�a�r�o�n�e�,� �e� �t�a�n�t�o� �a�t�t�e�s�e� �d�a�l�l�e�
�p�o�p�o�l�a�z�i�o�n�i� �c�o�l�p�i�t�e� �e� �d�a�l�l'o�p�i�n�i�o�n�e� �p�u�b�b�l�i�c�a�
�d�i� �f�r�o�n�t�e� �a� �d�u�e�m�i�l�a� �v�i�t�t�i�m�e� �e� �a� �u�n� �d�i�s�a�s�t�r�o�
�d�i� �c�o�sì� �i�m�m�a�n�i� �p�r�o�p�o�r�z�i�o�n�i�»�.��
�G�l�i� �i�n�t�e�r�r�o�g�a�n�t�i� �B�u�s�e�t�t�o�,� �A�l�i�c�a�t�a�,� �L�i�z�z�e�r�o�
�e� �V�i�a�n�e�l�l�o�,� �p�a�r�l�a�m�e�n�t�a�r�i� �c�o�m�u�n�i�s�t�i�,�
�a�v�e�v�a�n�o� �r�a�g�i�o�n�e� �d�a� �v�e�n�d�e�r�e�:� �i�n�f�a�t�t�i�,� �i�l�
�r�i�f�i�u�t�o� �d�e�l� �G�o�v�e�r�n�o� �i�t�a�l�i�a�n�o� �d�i� �a�i�u�t�a�r�e� �l�e�
�f�a�m�i�g�l�i�e� �d�e�l�l�e� �v�i�t�t�i�m�e� �e� �i�l� �C�o�m�u�n�e� �d�i�
�L�o�n�g�a�r�o�n�e� �a� �o�t�t�e�n�e�r�e� �g�i�u�s�t�i�z�i�a� �p�a�r�l�a�v�a� �a�
�v�o�l�u�m�i� �s�u�l� �d�e�g�r�a�d�o� �m�o�r�a�l�e� �d�e�l�l'I�t�a�l�i�a�.� �M�a� �f�u�
�n�e�c�e�s�s�a�r�i�o� �a�r�r�e�n�d�e�r�s�i�.�
�I�l� �n�o�s�t�r�o�
�c�o�n�s�u�l�e�n�t�e� �r�i�s�e�r�v�a�t�o�,� �i�l� «�p�r�o�f�e�s�s�o�r� �B»,�
�m�i� �f�e�c�e� �a�l�l�o�r�a� �p�r�e�s�e�n�t�e�,� �d�o�p�o� �i�l� �f�a�l�l�i�m�e�n�t�o�
�d�e�l�l�a� �m�i�s�s�i�o�n�e� �a�m�e�r�i�c�a�n�a�,� �c�h�e� �s�i� �p�o�t�e�v�a�
�t�e�n�t�a�r�e� �a� �P�r�a�g�a�:� �i�n� �q�u�e�l�l�a� �U�n�i�v�e�r�s�i�t�à� �v�i�
�e�r�a�n�o� �t�e�c�n�i�c�i� �d�i� �g�r�a�n�d�e� �v�a�l�o�r�e� �e�,� �i�n�
�p�a�r�t�i�c�o�l�a�r�e�,� �i� �p�r�o�f�e�s�s�o�r�i� �T�h�e�o�d�o�r� �J�e�z�d�i�k� �e�
�L�a�d�i�s�l�a�v� �V�o�t�r�u�b�a�,� �t�i�t�o�l�a�r�i� �d�e�l�l�a� �c�a�t�t�e�d�r�a�
�d�i� �I�d�r�o�t�e�c�n�i�c�a�,� �l�a� �c�u�i� �c�o�l�l�a�b�o�r�a�z�i�o�n�e� �p�o�t�e�v�a�
�r�i�s�u�l�t�a�r�e� �p�r�e�z�i�o�s�a�.� �M�a� �p�e�r� �a�n�d�a�r�e� �a� �P�r�a�g�a�
�e�r�a� �n�e�c�e�s�s�a�r�i�a� �l�a� «�b�e�n�e�d�i�z�i�o�n�e» �d�e�l� �P�c�i�,�
�c�h�e� �n�o�n� �t�a�r�d�a�i� �a�d� �o�t�t�e�n�e�r�e�,� �a�n�c�h�e� �p�e�r�c�h�é�
�i�l� �P�a�r�t�i�t�o� �c�o�m�u�n�i�s�t�a� �a�v�e�v�a� �c�a�v�a�l�c�a�t�o� �l�a�
�p�r�o�t�e�s�t�a�,� �f�a�c�e�n�d�o�n�e� �u�n� �c�a�v�a�l�l�o� �d�e�l�l�a�
�b�a�t�t�a�g�l�i�a� �c�o�n�t�r�o� �i�l� «�r�e�g�i�m�e�
�d�e�m�o�c�r�i�s�t�i�a�n�o»,� �c�u�i� �v�e�n�i�v�a� �a�t�t�r�i�b�u�i�t�a� �l�a�
�r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�t�à� �d�e�l�l�a� �t�r�a�g�e�d�i�a�,� �a�n�c�h�e� �s�e�
�a�v�e�v�a� �c�o�m�m�e�s�s�o� �i�l� �c�o�n�s�u�e�t�o� �e�r�r�o�r�e� �d�i�
�p�o�l�i�t�i�c�i�z�z�a�r�e� �t�r�o�p�p�o� �l�a� �c�a�u�s�a�,� �f�o�r�n�e�n�d�o�
�c�o�sì� �p�r�e�z�i�o�s�i� �a�r�g�o�m�e�n�t�i� �a�l�l�a� �d�i�f�e�s�a�.� �D�a�
�p�a�r�t�e� �m�i�a�,� �i�n�v�e�c�e�,� �i�n�t�e�n�d�e�v�o� �a�f�f�i�d�a�r�m�i�
�i�n�t�e�r�a�m�e�n�t�e� �a�i� �d�a�t�i� �t�e�c�n�i�c�i�,� �c�h�e� �s�a�p�e�v�o�
�e�s�s�e�r�e� �i�n�d�i�s�c�u�t�i�b�i�l�m�e�n�t�e� �f�a�v�o�r�e�v�o�l�i� �a�l�l�a�
�t�e�s�i� �d�e�l�l'a�c�c�u�s�a�:� �v�o�l�e�v�o� �i�n�s�o�m�m�a� �r�i�p�o�r�t�a�r�e� �l�a�
�v�i�c�e�n�d�a� �p�r�o�c�e�s�s�u�a�l�e� �n�e�l� �s�u�o� �n�a�t�u�r�a�l�e� �s�o�l�c�o�
�g�i�u�r�i�d�i�c�o�,� �a�l� �d�i� �f�u�o�r�i� �e� �a�l� �d�i� �l�à� �d�i� �o�g�n�i�
�i�m�p�l�i�c�a�z�i�o�n�e� �p�o�l�i�t�i�c�a�,� �m�a� �a�v�e�v�o� �b�i�s�o�g�n�o� �d�i�
�t�e�c�n�i�c�i� �d�i� �c�u�i� �a�v�r�e�i� �p�o�t�u�t�o� �a�v�v�a�l�e�r�m�i� �s�o�l�o�
�c�o�n� �l�a� «�p�r�o�t�e�z�i�o�n�e» �d�e�l� �P�c�i�.�
�P�r�e�s�i�
�c�o�sì� �c�o�n�t�a�t�t�o� �d�i�r�e�t�t�a�m�e�n�t�e�,� �t�r�a�m�i�t�e� �i�
�v�e�r�t�i�c�i� �d�e�l� �P�c�i� �c�o�n� �l'A�m�b�a�s�c�i�a�t�a� �d�e�l�l�a�
�C�e�c�o�s�l�o�v�a�c�c�h�i�a� �a� �R�o�m�a� �e�,� �d�o�p�o� �a�v�e�r�e� �o�t�t�e�n�u�t�o�
�t�u�t�t�i� �i� �v�i�s�t�i� �n�e�c�e�s�s�a�r�i�,� �a�c�c�o�m�p�a�g�n�a�t�o�
�d�a�l�l'a�m�i�c�o� �L�u�c�i�a�n�o� �G�a�l�l�i�,� �c�h�e� �e�r�a�
�l'a�n�i�m�a�t�o�r�e� �d�e�l�l'a�c�c�u�s�a� «�p�r�i�v�a�t�a»,� �m�i�
�r�e�c�a�i� �a� �P�r�a�g�a� �d�o�v�e�,� �d�a�l� �7� �a�l�l'1�1� �g�e�n�n�a�i�o�
�1�9�6�6�,� �i�n�c�o�n�t�r�a�i� �J�e�z�d�i�k� �e� �V�o�t�r�u�b�a�,� �c�h�e� �m�i�
�p�r�e�s�e�n�t�a�r�o�n�o� �a�n�c�h�e� �i�l� �c�o�l�l�e�g�a� �A�l�o�i�s�
�M�y�s�l�i�v�e�c�.�
�I� �c�o�l�l�o�q�u�i� �c�o�n� �g�l�i� �s�c�i�e�n�z�i�a�t�i�
�c�e�c�o�s�l�o�v�a�c�c�h�i� �s�i� �s�v�o�l�s�e�r�o� �c�o�n� �e�s�t�r�e�m�a�
�f�r�a�n�c�h�e�z�z�a� �e� �f�a�c�i�l�i�t�à�,� �g�r�a�z�i�e� �a�n�c�h�e� �a� �u�n�
�i�n�t�e�r�p�r�e�t�e� �i�t�a�l�i�a�n�o� �c�h�e�,� �d�u�r�a�n�t�e� �l�a� �g�u�e�r�r�a�,�
�e�r�a� �s�t�a�t�o� �p�e�r� �a�n�n�i� �i�n� �q�u�e�l�l�e� �r�e�g�i�o�n�i� �c�o�m�e�
�p�a�r�t�i�g�i�a�n�o� �e�,� �p�o�i�,� �s�i� �e�r�a� �f�a�t�t�o� �u�n�a�
�f�a�m�i�g�l�i�a�.� �R�i�e�n�t�r�a�t�o� �i�n� �I�t�a�l�i�a�,� �s�i� �e�r�a�
�s�p�o�s�a�t�o�,� �o�v�v�i�a�m�e�n�t�e� �c�o�n� �u�n'a�l�t�r�a� �d�o�n�n�a�.� �A�v�e�v�a�
�p�e�r�c�i�ò� �d�u�e� �f�a�m�i�g�l�i�e - �c�o�n� �f�i�g�l�i� �e� �m�o�g�l�i -
�u�n�a� �i�n� �I�t�a�l�i�a� �e� �l'a�l�t�r�a�,� �a�p�p�u�n�t�o�,� �a� �P�r�a�g�a�:�
�l'u�n�a� �s�a�p�e�v�a� �d�e�l�l'a�l�t�r�a�,� �m�a� �e�n�t�r�a�m�b�e� �a�v�e�v�a�n�o�
�r�i�m�o�s�s�o� �q�u�e�s�t�o� �p�a�r�t�i�c�o�l�a�r�e�,� �c�o�n�s�e�n�t�e�n�d�o�g�l�i�
�d�u�e� �v�i�t�e� �a�s�s�o�l�u�t�a�m�e�n�t�e� �i�n�d�i�p�e�n�d�e�n�t�i�.� �E� �t�u�t�t�o�
�f�u�n�z�i�o�n�a�v�a� �a� �m�e�r�a�v�i�g�l�i�a�.�
�T�o�r�n�i�a�m�o� �a�l�l�a�
�n�o�s�t�r�a� �s�t�o�r�i�a�.�
F�o�r�t�u�n�a�t�a�m�e�n�t�e� �g�l�i�
�s�c�i�e�n�z�i�a�t�i� �c�e�c�o�s�l�o�v�a�c�c�h�i� �a�v�e�v�a�n�o� �s�t�u�d�i�a�t�o - �e�
�b�e�n�e - �i�l� �f�r�a�n�c�e�s�e�,� �s�i�c�c�h�é� �f�u� �p�o�s�s�i�b�i�l�e�
�u�t�i�l�i�z�z�a�r�e� �l�a� �t�r�a�d�u�z�i�o�n�e� �d�i� �t�u�t�t�i� �g�l�i� �a�t�t�i�,�
�c�h�e� �e�r�a� �s�t�a�t�a� �d�i�s�p�o�s�t�a� �p�e�r� �r�e�n�d�e�r�e� �p�o�s�s�i�b�i�l�e�
�l'i�n�t�e�r�v�e�n�t�o� �d�e�l�l'A�c�c�a�d�e�m�i�a� �d�i� �F�r�a�n�c�i�a�.�
�P�e�r�
�r�e�n�d�e�r�e� �c�o�m�p�l�e�t�a� �e� �d�e�c�i�s�i�v�a� �l�a�
�c�o�l�l�a�b�o�r�a�z�i�o�n�e� �d�e�g�l�i� �s�c�i�e�n�z�i�a�t�i�
�c�e�c�o�s�l�o�v�a�c�c�h�i� �d�o�v�e�t�t�i� �t�o�r�n�a�r�e� �più� �v�o�l�t�e� �a�
�P�r�a�g�a�,� �s�e�m�p�r�e� �a�c�c�o�m�p�a�g�n�a�t�o� �d�a�l�l'a�m�i�c�o�
�i�t�a�l�i�a�n�o� �e� �d�a�l�l'i�n�t�e�r�p�r�e�t�e� �c�o�n� �d�u�e� �f�a�m�i�g�l�i�e�.�
�D�e�b�b�o� �r�i�c�o�r�d�a�r�e� �c�h�e� �d�u�r�a�n�t�e� �t�u�t�t�a� �l�a� �n�o�s�t�r�a�
�p�e�r�m�a�n�e�n�z�a� �a� �P�r�a�g�a� �e�r�a�v�a�m�o� �s�o�r�v�e�g�l�i�a�t�i� �e�
�s�e�g�u�i�t�i�,� �o�v�u�n�q�u�e� �c�i� �r�e�c�a�s�s�i�m�o�,� �p�e�r� �t�u�t�t�a� �l�a�
�g�i�o�r�n�a�t�a�.� �E�,� �c�o�s�a� �i�n�c�r�e�d�i�b�i�l�e� �a� �d�i�r�s�i�,� �a�l�l�o�
�Y�a�l�t�a� �H�o�t�e�l�,� �d�o�v�e� �a�l�l�o�g�g�i�a�v�a�m�o� �e� �d�o�v�e� �l'u�n�i�c�a�
�l�i�n�g�u�a� �s�t�r�a�n�i�e�r�a� �p�a�r�l�a�t�a� �e�r�a� �i�l� �f�r�a�n�c�e�s�e�,� �l�e�
«�g�u�a�r�d�i�e» �o�c�c�u�p�a�v�a�n�o� �l�e� �s�t�a�n�z�e�
�c�o�n�f�i�n�a�n�t�i� �c�o�n� �l�e� �n�o�s�t�r�e� �e� �c�i� �s�o�r�v�e�g�l�i�a�v�a�n�o�
�d�i�s�c�r�e�t�a�m�e�n�t�e� �a�n�c�h�e� �d�i� �n�o�t�t�e�.�
�U�n�a� �s�e�r�a�,� �a�
�P�r�a�g�a�,� �a�s�s�i�e�m�e� �a�l�l'a�m�i�c�o� �G�a�l�l�i� �e�
�a�l�l'i�n�t�e�r�p�r�e�t�e�,� �c�i� �r�e�c�a�m�m�o� �i�n� �u�n�a� �s�o�r�t�a� �d�i�
�l�o�c�a�l�e� �n�o�t�t�u�r�n�o�,� �c�o�n� �b�a�l�l�e�r�i�n�e� �a�b�b�a�s�t�a�n�z�a�
�s�c�o�p�e�r�t�e�.� �M�a� �a�n�c�h�e� �i�n� �q�u�e�l�l'o�c�c�a�s�i�o�n�e� �f�u�m�m�o�
�a�c�c�o�m�p�a�g�n�a�t�i� �d�a�l�l�a� «�s�c�o�r�t�a»,� �c�h�e� �n�o�n� �c�i�
�l�a�s�c�i�ò� �m�a�i�:� �n�o�n� �a�v�e�v�o� �m�a�i� �v�i�s�s�u�t�o�
�u�n'e�s�p�e�r�i�e�n�z�a� �s�i�m�i�l�e�,� �c�h�e� �d�i�m�o�s�t�r�a�v�a�,�
�i�n�c�o�n�f�u�t�a�b�i�l�m�e�n�t�e�,� �q�u�a�l�e� �f�o�s�s�e� �i�l� �v�e�r�o� �v�o�l�t�o�
�d�e�l�l�e� «�d�e�m�o�c�r�a�z�i�e� �p�o�p�o�l�a�r�i».� [...] �M�a� �i� �d�u�e�
�c�o�n�s�u�l�e�n�t�i� �t�r�o�v�a�t�i� �a� �P�r�a�g�a� �n�o�n� �b�a�s�t�a�v�a�n�o�,� �e�
�c�o�sì� �c�o�n�t�i�n�u�ò� �i�l� �m�i�o� �p�e�l�l�e�g�r�i�n�a�g�g�i�o� �i�n�
�E�u�r�o�p�a�,� �a� �L�i�s�b�o�n�a�,� �P�a�r�i�g�i�,� �V�i�e�n�n�a�,� �G�r�e�n�o�b�l�e�,�
�Z�u�r�i�g�o�,� �c�i�t�t�à�,� �q�u�e�s�t'u�l�t�i�m�a�,� �n�e�l�l�a� �q�u�a�l�e�
�p�r�e�s�i� �c�o�n�t�a�t�t�o� �c�o�n� �u�n� �p�r�o�f�e�s�s�o�r�e� �d�i� �f�a�m�a�
�e�u�r�o�p�e�a� �c�h�e� �p�e�r�ò� �r�i�f�i�u�t�ò� �l'i�n�c�a�r�i�c�o� �d�i�
�c�o�n�s�u�l�e�n�t�e� �d�i� �p�a�r�t�e�,� �d�i�c�h�i�a�r�a�n�d�o�s�i� �d�i�s�p�o�s�t�o�
�a�d� �a�c�c�e�t�t�a�r�e� �s�o�l�t�a�n�t�o� �l'i�n�c�a�r�i�c�o� �d�i� �p�e�r�i�t�o�
�d'u�f�f�i�c�i�o�,� �b�e�n� �s�a�p�e�n�d�o� �c�h�e� �e�r�a� �s�t�a�t�o� �a�f�f�i�d�a�t�o�
�a�d� �a�l�t�r�i�.� �R�e�c�l�u�t�a�m�m�o�,� �p�e�r� �c�o�sì� �d�i�r�e�,� �t�r�a�
�l'a�l�t�r�o�,� �i� �p�r�o�f�e�s�s�o�r�i� �J�a�c�q�u�e�s� �V�e�r�d�e�y�e�n�n�e�,�
�t�i�t�o�l�a�r�e� �d�e�l�l�a� �c�a�t�t�e�d�r�a� �d�i� �g�e�o�l�o�g�i�a� �p�r�e�s�s�o�
�l'U�n�i�v�e�r�s�i�t�à� �d�i� �B�r�u�x�e�l�l�e�s�,� �e�d� �E�r�v�i�n�
�N�o�n�v�e�i�l�l�e�r�,� �t�i�t�o�l�a�r�e� �d�e�l�l�a� �c�a�t�t�e�d�r�a� �d�i�
�g�e�o�m�e�c�c�a�n�i�c�a� �p�r�e�s�s�o� �l'U�n�i�v�e�r�s�i�t�à� �d�i�
�Z�a�g�a�b�r�i�a�.� �A�g�g�i�u�n�g�a�s�i� �c�h�e� �i� �n�u�o�v�i� �p�e�r�i�t�i�
�d'u�f�f�i�c�i�o - �d�e�l�l'A�c�c�a�d�e�m�i�a� �d�i� �F�r�a�n�c�i�a - �f�a�c�e�v�a�n�o�
�i� �l�o�r�o� �e�s�p�e�r�i�m�e�n�t�i� �a� �N�a�n�c�y�,� �c�i�t�t�à� �n�e�l�l�a�
�q�u�a�l�e� �d�o�v�e�t�t�i� �r�e�c�a�r�m�i� �più� �v�o�l�t�e� �c�o�i� �n�o�s�t�r�i�
�c�o�n�s�u�l�e�n�t�i� �c�e�c�o�s�l�o�v�a�c�c�h�i�.�
�S�i� �t�r�a�t�t�ò�,�
�d�u�n�q�u�e�,� �più� �c�h�e� �d�i� �u�n�a� �v�i�c�e�n�d�a�
�p�r�o�c�e�s�s�u�a�l�e�,� �d�i� �u�n�a� «�s�t�o�r�i�a» �c�h�e�
�r�i�e�m�p�i�v�a� �l�a� �m�i�a� �v�i�t�a�:� �s�e�n�t�i�v�o� �d�i� �e�s�s�e�r�e� �n�o�n�
�t�a�n�t�o� �u�n�a� �p�a�r�t�e� �p�r�o�c�e�s�s�u�a�l�e�,� �q�u�a�n�t�o� �i�l�
�r�a�p�p�r�e�s�e�n�t�a�n�t�e� �d�i� �u�n'a�l�t�r�a� �I�t�a�l�i�a�,� �q�u�e�l�l�a�
«�i�d�e�a�l�e»,� �e� �d�e�b�b�o� �c�o�n�f�e�s�s�a�r�e� �c�h�e� �m�i�
�s�e�n�t�i�v�o� �d�e�g�n�o� �d�i� �q�u�e�l�l�a� �c�h�e�,� �p�e�r� �m�e�
�a�v�v�o�c�a�t�o�,� �e�r�a� �u�n�a� �s�o�r�t�a� �d�i� �m�i�s�s�i�o�n�e.
�T�o�r�n�a�n�d�o� �a�l� �p�r�o�c�e�s�s�o�,� �l'i�s�t�r�u�t�t�o�r�i�a� �c�o�n�d�o�t�t�a�
�d�a�l� �g�i�u�d�i�c�e� �i�s�t�r�u�t�t�o�r�e� �M�a�r�i�o� �F�a�b�b�r�i� �s�i�
�c�o�n�c�l�u�s�e� �c�o�l� �r�i�n�v�i�o� �a� �g�i�u�d�i�z�i�o� �d�a�v�a�n�t�i� �a�l�
�T�r�i�b�u�n�a�l�e� �d�i� �B�e�l�l�u�n�o� �d�i� �o�t�t�o� �i�m�p�u�t�a�t�i�,�
�c�h�i�a�m�a�t�i� �a� �r�i�s�p�o�n�d�e�r�e� �d�e�i� �r�e�a�t�i� �d�i� �f�r�a�n�a�,� �d�i�
�i�n�o�n�d�a�z�i�o�n�e�,� �d�i� �o�m�i�c�i�d�i�o� �c�o�l�p�o�s�o� �p�l�u�r�i�m�o�:�
�r�e�a�t�i� �t�u�t�t�i� �a�g�g�r�a�v�a�t�i� �d�a�l�l'a�v�e�r�e� �g�l�i� �i�m�p�u�t�a�t�i�
«�a�g�i�t�o� �n�o�n�o�s�t�a�n�t�e� �l�a� �p�r�e�v�i�s�i�o�n�e�
�d�e�l�l'e�v�e�n�t�o» �(�a�r�t�.� �6�1� �n�.� �2� �C�.�P�.�)�.� �E�
�c�i�ò� �r�e�n�d�e�v�a� �l�e�t�t�e�r�a�l�m�e�n�t�e� �e�n�o�r�m�e� �l�o�
�s�p�e�s�s�o�r�e� �d�e�l�l�a� �c�o�l�p�a�,� �a� �p�r�e�s�c�i�n�d�e�r�e� �d�a�l�l�e�
�c�o�n�s�e�g�u�e�n�z�e� �g�i�u�r�i�d�i�c�h�e�.� �L�a� �s�e�n�t�e�n�z�a� �d�e�l�
�g�i�u�d�i�c�e� �i�s�t�r�u�t�t�o�r�e� �M�a�r�i�o� �F�a�b�b�r�i� �c�o�m�i�n�c�i�a�v�a�
�c�o�l� �c�i�t�a�r�e� �l�a� �G�e�n�e�s�i�:� «�I�n� �q�u�e�l�
�g�i�o�r�n�o� �l�e� �a�c�q�u�e� �e�r�u�p�p�e�r�o�.�.�.�.� �i�n�g�r�o�s�s�a�r�o�n�o� �e�
�c�r�e�b�b�e�r�o� �g�r�a�n�d�e�m�e�n�t�e� �e� �a�n�d�a�r�o�n�o� �a�u�m�e�n�t�a�n�d�o�
�s�e�m�p�r�e� �più� �s�o�p�r�a� �l�a� �t�e�r�r�a�...� �e� �s�o�r�p�a�s�s�a�r�o�n�o�
�l�e� �v�e�t�t�e� �d�e�i� �m�o�n�t�i�.� �E� �o�g�n�i� �c�a�r�n�e� �c�h�e� �s�i�
�m�u�o�v�e�... �t�u�t�t�o� �q�u�e�l�l�o� �c�h�e� �e�r�a� �s�u�l�l�a� �t�e�r�r�a�
�a�s�c�i�u�t�t�o�,� �e� �a�v�e�v�a� �a�l�i�t�o� �v�i�t�a�l�e� �n�e�l�l�e� �n�a�r�i�c�i�,�
�m�o�r��.� �(�G�e�n�e�s�i�,� �7�-� �1�1�,� �1�8�,�
�2�2�)�.�
�E�d� �e�c�c�o� �l�a� �c�o�n�c�l�u�s�i�o�n�e�:� «�N�e�l� �c�o�r�s�o�
�d�e�l�l�a� �l�u�n�g�a� �d�i�s�c�u�s�s�i�o�n�e�,� �più� �d�i� �u�n�a� �v�o�l�t�a�,�
�c�i� �s�i�a�m�o� �i�m�b�a�t�t�u�t�i� �i�n� �d�i�f�f�i�c�i�l�i�
�i�n�t�e�r�r�o�g�a�t�i�v�i�,� �a�i� �q�u�a�l�i� �a�b�b�i�a�n�o� �r�i�s�p�o�s�t�o� �p�e�r�
�l�a� �p�a�r�t�e� �d�i� �n�o�s�t�r�a� �c�o�m�p�e�t�e�n�z�a�,� �s�e�n�z�a�
�t�u�t�t�a�v�i�a� �n�o�n� �s�e�g�n�a�l�a�r�e� �q�u�e�l�l�i - �d�i� �d�i�v�e�r�s�a�
�n�a�t�u�r�a - �c�h�e� �d�a� �a�l�t�r�i� �e�s�i�g�e�v�a�n�o� �u�n�a� �r�i�s�p�o�s�t�a�.�
�E� �c�i�ò� �a�b�b�i�a�m�o� �f�a�t�t�o� �p�e�r� �l'o�s�s�e�q�u�i�o� �d�o�v�u�t�o�
�a�l�l�a� �G�i�u�s�t�i�z�i�a� �c�h�e - �c�o�m�e� �a�l�t�r�o�v�e� �d�i�c�e�m�m�o� �–
è s�i�n�o�n�i�m�o� �d�i� �c�i�v�i�l�t�à�.� �P�e�r�c�h�é�,�
�a�n�c�h�e� �c�i�ò� �r�i�t�e�n�i�a�m�o� �r�i�e�n�t�r�a�r�e� �n�e�l� �p�r�e�c�i�s�o�
�e�d� �i�n�e�l�u�d�i�b�i�l�e� �d�o�v�e�r�e� �d�e�i� �g�i�u�d�i�c�i�:� �d�o�v�e�r�e�
�g�i�u�r�i�d�i�c�o� �e� �m�o�r�a�l�e�,� �s�e� �n�o�n� �v�o�g�l�i�a�m�o� �c�h�e� �i�n�
�a�v�v�e�n�i�r�e�,� �i�n� �n�o�m�e� �d�e�l� �p�r�o�g�r�e�s�s�o� �t�e�c�n�i�c�o�,�
�d�e�l�l'e�s�i�g�e�n�z�a� �p�r�o�d�u�t�t�i�v�a� �d�e�l�l�o� �S�t�a�t�o�,� �d�e�l�
�p�r�o�f�i�t�t�o� �d�i� �p�o�c�h�i� �o� �d�i� �m�o�l�t�i�,� �i� �n�o�s�t�r�i�
�s�t�e�s�s�i� �f�i�g�l�i� �s�i�a�n�o� �t�e�s�t�i�m�o�n�i� �e� �v�i�t�t�i�m�e� �d�i�
�a�n�a�l�o�g�h�e� �t�r�a�g�e�d�i�e�»�.� �L'a�b�b�i�a�m�o� �c�i�t�a�t�a�
�p�e�r� �e�s�t�e�s�o� �p�e�r�c�h�é è u�n�a� �d�e�l�l�e� �s�e�n�t�e�n�z�e�
�più� �d�e�g�n�e� �c�h�e�,� �i�n� �più� �d�i� �m�e�z�z�o� �s�e�c�o�l�o�
�d�i� �p�r�o�f�e�s�s�i�o�n�e�,� �i�o� �a�b�b�i�a� �l�e�t�t�o�:� �t�r�a� �l'a�l�t�r�o�
�e�r�a�,� �s�u�l� �p�i�a�n�o� �l�o�g�i�c�o� �e� �g�i�u�r�i�d�i�c�o�,�
�a�r�g�o�m�e�n�t�a�t�a� �m�o�l�t�o� �m�e�g�l�i�o� �d�i� �t�u�t�t�e� �l�e�
�s�e�n�t�e�n�z�e� �c�o�l�l�e�g�i�a�l�i� �s�u�c�c�e�s�s�i�v�a�m�e�n�t�e�
�i�n�t�e�r�v�e�n�u�t�e�.�A� �i�s�t�r�u�t�t�o�r�i�a� �c�o�n�c�l�u�s�a�,� �l�a�
�P�r�o�c�u�r�a� �g�e�n�e�r�a�l�e� �d�i� �V�e�n�e�z�i�a� �r�i�t�e�n�n�e� �c�h�e� �i�l�
�p�r�o�c�e�s�s�o� �n�o�n� �p�o�t�e�s�s�e� �e�s�s�e�r�e� �c�e�l�e�b�r�a�t�o� �a�
�B�e�l�l�u�n�o�,� �p�e�r�c�h�é� �v�a�l�u�t�a�v�a� �c�h�e� �i� �2�0�0�0� �m�o�r�t�i�
�r�e�n�d�e�s�s�e�r�o� �i�m�p�o�s�s�i�b�i�l�e� �l�o� �s�v�o�l�g�i�m�e�n�t�o� �s�e�r�e�n�o�
�d�e�l� �p�r�o�c�e�s�s�o�.� �E� �c�h�i�e�s�e� �a�l�l�o�r�a� �a�l�l�a� �C�o�r�t�e�
�s�u�p�r�e�m�a� �c�h�e� �f�o�s�s�e� �d�e�s�i�g�n�a�t�o� �a�l�t�r�o� �g�i�u�d�i�c�e�,�
�c�h�e� �f�u� �i�n�d�i�v�i�d�u�a�t�o� �n�e�l� �T�r�i�b�u�n�a�l�e� �d�i� �L'A�q�u�i�l�a�:�
�i�n�i�z�i�a�t�i�v�a�,� �q�u�e�s�t�a�,� �s�u�l�l�a� �q�u�a�l�e� �i� �g�i�u�d�i�z�i�
�f�u�r�o�n�o�,� �e� �r�e�s�t�a�n�o�,� �m�o�l�t�o� �d�i�v�e�r�s�i�.� �I�l�
�p�r�o�c�e�s�s�o� �e�b�b�e� �i�n�i�z�i�o� �i�l� �2�5� �n�o�v�e�m�b�r�e� �1�9�6�8�.� �L�e�
�p�a�r�t�i� �c�i�v�i�l�i� �e�r�a�n�o�,� �p�e�r� �l�a� �m�a�g�g�i�o�r� �p�a�r�t�e�,�
�a�p�p�u�n�t�o�,� �a�s�s�i�s�t�i�t�e� �d�a�l�l'a�v�v�o�c�a�t�o� �G�i�u�s�e�p�p�e�
�B�e�t�t�i�o�l�,� �c�h�e� �r�a�p�p�r�e�s�e�n�t�a�v�a� �a�n�c�h�e� �i�l� �c�o�m�u�n�e�
�d�i� �L�o�n�g�a�r�o�n�e�,� �d�a�l� �p�r�o�f�e�s�s�o�r� �E�t�t�o�r�e� �G�a�l�l�o� �e�
�d�a� �m�e�:� �a�n�c�h�e� �i� �c�o�m�u�n�i� �d�i� �E�r�t�o� �C�a�s�s�o� �e�
�C�a�s�t�e�l�l�a�v�a�z�z�o� �s�i� �e�r�a�n�o� �c�o�s�t�i�t�u�i�t�i� �p�a�r�t�e�
�c�i�v�i�l�e�.�
�M�a� �l�a� �c�o�s�a� �più� �s�i�n�g�o�l�a�r�e� �e�r�a� �c�h�e�
�l�o� �S�t�a�t�o� �a�v�e�v�a� �d�u�e� �p�o�s�i�z�i�o�n�i� �l�e�t�t�e�r�a�l�m�e�n�t�e�
�o�p�p�o�s�t�e�.� �D�a� �u�n� �l�a�t�o�,� �i�n�f�a�t�t�i�,� �s�i� �e�r�a�
�c�o�s�t�i�t�u�i�t�o� �p�a�r�t�e� �c�i�v�i�l�e� �c�o�n� �l'A�v�v�o�c�a�t�u�r�a�
�d�i�s�t�r�e�t�t�u�a�l�e� �d�e�l�l�o� �S�t�a�t�o� �d�i� �L'A�q�u�i�l�a�,�
�c�h�i�e�d�e�n�d�o� �i�l� �r�i�s�a�r�c�i�m�e�n�t�o� �d�i� �t�u�t�t�i� �i� �d�a�n�n�i�
�c�h�e� �a�v�e�v�a� �s�u�b�i�t�o� �i�n� �s�e�g�u�i�t�o� �a�l� �d�i�s�a�s�t�r�o�
�(�e�r�a�n�o�,� �o�l�t�r�e�t�u�t�t�o�,� �a�n�d�a�t�e� �d�i�s�t�r�u�t�t�e� �o�p�e�r�e�
�p�u�b�b�l�i�c�h�e� �e� �s�t�r�a�d�e� �s�t�a�t�a�l�i�)�.�
D�a�l�l'a�l�t�r�o�
�l�a�t�o� �l�o� �S�t�a�t�o� �e�r�a�,� �p�e�r� �c�o�sì� �d�i�r�e�,� �d�a�l�l�a�
�p�a�r�t�e� �d�i� �a�l�c�u�n�i� �i�m�p�u�t�a�t�i�,� �p�e�r�c�h�é�,� �q�u�a�l�o�r�a�
�f�o�s�s�e� �i�n�t�e�r�v�e�n�u�t�a� �l�a� �c�o�n�d�a�n�n�a� �d�e�i� �c�o�m�p�o�n�e�n�t�i�
�d�e�l�l�a� �C�o�m�m�i�s�s�i�o�n�e� �d�i� �c�o�l�l�a�u�d�o�,� �o� �d�e�i�
�f�u�n�z�i�o�n�a�r�i� �m�i�n�i�s�t�e�r�i�a�l�i� �c�o�i�n�v�o�l�t�i� �d�e�l�
�S�e�r�v�i�z�i�o� �d�i�g�h�e�,� �o�p�p�u�r�e� �d�e�l�l'i�n�g�e�g�n�e�r�e� �c�a�p�o�
�d�e�l� �G�e�n�i�o� �c�i�v�i�l�e� �d�i� �B�e�l�l�u�n�o�,� �c�i�ò� �a�v�r�e�b�b�e�
�c�o�m�p�o�r�t�a�t�o� �l�a� �s�u�a� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�t�à� �c�i�v�i�l�e�.�
�E� �p�e�r�c�i�ò� �d�o�v�e�v�a� �e�s�s�e�r�e� �a�s�s�i�s�t�i�t�o�
�d�a�l�l'A�v�v�o�c�a�t�u�r�a� �d�e�l�l�o� �S�t�a�t�o�.� �F�u� �s�c�e�l�t�a�
�l'A�v�v�o�c�a�t�u�r�a� �d�i� �u�n� �a�l�t�r�o� �c�a�p�o�l�u�o�g�o� �d�i�
�r�e�g�i�o�n�e�,� �m�a� �l�e� �d�u�e� �p�o�s�i�z�i�o�n�i�,� �i�n� �c�u�i� �v�e�n�i�v�a�
�a� �t�r�o�v�a�r�s�i� �l�o� �S�t�a�t�o�,� �a�l� �t�e�m�p�o� �s�t�e�s�s�o�
�c�r�e�d�i�t�o�r�e� �e� �d�e�b�i�t�o�r�e [contemporaneamente guardia e ladro, giudice e
imputato, assassino e vittima, n. di Tiziano]�,� �e�r�a�n�o� �e� �r�e�s�t�a�v�a�n�o�
�o�p�p�o�s�t�e�.� �I�l� �c�h�e� �r�e�n�d�e�v�a� �s�e�m�p�r�e� �a�t�t�u�a�l�e� �l�a�
�c�o�n�s�t�a�t�a�z�i�o�n�e� �d�i� �L�o�n�g�a�n�e�s�i� �c�h�e� �l'I�t�a�l�i�a è
l�a� �p�a�t�r�i�a� �d�e�l� �d�i�r�i�t�t�o�,� �m�a� �a�n�c�h�e� �d�e�l�
�r�o�v�e�s�c�i�o�.� �E� �f�u� �u�n�a� �v�e�r�a� �f�o�r�t�u�n�a� �c�h�e�
�l'a�v�v�o�c�a�t�o� �d�e�l�l�o� �S�t�a�t�o�,� �c�h�e� �r�a�p�p�r�e�s�e�n�t�a�v�a�
�l'a�c�c�u�s�a�,� �f�o�s�s�e� �u�o�m�o� �d�i� �e�c�c�e�z�i�o�n�a�l�e� �v�a�l�o�r�e�
�g�i�u�r�i�d�i�c�o� �e� �u�m�a�n�o�:� �V�i�n�c�e�n�z�o� �C�a�m�e�r�i�n�i�.�
�R�e�s�t�a� �d�a� �a�g�g�i�u�n�g�e�r�e� �c�h�e� �a�l�l�e� �u�d�i�e�n�z�e�
�p�a�r�t�e�c�i�p�a�v�a�n�o� �a�n�c�h�e� �m�o�l�t�i�s�s�i�m�i� �c�i�t�t�a�d�i�n�i� �d�i�
�L�o�n�g�a�r�o�n�e - �c�o�n�g�i�u�n�t�i� �d�e�i� �m�o�r�t�i - �c�h�e� �s�i�
�t�r�a�s�f�e�r�i�v�a�n�o� �a� �L'A�q�u�i�l�a� �e� �v�i�v�e�v�a�n�o� �i�l�
�p�r�o�c�e�s�s�o� �c�o�m�e� �u�n� �l�o�r�o� �d�r�a�m�m�a�.� �I�l� �p�r�o�c�e�s�s�o� �s�i�
�f�e�r�m�ò� �a� �l�u�n�g�o� �s�u�l�l�e� �c�o�s�i�d�d�e�t�t�e� �q�u�e�s�t�i�o�n�i�
�p�r�e�g�i�u�d�i�z�i�a�l�i�,� �i�n� �p�a�r�t�i�c�o�l�a�r�e� �s�u�l�l'e�c�c�e�z�i�o�n�e�
�d�i� �n�u�l�l�i�t�à� �d�e�l�l�a� �p�e�r�i�z�i�a� �d�e�l�l'A�c�c�a�d�e�m�i�a� �d�i�
�F�r�a�n�c�i�a�.� �S�i� �s�o�s�t�e�n�e�v�a�,� �i�n�f�a�t�t�i�,� �c�h�e�,� �e�s�s�e�n�d�o�
�i� �p�e�r�i�t�i� �c�i�t�t�a�d�i�n�i� �s�t�r�a�n�i�e�r�i�,� �q�u�e�s�t�i� �n�o�n�
�a�v�r�e�b�b�e�r�o� �p�o�t�u�t�o� �a�s�s�u�m�e�r�e� �i�n� �I�t�a�l�i�a� �l�a�
�q�u�a�l�i�t�à� �d�i� �p�u�b�b�l�i�c�i� �u�f�f�i�c�i�a�l�i�,�
�i�n�d�i�s�s�o�l�u�b�i�l�m�e�n�t�e� �c�o�r�r�e�l�a�t�a� �a�l�l�a� �l�o�r�o�
�q�u�a�l�i�t�à� �d�i� �p�e�r�i�t�i� �d'u�f�f�i�c�i�o�.� �M�a� �p�r�o�p�r�i�o� �l�a�
�n�a�t�u�r�a� �e�s�c�l�u�s�i�v�a�m�e�n�t�e� �f�o�r�m�a�l�e� �d�i�
�q�u�e�l�l'e�c�c�e�z�i�o�n�e� �r�e�n�d�e�v�a� �e�v�i�d�e�n�t�e� �l�a�
�c�o�n�s�a�p�e�v�o�l�e�z�z�a� �c�h�e� �e�r�a�v�a�m�o� �d�i� �f�r�o�n�t�e� �a�
�c�o�n�d�o�t�t�e� �c�o�l�p�o�s�e� �d�i� �i�n�u�s�i�t�a�t�e� �d�i�m�e�n�s�i�o�n�i�.�
A�
�c�o�m�i�n�c�i�a�r�e� �d�a�g�l�i� �u�o�m�i�n�i� �d�e�l�l�a� �S�a�d�e�,� �c�h�e�
�s�e�n�z�a� �e�s�s�e�r�e� �c�e�r�t�i� �d�e�l�l�a� �s�o�l�i�d�i�t�à� �d�e�l�l�e�
�s�p�o�n�d�e� �d�e�l� �b�a�c�i�n�o�,� �a�v�e�v�a�n�o� �c�o�s�t�r�u�i�t�o� �l�a� �d�i�g�a�
�e� �c�h�i�e�s�t�o� �g�l�i� �i�n�v�a�s�i� �p�u�r� �c�o�n�o�s�c�e�n�d�o�,� �p�e�r�
�f�a�r�e� �s�o�l�o� �u�n� �e�s�e�m�p�i�o�,� �i�l� �q�u�i�n�d�i�c�e�s�i�m�o�
�r�a�p�p�o�r�t�o� �M�ü�l�l�e�r� �c�h�e� �p�r�e�v�e�d�e�v�a� �l�a� �c�o�n�c�r�e�t�a�
�e�v�e�n�t�u�a�l�i�t�à� �d�i� �r�i�n�u�n�c�i�a�r�e� �a�l�l'e�s�e�r�c�i�z�i�o�
�d�e�l� �b�a�c�i�n�o�.� �I�l� �f�a�t�t�o� �c�h�e� �l�a� �S�a�d�e� �f�o�s�s�e� �n�e�l�
�p�r�o�c�e�s�s�o� �u�n�a� �p�a�r�t�e� �n�o�n� �g�i�u�s�t�i�f�i�c�a�v�a�
�c�e�r�t�a�m�e�n�t�e� �q�u�e�l�l�e� �c�o�n�d�o�t�t�e�.�
�M�a� �c�e�r�t�a�m�e�n�t�e�
�più� �g�r�a�v�e� �e�r�a� �s�t�a�t�o� �i�l� �c�o�m�p�o�r�t�a�m�e�n�t�o� �d�e�i�
«�m�i�n�i�s�t�e�r�i�a�l�i»,� �c�h�e� �a�u�t�o�r�i�z�z�a�n�d�o� �g�l�i�
�i�n�v�a�s�i� �p�u�r� �c�o�n�o�s�c�e�n�d�o� �l�a� �s�i�t�u�a�z�i�o�n�e� �d�i�
�e�s�t�r�e�m�a� �p�e�r�i�c�o�l�o�s�i�t�à� �d�e�l� �b�a�c�i�n�o�,� �a�v�e�v�a�n�o�
�a�v�u�t�o� �u�n� �r�u�o�l�o� �d�e�t�e�r�m�i�n�a�n�t�e� �n�e�l�l�a� �c�a�u�s�a�z�i�o�n�e�
�d�e�l�l'e�v�e�n�t�o�,� �p�u�r� �e�s�s�e�n�d�o� �f�u�n�z�i�o�n�a�r�i� �d�i� �S�t�a�t�o��
�c�u�i� �e�r�a� �a�f�f�i�d�a�t�a� �l�a� �t�u�t�e�l�a� �d�e�l�l�a� �p�u�b�b�l�i�c�a�
�i�n�c�o�l�u�m�i�t�à�.� �[�....�]�
�G�i�u�d�i�z�i�o�
�d�i� �a�p�p�e�l�l�o �M�i� �p�r�e�p�a�r�a�i� �c�o�m�u�n�q�u�e� �c�o�n�
�o�g�n�i� �f�o�r�z�a� �a�l� �g�i�u�d�i�z�i�o� �d�i� �a�p�p�e�l�l�o� �c�h�e� �e�b�b�e�
�i�n�i�z�i�o� �d�a�v�a�n�t�i� �a�l�l�a� �C�o�r�t�e� �d�i� �a�p�p�e�l�l�o� �d�e�
�L'A�q�u�i�l�a� �i�l� �2�5� �n�o�v�e�m�b�r�e� �1�9�6�8�.� �E� �l�e� �m�i�e�
�r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�t�à� �e�r�a�n�o� �d�i� �m�o�l�t�o� �a�u�m�e�n�t�a�t�e�
�p�e�r�c�h�é� �a�v�e�v�o� �a�s�s�u�n�t�o�,� �n�e�l� �f�r�a�t�t�e�m�p�o�,�
�a�n�c�h�e� �i�l� �p�a�t�r�o�c�i�n�i�o� �d�e�l�l�o� �s�t�e�s�s�o� �c�o�m�u�n�e� �d�i�
�L�o�n�g�a�r�o�n�e�,� �i�n� �s�o�s�t�i�t�u�z�i�o�n�e� �d�e�l� �p�r�o�f�e�s�s�o�r�
�G�i�u�s�e�p�p�e� �B�e�t�t�i�o�l�.�
I�l� �p�r�o�c�e�s�s�o� �f�u�
�l�u�n�g�h�i�s�s�i�m�o� �e� �s�i� �c�o�n�c�l�u�s�e� �s�o�l�o� �i�l� �3� �o�t�t�o�b�r�e�
�1�9�7�0�:� �l�a� �C�o�r�t�e�,� �o�p�e�r�a�t�a� �l�a� �s�e�p�a�r�a�z�i�o�n�e� �n�e�i�
�c�o�n�f�r�o�n�t�i� �d�i� �C�u�r�z�i�o� �B�a�t�i�n�i�,� �g�r�a�v�e�m�e�n�t�e�
�i�n�f�e�r�m�o�,� �e� �p�o�i� �d�e�c�e�d�u�t�o� �n�e�l� �c�o�r�s�o� �d�e�l�
�p�r�o�c�e�s�s�o�,� �d�i�c�h�i�a�r�a�v�a� �f�i�n�a�l�m�e�n�t�e� �i�l� �B�i�a�d�e�n�e�
�c�o�l�p�e�v�o�l�e� �a�n�c�h�e� �d�e�i� �r�e�a�t�i� �d�i� �f�r�a�n�a� �e� �d�i�
�i�n�o�n�d�a�z�i�o�n�e� �a� �l�u�i� �a�s�c�r�i�t�t�i�,� �c�o�n� �l'a�g�g�r�a�v�a�n�t�e�
�d�i� �a�v�e�r�e� «�a�g�i�t�o� �n�o�n�o�s�t�a�n�t�e� �l�a� �p�r�e�v�i�s�i�o�n�e�
�d�e�l�l'e�v�e�n�t�o».� �E� �l�o� �c�o�n�d�a�n�n�a�v�a� �a�l�l�a� �p�e�n�a�
�c�o�m�p�l�e�s�s�i�v�a� �d�i� �s�e�i� �a�n�n�i� �d�i� �r�e�c�l�u�s�i�o�n�e�.�
�L�a�
�p�e�n�a�,� �c�h�e� �g�l�i� �e�r�a� �s�t�a�t�a� �i�n�f�l�i�t�t�a� �i�n� �p�r�i�m�o�
�g�r�a�d�o� �p�e�r� �i�l� �s�o�l�o� �r�e�a�t�o� �d�i� �o�m�i�c�i�d�i�o� �c�o�l�p�o�s�o�,�
�v�e�n�i�v�a� �d�i�v�i�s�a� �i�n� �d�u�e� �p�a�r�t�i�,� �m�a� �r�e�s�t�a�v�a�
�i�d�e�n�t�i�c�a�:� �f�u� �c�o�n�d�a�n�n�a�t�o�,� �i�n�f�a�t�t�i�,� �a� �u�n� �a�n�n�o�
�d�i� �r�e�c�l�u�s�i�o�n�e� �p�e�r� �l�a� �f�r�a�n�a�,� �d�u�e� �p�e�r�
�l'i�n�o�n�d�a�z�i�o�n�e�,� �t�r�e� �p�e�r� �l'o�m�i�c�i�d�i�o� �c�o�l�p�o�s�o�.� �S�e�i�
�a�n�n�i�,� �i�n�s�o�m�m�a�,� �c�o�m�e� �i�n� �p�r�i�m�o� �g�r�a�d�o�.� �N�o�n è
i�l� �s�o�l�o� �a�s�p�e�t�t�o� �g�r�o�t�t�e�s�c�o� �d�i� �t�u�t�t�a� �q�u�e�s�t�a�
�v�i�c�e�n�d�a� �p�r�o�c�e�s�s�u�a�l�e�.�
�V�e�n�e�n�d�o� �o�r�a� �a�l�l�e� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�t�à� �c�i�v�i�l�i�,�
�l�e� �c�o�n�s�e�g�u�e�n�z�e� �e�r�a�n�o� �d�i� �g�r�a�n�d�e� �r�i�l�i�e�v�o�,�
�p�e�r�c�h�é� �c�o�m�p�o�r�t�a�v�a�n�o� �s�i�a� �l�a�
�r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�t�à� �c�i�v�i�l�e� �d�e�l�l�a� �S�a�d�e� �e�,�
�c�o�n�s�e�g�u�e�n�t�e�m�e�n�t�e�,� �d�e�l�l�a� �M�o�n�t�e�d�i�s�o�n�,� �s�i�a�
�d�e�l�l�o� �S�t�a�t�o�.� �I�n�f�a�t�t�i�,� �a�n�c�h�e� �l�a� �C�o�m�m�i�s�s�i�o�n�e�
�d�i� �c�o�l�l�a�u�d�o�,� �c�o�n� �l�a� �c�o�n�s�e�g�u�e�n�t�e�
�r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�t�à� �c�i�v�i�l�e� �d�e�l�l�o� �S�t�a�t�o�,� �v�e�n�i�v�a�
�c�o�i�n�v�o�l�t�a� �n�e�l�l�a� �p�e�r�s�o�n�a� �d�i� �u�n�o� �d�e�i� �s�u�o�i�
�m�e�m�b�r�i�,� �l'i�n�g�e�g�n�e�r� �S�e�n�s�i�d�o�n�i - �i�s�p�e�t�t�o�r�e�
�g�e�n�e�r�a�l�e� �d�e�l� �G�e�n�i�o� �c�i�v�i�l�e� �p�r�e�s�s�o� �i�l�
�C�o�n�s�i�g�l�i�o� �s�u�p�e�r�i�o�r�e� �d�e�i� �L�a�v�o�r�i� �p�u�b�b�l�i�c�i - �c�h�e�
�v�e�n�i�v�a� �c�o�n�d�a�n�n�a�t�o� �a�l�l�a� �p�e�n�a� �d�i� �q�u�a�t�t�r�o� �a�n�n�i�
�e� �s�e�i� �m�e�s�i� �d�i� �r�e�c�l�u�s�i�o�n�e�,� �e�s�s�e�n�d�o� �s�t�a�t�a�
�r�i�t�e�n�u�t�a� �s�u�s�s�i�s�t�e�n�t�e�,� �a�n�c�h�e� �p�e�r� �l�u�i�,�
�l'a�g�g�r�a�v�a�n�t�e� �d�e�l�l�a� �p�r�e�v�i�s�i�o�n�e� �d�e�l�l'e�v�e�n�t�o�.� �L�a�
�p�e�n�a� �f�u�,� �p�e�r� �c�o�sì� �d�i�r�e�,� �d�i�s�t�r�i�b�u�i�t�a�:�
�d�i�e�c�i� �m�e�s�i� �p�e�r� �l�a� �f�r�a�n�a�,� �u�n� �a�n�n�o� �e� �o�t�t�o� �m�e�s�i�
�p�e�r� �l'i�n�o�n�d�a�z�i�o�n�e�,� �d�u�e� �a�n�n�i� �p�e�r� �l'o�m�i�c�i�d�i�o�
�c�o�l�p�o�s�o�.� �M�a�i� �t�r�a�g�e�d�i�a� �e� �f�a�r�s�a� �f�u�r�o�n�o� �c�o�sì�
�v�i�c�i�n�e�.� D�e�g�l�i� �a�l�t�r�i� �d�u�e� �m�e�m�b�r�i� �d�e�l�l�a�
�C�o�m�m�i�s�s�i�o�n�e�,� �P�e�n�t�a� �e�r�a� �n�e�l� �f�r�a�t�t�e�m�p�o� deceduto�,� �e�
�F�r�o�s�i�n�i�,� �d�i� �c�u�i� �e�r�a� �d�u�b�b�i�a� �l�a� �p�a�r�t�e�c�i�p�a�z�i�o�n�e�
�a�l�l�e� �d�e�c�i�s�i�o�n�i�,� �f�u� �a�s�s�o�l�t�o� �p�e�r� �i�n�s�u�f�f�i�c�i�e�n�z�a�
�d�i� �p�r�o�v�e�.� �L�a� �s�e�n�t�e�n�z�a� �v�e�n�i�v�a� �d�e�p�o�s�i�t�a�t�a� �i�n�
�C�a�n�c�e�l�l�e�r�i�a� �i�l� �5� �g�e�n�n�a�i�o� �1�9�7�1�,� �q�u�a�n�d�o�,�
�t�e�n�e�n�d�o� �p�r�e�s�e�n�t�e� �c�h�e� �g�l�i� �i�m�p�u�t�a�t�i� �a�v�e�v�a�n�o�
�f�r�u�i�t�o� �d�e�l�l�e� �a�t�t�e�n�u�a�n�t�i� �g�e�n�e�r�i�c�h�e�,� �g�r�a�v�a�v�a�
�s�u�l� �p�r�o�c�e�s�s�o� �l'o�m�b�r�a� �d�e�l�l�a� �p�r�e�s�c�r�i�z�i�o�n�e�,�
�d�e�s�t�i�n�a�t�a� �a� �m�a�t�u�r�a�r�e� �i�l� �9� �a�p�r�i�l�e� �1�9�7�1�.�
�E�,� �p�e�r� �o�t�t�e�n�e�r�e� �u�n�a� �f�i�s�s�a�z�i�o�n�e� �r�a�p�i�d�i�s�s�i�m�a�,�
�f�u� �g�i�o�c�o�f�o�r�z�a� �i�m�p�e�g�n�a�r�s�i� �a� �f�o�n�d�o�,� �r�i�c�o�r�r�e�n�d�o�
�a�d� �a�l�c�u�n�i� �i�n�t�e�r�v�e�n�t�i� �a� �m�u�s�o� �d�u�r�o�: è
n�e�c�e�s�s�a�r�i�o� �r�i�c�o�r�d�a�r�e� �c�h�e� �t�a�l�v�o�l�t�a� �b�i�s�o�g�n�a�
�v�e�s�t�i�r�e� �i� �p�a�n�n�i� �d�e�g�l�i� �i�n�g�i�u�s�t�i� �s�o�l�d�a�t�i� �d�e�l�l�a�
�g�i�u�s�t�i�z�i�a�.� �C�o�m�u�n�q�u�e�,� �i�l� �p�r�o�c�e�s�s�o� �d�a�v�a�n�t�i�
�a�l�l�a� �C�o�r�t�e� �s�u�p�r�e�m�a� �e�b�b�e� �i�n�i�z�i�o� �i�l� �1�5� �m�a�r�z�o�
�1�9�7�1� �e� �s�i� �c�o�n�c�l�u�s�e� �c�o�n� �l�a� �s�e�n�t�e�n�z�a� �d�e�l� �2�5�
�m�a�r�z�o�,� �c�h�e� �r�i�g�e�t�t�a�v�a� �i� �r�i�c�o�r�s�i� �e�,�
�c�o�n�f�e�r�m�a�n�d�o� �l�a� �s�u�s�s�i�s�t�e�n�z�a� �d�e�l�l'a�g�g�r�a�v�a�n�t�e�
�d�e�l�l�a� �p�r�e�v�i�s�i�o�n�e� �d�e�l�l'e�v�e�n�t�o�,� �a�t�t�r�i�b�u�i�v�a� �l�a�
�r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�t�à� �c�i�v�i�l�e� �o�l�t�r�e� �c�h�e� �a�l�l'E�n�e�l -
�r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�e� �c�i�v�i�l�e� �p�e�r� �l�e� �c�o�n�d�o�t�t�e�
�p�o�s�t�e�r�i�o�r�i� �a�l� �2�7� �l�u�g�l�i�o� �1�9�6�3 - �a�n�c�h�e� �a�l�l�a� �S�a�d�e�
�e�,� �c�o�n�s�e�g�u�e�n�t�e�m�e�n�t�e�,� �a�l�l�a� �M�o�n�t�e�d�i�s�o�n�,� �c�h�e� �a�d�
�e�s�s�a� �e�r�a� �s�u�b�e�n�t�r�a�t�a�,� �n�o�n�c�h�é� �a�l�l�a�
�C�o�m�m�i�s�s�i�o�n�e� �d�i� �c�o�l�l�a�u�d�o� �e�,� �c�o�n�s�e�g�u�e�n�t�e�m�e�n�t�e�,�
�a�l�l�o� �S�t�a�t�o�.�
�I� �c�o�n�d�o�n�i� �s�u�c�c�e�s�s�i�v�a�m�e�n�t�e�
�e�l�a�r�g�i�t�i� �r�i�d�u�s�s�e�r�o� �p�r�a�t�i�c�a�m�e�n�t�e� �a� �z�e�r�o� �l�e�
�p�e�n�e� �d�e�t�e�n�t�i�v�e�,� �m�a�,� �c�o�m�e� �s�i� �u�s�a� �d�i�r�e�,� �i�
�p�r�i�n�c�ì�p�i� �e�r�a�n�o� �s�a�l�v�i�.�
�I�n�f�a�t�t�i�,� �n�e�l�l�a� �s�e�n�t�e�n�z�a� �d�e�l�l�a� �C�a�s�s�a�z�i�o�n�e� �s�i�
�l�e�g�g�e� �f�i�n�a�l�m�e�n�t�e�:� «�I�n� �t�e�m�a� �d�i�
�e�s�e�r�c�i�z�i�o� �l�e�c�i�t�o� �d�i� �a�t�t�i�v�i�t�à� �p�e�r�i�c�o�l�o�s�e�
�i�l� �p�a�r�a�m�e�t�r�o� �d�i� �v�a�l�u�t�a�z�i�o�n�e� �d�e�l�l�a� �c�o�n�d�o�t�t�a�
�d�e�l� �s�o�g�g�e�t�t�o� �d�e�v�e� �e�s�s�e�r�e� �r�a�p�p�o�r�t�a�t�o� �a�l�l�e�
�c�o�g�n�i�z�i�o�n�i� �e� �c�a�p�a�c�i�t�à� �d�i� �c�h�i� �a�b�b�i�a� �u�n�a�
�p�a�r�t�i�c�o�l�a�r�e� �a�t�t�i�t�u�d�i�n�e� �a� �p�r�e�v�e�d�e�r�e� �g�l�i�
�e�v�e�n�t�i� �l�e�s�i�v�i� �c�h�e� �l'a�t�t�i�v�i�t�à è
s�u�s�c�e�t�tì�b�i�l�e� �d�i� �p�r�o�v�o�c�a�r�e�,� �m�a�
�n�e�l�l'e�s�e�r�c�i�z�i�o� �d�i� �t�a�l�i� �a�t�t�i�v�i�t�à� �n�o�n è
c�o�m�u�n�q�u�e� �c�o�n�s�e�n�t�i�t�o� �p�o�r�r�e� �a� �r�i�s�c�h�i�o�
�l'i�n�c�o�l�u�m�i�t�à� �d�i� �p�e�r�s�o�n�e� �e�s�t�r�a�n�e�e�
�a�l�l'a�t�t�i�v�i�t�à� �m�e�d�e�s�i�m�a� �o� �d�e�l�l'i�n�t�e�r�a�
�c�o�l�l�e�t�t�i�v�i�t�à� �»�.� �
U�n� �r�i�c�o�r�d�o� �a�n�c�o�r�a�.� �Q�u�a�n�d�o� �s�i� �s�t�a�v�a� �d�i�s�c�u�t�e�n�d�o�
�i�n� �C�a�s�s�a�z�i�o�n�e� �m�a�n�c�a�v�a�n�o� �p�o�c�h�i� �g�i�o�r�n�i� �a�l�l�a�
�p�r�e�s�c�r�i�z�i�o�n�e�.� �T�a�l�u�n�i� �d�i�f�e�n�s�o�r�i� «�c�e�l�e�b�r�i»
�d�i�s�c�u�t�e�v�a�n�o� �m�o�l�t�o� �a� �l�u�n�g�o� �e� �l�e� �u�d�i�e�n�z�e� �s�i�
�p�r�o�t�r�a�e��v�a�n�o� �f�i�n�o� �a� �s�e�r�a�:� �u�n� �a�v�v�o�c�a�t�o� �s�i�
�i�n�t�e�r�r�u�p�p�e� �a�l�l�e� �o�r�e� �2�2�,� �r�i�s�e�r�v�a�n�d�o�s�i� �d�i�
�p�a�r�l�a�r�e� �i�l� �g�i�o�r�n�o� �d�o�p�o�,� �d�i�c�e�n�d�o�s�i�
�s�t�a�n�c�h�i�s�s�i�m�o�.� �M�a� �i�l� �p�r�e�s�i�d�e�n�t�e� �R�o�s�s�o� �g�l�i�
�d�i�s�s�e� �c�h�e� �l'u�d�i�e�n�z�a� �s�a�r�e�b�b�e� �c�o�n�t�i�n�u�a�t�a - �d�o�p�o�
�l�a� �s�o�s�t�a� �d�i� �u�n'o�r�a�,� �p�e�r� �c�o�n�c�e�d�e�r�g�l�i� �d�i�
�r�i�p�o�s�a�r�e - �f�i�n�o� �a�l�l'e�s�a�u�r�i�m�e�n�t�o�;� �e� �q�u�e�s�t�o�
�i�n�d�u�s�s�e� �q�u�e�l� �c�e�l�e�b�r�e� �d�i�f�e�n�s�o�r�e� �a� �n�o�n�
�o�l�t�r�e�p�a�s�s�a�r�e� �l�a� �m�e�z�z�a�n�o�t�t�e�.� �F�u�i� �s�o�d�d�i�s�f�a�t�t�o�
�d�i� �q�u�e�l�l�a� �d�e�c�i�s�i�o�n�e�,� �p�e�r�c�h�é� �i�l� �f�a�t�t�o� �c�h�e�
�i�l� �P�r�e�s�i�d�e�n�t�e� �n�o�n� �v�o�l�e�s�s�e� �t�o�g�l�i�e�r�e� �l�a� �p�a�r�o�l�a�
�a�n�c�h�e� �a� �c�h�i� �p�a�r�l�a�v�a� �t�r�o�p�p�o� �m�i� �c�o�n�v�i�n�s�e� �c�h�e�
�l�a� �C�o�r�t�e� �a�v�r�e�b�b�e� �r�i�g�e�t�t�a�t�o� �t�u�t�t�i� �i� �r�i�c�o�r�s�i�.�
�R�e�s�t�a� �s�o�l�o� �d�a� �a�g�g�i�u�n�g�e�r�e� �c�h�e� �l'E�n�e�l� �a�v�e�v�a�
�a�n�t�i�c�i�p�a�t�o� �a� �m�o�l�t�i� �t�r�a� �i� �f�a�m�i�l�i�a�r�i� �d�e�l�l�e�
�v�i�t�t�i�m�e� �a�v�e�n�t�i� �d�i�r�i�t�t�o� �a�l� �r�i�s�a�r�c�i�m�e�n�t�o� �d�e�l�
�d�a�n�n�o� �l�a� �s�o�m�m�a� �d�i� �d�i�e�c�i� �m�i�l�i�a�r�d�i� �d�i� �l�i�r�e�,�
�a�s�s�i�c�u�r�a�n�d�o�s�i� �p�e�r�a�l�t�r�o� �i�l� �d�i�r�i�t�t�o� �d�i� �r�i�v�a�l�s�a�
�n�e�i� �c�o�n�f�r�o�n�t�i� �d�e�g�l�i� �a�l�t�r�i� �c�o�r�r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�,� �e�
�c�i�o�è �l�a� �M�o�n�t�e�d�i�s�o�n�,� �s�u�b�e�n�t�r�a�t�a� �a�l�l�a� �S�a�d�e�,�
�e� �l�o� �S�t�a�t�o�.� �L�a� �m�a�g�g�i�o�r�a�n�z�a� �a�v�e�v�a� �i�n�f�a�t�t�i�
�a�c�c�e�t�t�a�t�o� �r�i�s�a�r�c�i�m�e�n�t�i� �m�o�d�e�s�t�i�,� �f�a�c�e�n�d�o�
�p�r�o�p�r�i�a� �u�n�a� �v�e�c�c�h�i�a� �m�a�s�s�i�m�a� �d�i� �e�s�p�e�r�i�e�n�z�a�:�
�p�o�c�h�i�,� �m�a�l�e�d�e�t�t�i�,� �m�a� �s�u�b�i�t�o�.� �M�a� �l�a�
�c�o�n�t�r�o�v�e�r�s�i�a� �c�i�v�i�l�i�s�t�i�c�a� �r�e�l�a�t�i�v�a� �a�l�l�a�
�r�i�p�a�r�t�i�z�i�o�n�e� �d�e�l�l'i�n�t�e�r�o� �o�n�e�r�e� �r�i�s�a�r�c�i�t�o�r�i�o�
�f�r�a� �i� �t�r�e� �s�o�g�g�e�t�t�i� �o�b�b�l�i�g�a�t�i - �l�o� �S�t�a�t�o�,� �l�a�
�M�o�n�t�e�d�i�s�o�n� �e� �l'E�n�e�l - �r�e�s�t�a�v�a� �s�e�m�p�r�e� �i�n�s�o�l�u�t�a�,�
�a�n�c�h�e� �p�e�r�c�h�é� �l�o� �S�t�a�t�o�,� �c�o�m�e� �a�b�b�i�a�m�o�
�v�i�s�t�o�,� �a�v�e�v�a� �d�u�e� �p�a�r�t�i� �i�n� �c�a�u�s�a�.� �E� �s�i è
c�o�n�c�l�u�s�a� �s�o�l�t�a�n�t�o�,� �i�n�c�r�e�d�i�b�i�l�e� �a� �d�i�r�s�i�,� �a�
�d�i�s�t�a�n�z�a� �d�i� �d�e�c�e�n�n�i�,� �t�r�a� �i�l� �1�9�9�9� �e� �i�l� �2�0�0�0�,�
�g�r�a�z�i�e� �a�l�l'i�n�t�e�r�v�e�n�t�o� �d�e�c�i�s�i�v�o� �d�i� �G�i�u�l�i�a�n�o�
�A�m�a�t�o�,� �p�r�e�s�i�d�e�n�t�e� �d�e�l� �C�o�n�s�i�g�l�i�o�.� �L�a�
�s�o�l�u�z�i�o�n�e� �f�u� �s�a�l�o�m�o�n�i�c�a�:� �u�n� �t�e�r�z�o� �a� �c�i�a�s�c�u�n�o�
�d�e�i� �t�r�e� �s�o�g�g�e�t�t�i� �c�i�v�i�l�m�e�n�t�e� �o�b�b�l�i�g�a�t�i�.� �E�
�c�o�sì� �i�l� �C�o�m�u�n�e� �o�t�t�e�n�n�e�,� �s�i�a� �p�u�r�e� �c�o�n� �u�n�
�r�i�t�a�r�d�o� �t�u�t�t�o� �i�t�a�l�i�a�n�o�,� �i� �m�i�l�i�a�r�d�i� �c�h�e� �g�l�i�
�s�p�e�t�t�a�v�a�n�o�.�
�P�e�r� �q�u�e�l�l�o� �c�h�e� �h�o� �f�a�t�t�o� �i�n� �q�u�e�s�t�a� �b�a�t�t�a�g�l�i�a�
�p�r�o�c�e�s�s�u�a�l�e�,� �c�h�e� �r�e�s�t�a� �l�a� �più� �d�i�f�f�i�c�i�l�e�
�d�e�l�l�a� �m�i�a� �v�i�t�a�,� �m�i è s�t�a�t�a� �c�o�n�f�e�r�i�t�a�,� �n�e�l�l�a�
�s�a�l�a� �c�o�n�s�i�l�i�a�r�e� �d�e�l� �C�o�m�u�n�e� �d�i� �L�o�n�g�a�r�o�n�e�,� �i�l�
�9� �o�t�t�o�b�r�e� �2�0�0�3�,� �a� �4�0� �a�n�n�i� �d�a�l�l�a� �s�t�r�a�g�e�,� �l�a�
�c�i�t�t�a�d�i�n�a�n�z�a� �o�n�o�r�a�r�i�a�,� �a�l�l�a� �p�r�e�s�e�n�z�a� �d�e�l�
�p�r�e�s�i�d�e�n�t�e� �C�i�a�m�p�i�,� �c�o�n� �l�a� �s�e�g�u�e�n�t�e�
�m�o�t�i�v�a�z�i�o�n�e�:� «�P�e�r� �l�a� �l�u�n�g�a�,� �g�e�n�e�r�o�s�a�
�e� �p�r�o�f�i�c�u�a� �o�p�e�r�a�,� �c�o�n�d�o�t�t�a� �p�e�r� �o�l�t�r�e�
�t�r�e�n�t'a�n�n�i� �c�o�m�e� �l�e�g�a�l�e� �d�e�l� �C�o�m�u�n�e� �d�i�
�L�o�n�g�a�r�o�n�e� �n�e�i� �p�r�o�c�e�d�i�m�e�n�t�i� �g�i�u�d�i�z�i�a�r�i�
�c�o�n�s�e�g�u�e�n�t�i� �a�l� �d�i�s�a�s�t�r�o� �d�e�l� �V�a�j�o�n�t�,� �o�p�e�r�a�
�c�o�n�d�o�t�t�a� �c�o�n� �g�r�a�n�d�e� �i�m�p�e�g�n�o� �e� �p�a�s�s�i�o�n�e� �i�n�
�d�i�f�e�s�a� �d�e�l�l�a� �m�e�m�o�r�i�a� �d�e�l�l�e� �V�i�t�t�i�m�e�,� �v�o�l�t�a�
�a�l�l�a� �s�o�d�d�i�s�f�a�z�i�o�n�e� �d�e�l�l'e�s�i�g�e�n�z�a� �d�i� �v�e�r�i�t�à�
�e� �d�i� �g�i�u�s�t�i�z�i�a� �d�e�l�l�a� �c�o�m�u�n�i�t�à� �s�u�p�e�r�s�t�i�t�e�,�
�e� �c�o�n�t�i�n�u�a�t�a� �p�o�i� �n�e�l� �p�r�e�z�i�o�s�o� �a�i�u�t�o� �f�o�r�n�i�t�o�
�a�l� �C�o�m�u�n�e� �n�e�l�l�a� �d�e�l�i�c�a�t�a� �c�o�n�c�l�u�s�i�v�a� �f�a�s�e�
�d�e�g�l�i� �a�c�c�o�r�d�i� �t�r�a�n�s�a�t�t�i�v�i� �i�n�t�e�s�i� �a� �r�i�s�a�r�c�i�r�e�
�L�o�n�g�a�r�o�n�e� �d�e�i� �d�a�n�n�i� �s�u�b�i�t�i�»�.��
�È �s�t�a�t�o� �u�n� �g�i�o�r�n�o� �d�i� �c�o�m�m�o�z�i�o�n�e�,� �m�a�,� �p�e�r�
�a�r�r�i�v�a�r�e� �a� �u�n�a� �g�i�o�r�n�a�t�a� �d�i� �l�u�c�e�,� �s�o�n�o� �s�t�a�t�e�
�n�e�c�e�s�s�a�r�i�e� �t�r�o�p�p�e� �g�i�o�r�n�a�t�e� �d�i� �o�m�b�r�a� �c�u�p�a�.�
M�a�i� �d�i�s�a�s�t�r�o� �e�r�a� �s�t�a�t�o� �t�a�n�t�o� �u�m�a�n�a�m�e�n�t�e� �e�
�c�h�i�a�r�a�m�e�n�t�e� �p�r�e�v�i�s�t�o�:� �e� �i�l� �f�a�t�t�o� �c�h�e� �s�i�a�n�o�
�o�c�c�o�r�s�i� �a�n�n�i� �ed� �a�n�n�i� �p�e�r�c�h�é� �u�n�a� �p�u�n�i�z�i�o�n�e�
�i�r�r�i�s�o�r�i�a� �r�a�g�g�i�u�n�g�e�s�s�e� �a�l�c�u�n�i� �t�r�a� �i�
�c�o�l�p�e�v�o�l�i� �e� �t�r�e�n�t'a�n�n�i� �d�i� �l�i�t�i� �p�e�r� �c�h�i�u�d�e�r�e�
�t�u�t�t�i� �i� �r�i�s�v�o�l�t�i� �c�i�v�i�l�i�s�t�i�c�i� �a�c�c�r�e�s�c�e�,� �s�e�
�p�o�s�s�i�b�i�l�e�,� �l�a� �g�r�a�v�i�t�à� �d�e�l�l�a� �t�r�a�g�e�d�i�a.
(�U�n�a)� �c�o�n�c�l�u�s�i�o�n�e
�H�o� �n�a�r�r�a�t�o� �u�n�a� �s�t�o�r�i�a� �c�h�e� �n�o�n� �r�i�g�u�a�r�d�a�
�s�o�l�t�a�n�t�o� �u�n�a� �v�i�c�e�n�d�a� �g�i�u�r�i�d�i�c�a�,� �m�a� �p�a�r�l�a�
�d�e�l�l'I�t�a�l�i�a�,� �d�e�i� �s�u�o�i� �d�r�a�m�m�i� �c�h�e� �s�i� �r�i�p�e�t�o�n�o�
�s�e�m�p�r�e�,� �e� �c�o�n� �l�a� �s�t�e�s�s�a� �i�n�t�e�n�s�i�t�à�,� �i�n�
�d�i�v�e�r�s�i� �s�e�t�t�o�r�i�,� �a�n�c�o�r�c�h�é� �s�e�n�z�a�
�e�s�c�l�u�s�i�o�n�e� �d�e�l�l�a� �p�o�s�s�i�b�i�l�i�t�à� �d�i�
«�m�i�r�a�c�o�l�i».� �I�l� �c�h�e� �s�i� �v�e�r�i�f�i�c�a� �o�g�n�i� �q�u�a�l�
�v�o�l�t�a� �p�o�c�h�i� �u�o�m�i�n�i� �o�n�e�s�t�i� �r�i�e�s�c�a�n�o� �a�
�s�t�a�b�i�l�i�r�e�,� �s�i�a� �p�u�r�e� �c�o�n� �m�o�l�t�a� �f�a�t�i�c�a�,� �u�n�
�e�q�u�i�l�i�b�r�i�o�,� �p�e�r�a�l�t�r�o� �a�s�s�a�i� �i�n�s�t�a�b�i�l�e.
�L'I�t�a�l�i�a� �r�e�s�t�a�,� �c�o�m�u�n�q�u�e�,� �u�n�o� �S�t�a�t�o� �n�e�l� �q�u�a�l�e�
�o�g�n�i� �t�a�n�t�o� �b�i�s�o�g�n�a� �c�a�m�b�i�a�r�e� �q�u�a�l�c�o�s�a�
�p�e�r�c�h�é� �t�u�t�t�o� �r�e�s�t�i� �c�o�m�e� �p�r�i�m�a�.� �M�i� �s�i�a�
�c�o�n�s�e�n�t�i�t�o� �d�i� �r�i�c�o�r�d�a�r�e� �l�a� �c�o�n�c�l�u�s�i�o�n�e� �d�e�l�l�a�
�m�i�a� �a�r�r�i�n�g�a� �i�n� �p�r�i�m�o� �g�r�a�d�o� �d�a�v�a�n�t�i� �a�l�
�T�r�i�b�u�n�a�l�e� �d�e� �L'A�q�u�i�l�a�,� �c�h�e� �p�o�i� �m�i� �d�e�t�t�e�
�r�o�v�i�n�o�s�a�m�e�n�t�e� �t�o�r�t�o�:�
«�...Q�u�e�s�t�i� �e�s�s�e�n�d�o� �i� �f�a�t�t�i�,� �i�o� �c�r�e�d�o� �d�i�
�p�o�t�e�r� �a�f�f�e�r�m�a�r�e� �c�h�e� �u�n�a� �s�o�c�i�e�t�à� �e� �u�n�o�
�S�t�a�t�o� �c�h�e� �a�s�s�o�l�v�e� �c�o�s�t�o�r�o�,� �p�r�o�n�u�n�c�i�a� �c�o�n�t�r�o�
�s�e� �s�t�e�s�s�o� �l�a� �più� �d�u�r�a� �e�d� �i�n�e�s�o�r�a�b�i�l�e�
�s�e�n�t�e�n�z�a� �d�i� �c�o�n�d�a�n�n�a�.� �N�o�n� �f�a�r�ò� �r�e�t�o�r�i�c�a�
�n�e�l� �f�i�n�a�l�e� �p�e�r�c�h�é� �r�i�t�e�n�g�o� �c�h�e� �s�a�r�e�b�b�e�
�o�f�f�e�n�s�i�v�o� �p�e�r� �l�a� �m�e�m�o�r�i�a� �d�e�i� �m�o�r�t�i�.� �V�o�r�r�e�i�
�s�o�l�o� �r�i�c�o�r�d�a�r�e� �c�h�e�,� �i�n� �u�n�a� �p�a�g�i�n�a� �n�o�n�
�d�i�m�e�n�t�i�c�a�t�a�,� �C�r�o�c�e� �s�c�r�i�s�s�e� �c�h�e� �n�o�i� �n�o�n�
�p�o�s�s�i�a�m�o� �n�o�n� �s�e�n�t�i�r�c�i� �c�r�i�s�t�i�a�n�i�.� �A� �q�u�e�s�t�o�
�p�e�n�s�a�v�a�,� �r�i�c�o�r�d�a�n�d�o� �l'i�n�i�z�i�o� �d�e�l� �V�a�n�g�e�l�o� �d�i�
�G�i�o�v�a�n�n�i�,� �n�o�n� �n�e�l�l�a� �t�r�a�d�u�z�i�o�n�e� �d�i� �S�a�n�
�G�i�r�o�l�a�m�o�,� �c�h�e� �t�a�n�t�e� �v�o�l�t�e� �a�b�b�i�a�m�o� �s�e�n�t�i�t�o�,�
�m�a� �n�e�l�l'o�r�i�g�i�n�a�r�i�o� �t�e�s�t�o� �g�r�e�c�o�,� �i�l� �s�o�l�o� �c�h�e�
�d�i�a� �i�l� �v�e�r�o� �s�e�n�s�o� �d�i� �u�n�a� �p�r�o�d�i�g�i�o�s�a�
�i�n�t�u�i�z�i�o�n�e�.� �S�o�l�o� �l�a� �l�i�n�g�u�a� �g�r�e�c�a� �r�e�n�d�e�
�a�d�e�g�u�a�t�a�m�e�n�t�e� �i�l� �c�o�n�c�e�t�t�o�,� �c�h�e� �p�u�ò� �e�s�s�e�r�e�
�c�o�sì� �e�n�u�n�c�i�a�t�o�:� �a�l�l'i�n�i�z�i�o� �e� �a� �s�o�s�t�e�g�n�o�
�d�i� �t�u�t�t�o� �v�i è l�a� �c�a�p�a�c�i�t�à� �r�a�z�i�o�c�i�n�a�n�t�e�
�d�e�l�l'u�o�m�o�,� «�i�l� �l�o�g�o�s»;� �m�a� �s�e� «�i�l�
�l�o�g�o�s» �n�o�n è a�s�s�i�s�t�i�t�o� �d�a� �u�n�a� �v�o�l�o�n�t�à�
�m�o�r�a�l�e� �o� �r�e�l�i�g�i�o�s�a - �s�o�s�t�a�n�z�i�a�l�m�e�n�t�e�
�e�q�u�i�v�a�l�e�n�t�i - �c�h�e� �l�o� �s�o�s�t�e�n�g�a� �e� �l�o� �i�s�p�i�r�i�,�
�s�o�l�o� �s�e� �l�a� �S�a�p�i�e�n�z�a� �d�i�v�e�n�t�a� �D�i�o�,� �l'u�m�a�n�i�t�à�
�s�a�r�à� �s�a�l�v�a�.�
�I�n� �q�u�e�s�t�o� �s�e�n�s�o� �l�a�
�s�e�n�t�e�n�z�a� �c�h�e� �v�i� �p�r�e�p�a�r�a�t�e� �a�d� �e�m�e�t�t�e�r�e è u�n�a�
�s�e�n�t�e�n�z�a� �r�e�l�i�g�i�o�s�a�»
�L�e� �f�o�l�l�i�e�
�t�e�c�n�i�c�h�e� e �s�e�n�z�a� �v�o�l�o�n�t�à� �m�o�r�a�l�e� �d�e�i� �n�o�s�t�r�i�
�t�e�m�p�i� �m�i� �r�e�n�d�o�n�o� �o�r�g�o�g�l�i�o�s�o� �d�i�
�q�u�e�l�l'i�n�a�s�c�o�l�t�a�t�a� �c�o�n�c�l�u�s�i�o�n�e�.�
(Trovi questa TESTIMONIANZA nella sua pagina ORIGINALE)
Ritagli di giornali, libere opinioni, ricerche e testi di:
Tiziano Dal Farra (se non diversamente specificato o indicato nel corpo della pagina) Problemi col sito?
Dissensi? Commenti?
Informazioni?
Scrivimi,
oppure

|

|