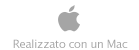Toni Sirena*
In quanti modi si può raccontare il Vajont, ammesso che lo si possa raccontare? Come si può dire il grumo di orrore, di lutti, di morte, di ingiustizia? Prima un lungo silenzio, annichilito dall'enormità del fatto...
Poi la stura al racconto, quasi una catarsi. Quanti Vajont esistono? L'ansia di recuperare la memoria si e trasformata in urgenza di raccontare. Lo si è fatto con i registri dell'inchiesta, del monologo, della testimonianza, del verbale, della sentenza, della cronaca, della transizione scientifica, della relazione burocratica, della
poesia, dell'iconografia. Saluti da Longarone. Abbiamo detto, abbiamo fatto. Io ero qui, lui era lì. Lampo,
nube, tuono. Il vento, l'acqua, il rombo. Come mille vagoni impazziti. L'alba livida. Gli elicotteri. Gli alpini. Il silenzio. La cronaca, il ricordo. Memorie frantumate, disperse, come i duemila morti. Frammenti d memoria, che non costruiscono però un quadro unitario.
Per questo c'è voluto il teatro, c'è voluto il cinema, la poesia. Il Vajont ha avuto, in parte e tardi, un suo risarcimento solo così.
Come variazioni di stile di Queneau. Lo stesso fatto raccontare più e più volte, su registri diversi. E così il medesimo fatto trasfigura, cambia i connotati. Talvolta rischiando il grottesco o il comico. Ma quello di Queneau era un fatto di banalità quotidiana. Ma si può raccontare, e come, l'enormità del Vajont? Quante volte lo si può raccontare, e perché c'è bisogno, ancora, di raccontare? Perché questa urgenza che preme dentro? Raccontare è risarcire, è esorcismo. Risarcire è far rivivere. E far rivivere è, da un lato, terapia del racconto, dall'altro è dare una chance di vita a chi la vita l'ha avuta spezzata, interrotta. I morti del Vajont, i nostri morti, sono così ancora vivi. Non a caso, nella notte dei tempi, la storia inizia e coincide con l'attività del raccontare, con la poesia, con il canto. Per questo raccontare ha che fare, strettamente, con la dimensione del sacro.
Per questo il racconto del Vajont non può che essere un racconto al condizionale. Un condizionale subordinato. Raccontare il Vajont è avere, sempre, come orizzonte di riferimenro, ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Ciò che sarebbe potuta diventare Longarone, e con Longarone le 1911 vite, una ad una, spezzate. Quel vecchio, quella donna, quel bambino, quale destino avrebbero avuto, quale vita, quali gioie, quali dolori, se non ci fosse stato il Vajont? Un orizzonte, un destino inespresso, ma sempre, in tutti i racconti, concretamente, dolorosamente, presenti.
Per Pittarello il raccontare è un'attività legata al sacro. Non alla cronaca, appunto, ma alla poesia. Se «i ricordi appartengono al tempo, e il tempo muore, allora non è accaduto niente». La chiave di lettura è, appunto, qui. No, non era una lotteria dove è uscito il 1911, al contrario sono 1911 volte la vita e la morte di una persona. E la memoria è un modo per riannodare i fili della vita.
«La potenza della tecnica, l'emozione della luce»: la retorica dello sviluppo (quale sviluppo?). Hanno cercato di convincerci, i rètori della tecnica, fin dal giorno dopo che era un prezzo da pagare. O la punizione, magari di qualche dio pagano, per la superbia umana. Il profitto, il mercato, promosso a dio regolatore, l'orrore a fin di bene. E così la notte della morte trasfigura in un racconto dell'Apocalisse dove, in assenza di un giustificabile-giustificato motivo terreno, umano, si cerca affannosamente un imprescrutabile senso divino. Al dio della pietà si sovrappone il dio sterminatore.
In quanti modi si può raccontare il Vajont? Pittarello fa parlare i poveri morti, ma anche gli uomini della diga, i padroni della luce, le voci che hanno cercato di fermare il Vajont. È come un romanzo polifonico, quello di Pittarello. Parlano i protagonisti, e magari si pentono. Ma ormai «il tempo è scaduto». C'è un senso di ineluttabile, nel «costruirsi» del Vajont. Ineluttabile perché ciò che è stato è stato. E andata così. Ma davvero tutto ciò che è tale è razionale? Eppure, c'era «una voce che poteva fermare il Vajont».
Fermare la storia? E possibile, ma solo con la poesia. Di fronte alla ragione impazzita, ognuno di noi cerca di non sapere. Ma Pittarello, crudele nella sua 'pietas', scioglie l'enigma del disastro nella certezza di una restituzione: perché la storia non può rimanere in sospeso.
[Toni Sirena è il figlio di Merlin Costantina (Tina), la "voce che poteva fermare - per tempo, se diffusa all'opinione pubblica del Paese - il Vajont"]
Dino Bridda
Le memorie del Vajont non sono ancora scritte tutte, nemmeno si sono esaurite, forse l'operazione non si compirà mai del tutto. Alcune di quelle parole rimarranno chiuse per sempre dentro chi visse quella tragedia. Altre, pian piano, riaffiorano a fatica, forse anche per raccontare ciò che altri tacciono per un personale pudore che, comunque sia, va rispettato e compreso.
Una cosa è certa: per molti è passato il tempo del silenzio dettato dalla paura di esorcizzare quel teatro di morte. Se ne parla sempre di più, rischiando magari la babele delle parole, però, tutto sommato, parlarne diffusamente fa bene a tutti. Quella paura ci accompagnò per anni, quando solo pochi portavano addosso il coraggio della verità, mentre la maggior parte di noi possedeva solo un debole dubbio, un'incertezza che ci costò cara, perché rischiò di accomunarci moralmente nella correità con chi agì nel più totale disprezzo della vita umana inseguendo le false sirene di un falso progresso.
Nel nuovo coro di chi non teme la parola sferzante, intrisa di accertata verità, si sta muovendo da tempo Bruno Pittarello, autore di altri precedenti lavori sul Vajont e portatore di una memoria familiare che nessun tempo potrà mai cancellare.
Che cosa lo ha spinto, questa volta, a raccontarci il «suo» Vajont? Un civilissimo e nobile desiderio di testimonianza, senza dubbio: superati certi silenzi, gravati di comprensibile smarrimento, sgorgano dalla memoria e dal cuore immagini e concetti che premono con violenza alle pareti dell'anima per uscire allo scoperto, per farsi sentire, per vedere riconosciuto il loro diritto di cittadinanza in quel grande e variegato libro che è la memoria collettiva del 9 ottobre 1963.
Le parole, molto spesso crude e inequivocabili, si presentano una dietro l'altra come una naturale sequenza che dà, insieme, respiro e forza ai pensieri per esplodere, qua e là, in atti d'accusa pesanti come macigni.
Allora le parole stesse danno corpo a una narrazione quasi teatrale, una sorta di incalzante drammaturgia tanto più efficace quanto più ripete, sin quasi allo spasimo, tutto l'orrore di quella immane tragedia.
L'autore, a quel punto, è un attore che recita il suo monologo sul palcoscenico.
Ma questa, si badi bene, non è finzione teatrale, è storia vera ed accaduta. Il palcoscenico non sta dentro un teatro, è invece allestito sopra la scena della storia, sulla piana del Piave, oppressa dalla presenza funesta e incombente della diga mutilata e del monte Toc. L'autore-attore, il monologhista insistente e caparbio, non ha bisogno di recitare, gli basta soltanto fare andare il film dei ricordi e lasciar parlare la sua sensibilità. Allora il gioco del narrare è fatto.
Lo snodarsi di questa drammaturgia monologante non concede attimi di respiro. Ed è bene che sia così. La tragedia del Vajont non può concedere tregue a nessuno, il dovere di ricordare assale tutti noi, ciascuno per la sua parte di competenza e di responsabilità. L'incalzare del racconto deve farci male dentro, come una spada che martirizza la ferita, perché ne siamo stati immuni per troppo tempo...
C'è poi, in questo incessante e tumultuoso narrare di Bruno Pittarello, una sorta di modalità comunicativa ancestrale rivelata dal continuo richiamo ad antiche saghe popolari che ancor oggi occupano le radici della nostra cultura. Un richiamo che si materializza in ripetute visioni di individui cari - perché appartenenti alla comunità storica del narrante - che si muovono come spettri in un groviglio tormentante di morti già sepolti e uccisi una seconda volta (o piu' volte, in seguito); di uomini e donne falciati nel sonno di una tranquilla notte d'autunno, d bambini mai nati e ammazzati nel grembo materno prima di conoscere la vita. E' una grande saga popolare
che, come accade in molte antiche culture sia mediterranee che nordiche, sembra paragonare il 9 ottobre 1963 di Longarone e dintorni alla notte nella quale, nella credenza dei nostri antenati, i defunti ritornano sui luoghi della loro esistenza terrena, non certo per spaventarci, quanto per ammonirci.
Nel vagheggiamento onirico dell'autore, che si fa meditazione ad alta voce in un crescendo di emozioni sconquassanti, quei morti tornano ad ammonirci, ma senza parole o gesti, bensì soltanto svelando ai nostri occhi la loro condizione di vittime così come apparve ai primissimi soccorritori.
A quel punto le parole si fanno immagine e le immagini parlano il linguaggio della pietà. Bruno Pittarello, attraverso la sua personale rivisitazione della tragedia, dipinge alla perfezione un quadro muto e fermo, ma che sembra esplodere, da un momento all'altro, in un grande fragore. È il fragore della ribellione contro un misfatto che ci offende tutti, umanamente e civilmente. Questo libro è un ordigno a tempo, può esplodere solo se, ad innescare il detonatore, è il lettore che ne ha compreso appieno il significato e lo condivide.
TOC TOC. Duplice, triste, ironia di un nome che parla di sbriciolamento della roccia e, contemporaneamente, richiama il suono di un avvertimento.
Quella notte - non ce ne eravamo accorti - quel monte aveva bussato alle porte della nostra coscienza.
Magari tardi, ma fortunatamente ce ne stiamo accorgendo sempre
di più.

|
Nota sull'autoreLe mie parole sul tardi della sera come un diario per parlarti. L'aria nera sulla pista del buio. Dicono che i ricordi appartengono al tempo. E il tempo muore. Forse così non è accaduto niente. E allora perché saperne di più? La storia non è felice, si allontana, s nasconde. Che cosa resta della memoria se non gli sgoccioli di un errore, più nulla. Eppure c'è un fatto orrendo affumicato da tante parole: era improbabile, era imprevedibile, era prevedibile; era una lotteria. Allora se era una lotteria il numero è uscito: 1911. E sono i morti nella cornice della sera. Più che mai le parole chiedono i margini della storia costruita sul fango, sulle briciole o su niente. Il tempo è passato, oblio non c'è. L'autunno con le sue sere si ripete nella scia del massacro numerando i morti. Erano tanti. Anni bruciati a ricostruire i miei morti, ad ammorbidire terrore e crolli, troppo tardi per iniziare a dimenticare. La storia si ostina a rimanere e tutti ancora ne parlano. La tabula rasa della geografia sullo spazio e sul tempo appartengono all'anima, le immagini coincidono pur con le contraddizioni della ricostruzione. Terra e acqua ne sono la visione e l'enigma. Terra e acqua nei fili della memoria, grigi e neri del paese macerato, affiorante e impalpabile. Accarezzi le pietre, le impronte, le mani o i capelli, riprendi le voci, ritrovi i campi e i prati. Ma lo spazio si annebbia e si disfa. Così va solitario e capriccioso l'assedio dei ricordi.
Parlavano dell'affare diga nelle segrete stanze con taciti consensi. E rapidamente la diga si assestò tra montagna e montagna e l'acqua prigioniera ne rimirava lo splendore. Ma la montagna era tutta rattoppata sotto il vestito di pini. I gorghi del lago le bagnavano i piedi con il monotono quotidiano fastidio. Brontolio e ruggito delle pietre. Si poteva parlare esterrefatti di opera fallita, di minaccia, di rovina economica, di progetto deluso. Sto rifacendo i piani, misuro gli studi e le speculazioni, vivo le vicende, cerco se c'è o non c'è l'errore. Ma scaduto è il tempo oramai e tutto è pronto, per morire. Il vecchio angelo vestito di nero ha falciato l'ultimo prato della mia vita e con la sapienza dei millenni spegne la luce del giorno, per morire. L'azzurro del cielo è più terso che mai e la luna gioca dietro la montagna. L'ultimo treno è passato, anche il vento se ne è andato. Preme il vecchio angelo vestito di nero: scaduto è il tempo oramai e il cielo è tutto in fiamme. Così, frantumate le case, morti gli uomini, il tempo crudele mi attende sopra i frammenti.
Tacciono i paesi sciolti nell'acqua, non ci sono parvenze di movimento, di parole, di miracoli, di finestre di luce. Il suono è la voce stanca dell'acqua che si dilegua. Non troverò più la mia città che si è spogliata dei suoi quartieri per fuggire lungo il Piave. Il fiume ha lavato il sangue dei corpi, ha coperto di polvere di fango la pelle bianca dei cadaveri per nascondere alla luna le piaghe e lo scempio. La voce della morte addormenta la piana e tutto sembra riposare. Non ho più trovato la mia città con le sue labbra d'amore, le sue notti di voluttuosa musica; perduti gli occhi, le mani, il profumo della memoria. E' sparita la lampada di Aladino per far tornare mura, finestre, porte di casa, il piacere dei vivi e delle antiche strade. Giunge invece il fantasma dei perché e dorme qui, su questa pagina, frammento del tempo di Longarone, un piccolo disegno a matita che ogni giorno il sole piano piano evapora e si porta via. Così resta il mio panorama di sole vecchie montagne che imprigionano il fiume e la fantasia. E la voce de pettirossi mi fa scivolare fuori dagli affanni.
Sosta l'acqua nel bacino, impellente, vaso chiuso di Pandora. L'esile filo che la collega alla centrale ne è il respiro e l'incessante energia. Nella centrale le sue urla sono la potenza della tecnica e l'emozione della luce nelle nostre case. La diga non ha sentimenti, impietosa, appartata, superba nella forra dimenticata. La sua nudità di bianco cemento divarica le montagne, ne trema l'ambiente. Viene dal suo lago un vento freddo, irregolare con nebbie selvagge e troppo umide. L'ingombro della diga nella notte è un ombra nera, priva di concretezza, affabile per il silenzio. Infatti non ha voce la diga ne di giorno ne di notte. Ma quel polmone di cemento e ferro nella schiuma del mattino mostra i segni indelebili sul declivio della montagna.
TOC TOC. Naufraga il sasso dentro il bacino.
TOC TOC e i sassi gonfiano l'onda cadendo. Così un giorno è venuta la morte dalla vacillante montagna. E la morte con i suoi denti ha grattato tutta la valle annegando i cadaveri in una enorme bara d'acqua. Sento lontano, tanto lontano il canto di un violino e le campane mosse dal vento e il latrare continuo dei cani. Qui cresce il pianto, cresce solo la morte e le acque si vestono di fango.Le pietre color ocra dei palazzi abbattuti e la carne rosea dei morti. Disperazione senza pianto o grida, vagando sopra l'odore del fango. Parole maledette e gesti di pietà, mentre la vita e la morte alle sponde della valle si tengono per mano. Ovunque segnali d forme umane di morti dilaniati e levigati dall'onda. Tra le pietre tento di accarezzare i cadaveri dei miei amici, anch'io ho bisogno di pietà. Tutto è di Dio ora, anche questo nulla di macerie.
Nuda e leggera dorme la montagna silenziosa, cullata dal cielo, dalle stelle, dai pianeti. È questo il momento di misurare il desiderio appagando i venti e gli uragani dell'anima. Non c'è tempo a fabbricare ulteriori sogni, a tessere una nuova méta. Tutto si confonde nella notte. Lì tutti gli occhi sono spenti e l'aria accarezza le torme dei monti solide e stabili.
Ma il midollo del monte Toc non regge gli equilibri delle nude rocce e le profonde radici che legano pietra a pietra sono spezzate dalla febbre dell'acqua. I gangli e le vene dei lastroni non dormono, non dormono gli alberi del bosco accovacciati sul pendio. Muggiscono nelle stalle del Col delle Spesse, di Pineda e San Martino, di Ceva Savèda e Prada le vacche e non è l'ora della mungitura o del fieno; è sordida la lotta tra roccia e acqua. La luna fantastica turca la valle ed entra nella notte di un cielo minuscolo e insonne. Le architetture dei paesi sono palazzi moribondi, l'orologio continua la sua corsa. Ma giunge l'ora stabilita e il tempo finisce. Il Toc lascia la fessura, scende, si scatena contro le spallette della diga e si siede nel lago. La notte precipita nel vento del dolore e un sudario di fango morde e avvolge.
Io sono qui sulla riva del fiume, nudo. L'acqua mi ha spogliato, le onde mi trapassano, l'uragano di fango giallo fa ballare tutti morti. Sciami di case urlano davanti il cielo, agonizzano tronchi di legno che erano tetti e strutture portanti. Un Cristo rotola nella terra: ha perso la croce e le braccia. Nude mandrie di vacche statiche quasi antiche statue del Piave. Gli abiti dei morti foglie appassite. Bambini spenti singhiozzano dentro i rovi, mulinelli di mani tagliate sull'arena, avanzano donne decapitate che ancora piangono, torsi di vecchi come soldati colpiti a morte. Coltelli, bisturi, spade di pietra uccidono i delicati corpi. Carne, capelli, occhi raschiano il Piave e gemono. Sulle balaustre di marmo e sassi i morti si tengono per mano, la terra si offre come un cimitero. Si spegne la notte dentro il fiume. Agonia, solamente agonia e la luna sgrana terrore fino al mare.
La mia casa odora di calce, come tutta la piazza di Pirago.
Fischia col vento il treno alla solita ora prevista nello spazio rettilineo della strada ferrata, prima della galleria. Il vento assale gli alberi del colle e precipita nella valle. La terra sa d'autunno, lo spazio ha colori che amo. Il vento mi accompagna, immobile il cielo nell'infinito anfiteatro. Sulle sabbie del Piave cerco il mare e i sogni. La distesa di ciottoli non finisce mai. Paesi intorno adagiati come pezzi di marmo che all'improvviso diventano città piene di giardini, di piazze, di uomini. Sulle rive del Piave si alzano le foglie come uccelli che fuggono e il vento si diverte come sempre. Vacillanti foglie d'autunno, sottili, e gli alberi si spogliano con poco rumore. Il vento non cala e martella il bosco e il sottobosco. Sono silenziosi gli alberi; molti, così spogliati, si notano poco, leggere strutture verticali in solitudine.Una sera d'autunno, tanto tempo fa, questa valle diventò cimitero annegando nei colori del fango. Dall'alto soffiò la morte con l'acqua alzata per forza. Il fiume diventò una bara, rutto dentro nel fiume, inevitabile. Tra le braccia degli alberi i bambini come bambole. Avevano gli ocelli aperti per guardare il vento e le stelle. Alberi vestiti di piccoli esseri umani come foglie gonfiate. E silenzio e morte. Poi l'orrore del giorno. Aspettando i soldati, ho visto il pianto mordere la terra.
Lontano, dove le montagne si fanno anfiteatro, l'insaziabile lupo afferra il timido agnello e lo sbrana: due nuvole sopra la valle rosse come il sangue. Poi il lupo e l'agnello si dissolvono e la sera senza luce, senza splendore appassisce il giorno.
C'era una volta una voce che poteva fermare il Vajont. Ma il lupo era pieno di menzogne e fece fuori l'agnello. Così la voce d una donna contro il disastro non vinse l'inferno. Le sue parole le abbiamo lette su giornali detti sovversivi. Giornale comunista, quando ti leggevo di nascosto, scrutavo la montagna e tu dietro a perseguitarmi, ad accendere le leggende dei monti che ballano e camminano. Se tutti insieme avessimo comperato quei giornali, si poteva vincere la devastante storia.
«Credo signora che lei turbi l'ordine pubblico, qui esiste il paradiso e mille occhi di mercati porteranno la luce e il benessere in capo al mondo». E tu, invece continuavi a scrivere. E la montagna venne giù e il lago fu sotterrato.
Qui comincia il dolore. Il buio si fece più buio. Un soffio e la montagna si accese di vita: con il rumore del vento infranse lo specchio del lago. E poi su, a soffocare la voce del cielo e giù con gli artigli a chiudere il respiro della valle. L'acqua raschiò anche la terra, il fango lasciò solo schegge di vita. Si svegliarono i cimiteri, gli ospedali, più veloce l'alba. L'acqua si prese uomini e case, tutto. I giornali, quei giornali l'avevano detto. Ma il lupo della storia si era mangiato l'agnello e così vinse l'irrealtà. Croci a non finire circondate da mani, da gesti disperati, da fòsse. Il vento accarezzò il dolore, grattò la scorza del pianto e del singulto. La rabbia divenne lamento.
Perché c'era una voce che poteva fermare il Vajont.È tardi, amici, per mandare via la gente, è tardi per chiudere le fabbriche e i bar. È tardi per svuotare le case e le chiese, il bosco e i giardini. La notte porterà giù la montagna come una lama e boschi cammineranno sopra le nostre teste sulla spuma dell'acqua. La luce si infrangerà sulla centrale naufragando. Ma siamo noi il tempo del progresso. La diga non crollerà e neppure una goccia di sangue ci sarà nella valle. Finalmente chiuderemo il conto con le pietre di questa maledetta montagna. Poi ci s lederemo a guardare l'acqua calma sotto il gioco dei nuovi monti.
È proprio l'ora, amici. L'acqua non toccherà la luce di Longarone, laggiù. L'onda morirà dentro il solco del lago come una nuvola che nasce e si dissolve. Noi siamo gli uomini della diga, i padroni dello spazio, della luce, della catastrofe.Maledetta montagna, sappiamo tutto di te. Dopo il tramonto verrai giù finalmente. Ma noi siamo il tempo dell'invenzione e il futuro.
Amici, guardatemi però un momento: sentite questo silenzio? Vedete anche voi i fantasmi che fuggono dalle case degli abitanti e i colori della notte che si confondono con il cielo? Sentite la montagna come vibra? La grande acqua del lago trema per un diluvio universale.
Anche Cristo ora vorrebbe lasciare la chiesa.
Amici miei, io non so pregare, ma chiamo Dio e lui purtroppo non mi risponde. È tardi oramai per...Addio luna piena con il gregge che bela sulle rive del fiume. Addio autunno con le canzoni del vento. Viene il pastore con il nero mantello e tutto è uguale.
Finalmente la notte ha conquistato il mio paese. Lentamente ha demolito le case, ha sgretolato le strade. Gli alberi hanno preso sonno e nel sonno anche il silenzio e gli abitanti. La notte ha aperto lo spazio celeste e le stelle come diamanti sono scese verso la mia terra. Con dolcezza i bambini già sognano l'immenso e l'incredibile, nel silenzio del sonno muovono le parole e parlano con gli amici. Solo gli uomini innamorati resistono al sonno e ascoltano l'anima della notte con labbra che si toccano. Amori intimi e altrove tormenti e rancori. La notte è enorme e percorre tutto il mio paese indossando il vestito nero e arcano. Là, in alto, l'acqua del Vajont respira ma non riposa. Abbiamo visto nascere la diga percossa da infiniti boati e dalla potenza elettrica. Incalza l'ora del buio. E notte da ogni parte oramai e l'oscurità ha diffuso il suo segreto respiro. Ma è strana questa notte che riverbera d brividi e fugge il canto della luna.Ora tutto è pronto e amaro. Così davanti la mia casa ho visto la notte diventare tempesta poi onda furiosa mentre si portava via la vita del paese e la mia infanzia. Il canto dei morti giungeva fino a Dio, mille e mille voci sferzanti come la luce.
Il vento iniziò a gorgogliare sempre più orrendo, più perverso. Poi spalancò il cielo e si prese la terra. La sua polvere illuminò il paese come un lampo. Allora l'acqua simulò il tuono e prese intanto il volto della morte. Dio resse la diga con le sue stesse mani ma l'onda si alzò verso le stelle straziando il paese casa per casa. Entrò nella casa di mio padre e mia madre ma la morte scansò le pareti e le strutture portanti: risparmiò mio padre e mia madre.
Tutto fu perduto dei paesi. La lunga impronta di granito divenne una pista dove correva la memoria e la traccia stupita degli uomini. Il fiume si riempì di corpi, deboli semplici fragili. Anche morti degli antichi sepolcri, scrigni aperti, si dileguarono sulla pista del Piave. Mentre la notte disperata si dissolveva nello spasimo e nello stupore del silenzio.Brivido di luce l'onda e tutto si frantuma, tutto si decompone dentro un fantasma. Ovunque presenze umane stese come discariche di sassi, abbandonate macerie di nudità impalpabili, inconsistenti. Corpi dolci, delicati, rotti, inquietanti, senza valore; corpi bellissimi. Una spiaggia il campo visivo, tutto ridotto a rottame il mio paese con inutili superstiti.
Ora la luce del sole attacca il paesaggio e ogni ricordo è un gioco del tempo non più adoperabile. I segni della storia e della tradizione non ci sono più. Vedo solo morti, morti in vesti succinte o spogliati, senza malizia senza provocazione. Morti rivestiti dalle urla della nostra umanità. Ogni cosa oggi si ricompone nell'itinerario della memoria e diventa storia.
Senza sapere che dovevano morire per un Errore, tutti nudi privi d'identità nel letto buio della morte, verso la luce del Sole. Schizzano via donne, mariti, ragazzi, vecchi. Fabbriche, chiese, automobili stritolano l'infinita serie di campi, di prati, di strade, di piazze. Le strutture di acciaio camminano come fantasmi assordanti. «La diga, la diga!»
Longarone si nasconde come pazza. Ma forse è solo pioggia o un forte tuono. Invece, è che viene la morte da una nube splendente. «Da che parte colpirà? Avete visto Dio? Qualcuno ci aiuti». Come un meteorite, la luce colpisce, spappola e il contatore segna milioni di metri cubi di acqua che orbita e cade come basalto. Tutti compagni di viaggio gli abitanti, lavati da un universo di fango.
Immerso nei vapori del Piave posso contare i corpi accucciati su materia fetida. Donne e bambini corrono nudi nell'acqua, uomini e donne tutti come dannati. Anch'io ho indossato la mia nudità e il fiume mi porta finché troverà pace e mi lascerà sul bordo d un prato sotto i cespugli per riposare nelle braccia della notte.Si ferma il tempo. Qui bisognerebbe proprio fare un nuovo universo, un mondo nuovo dove l'Errore dell'uomo non c'è. Perché di fronte alla ragione impazzita ognuno di noi finge di non sapere oppure crede che non ci siano strade per tornare indietro. Così si è sempre fatto e il tempo riconsegna la memoria ingiallita del passato sulla scia degli avanzi della distruzione sussurrando ricordi di devastazione e deserto. Solamente l'immagine della sera riaffiora nel sibilo del vento e il buio risorge per chiamare le stelle. Qui dormiva la pace e la voce del fiume saziava la valle. Io amavo il silenzio dei campi che circondavano la mia vita e la voce dei gatti in amore sulle cataste di legna. Amavo guardare le cime dei monti dove le nuvole nascondevano la divinità. Che venga il domani, per tornare a vivere, senza essere soli, senza cercare nelle pietre e nella cenere, senza frugare nel pianto della mia gente ogni sera.
Morirono tutti ed era l'inizio di ottobre, quando l'autunno matura i campi e la montagna perfetta raggiunge il colmo dei colori. Sono morti come un gregge tranquillo nell'ovile triturato da una muraglia d'acqua compatta per l'incantesimo di una orribile fiaba. Nell'acqua correvano le case, gli alberi impazziti, le campane in fuga. Sopra vibrava il vento e il brivido della montagna. Crollavano le torri di Longarone, si polverizzava il villaggio Vajont e la Punta Malcolm, Rivalta e Pirago, Villanova e Faè. La polvere delle macerie col fango creò la nuova terra. A Pirago restò in piedi lo spicchio di un campanile; anche la mia casa, al di sopra di ogni congettura. Antiche tombe violate perché i morti sono morti di nuovo. La fotografia del paese è una penosa spianata. E sopra, granelli di polvere fatti con la mia gente che non abbiamo più trovato cercando anche lontano, fino al mare. Tendo le mani a mani invisibili, allontano o cerco ricordi, prendo con mani vuote tracce dello spazio dei morti. Ora vivo in una bella casa, ho stanze e finestre che guardano i monti e il cielo superbo, allargo le mie mani quando voglio per accogliere compagni invisibili. Intuisco la compagnia. Non mi annoio dei sogni, dei giochi o degli scherzi. Le voci della sera sono tante. E un'impresa disperata aprire a tutti. Questa è l'eternità al chiudersi della sera. Sono passati tanti anni, la terra è cresciuta, arrivano zolle da tutto il mondo. Il paese vive di nuovo e il ciclo s'inchina al miracolo. Sì, è giunta finalmente la pace. Ma è l'autunno che riporta il richiamo del passato, timidamente. Suggerisce e illude l'autunno. Sempre.
Perché morirono tutti ed era l'inizio di ottobre, quando l'autunno vestito di nebbia si prendeva le foglie per fare quadri naif, quando il giorno s'impigriva nel vento che cercava la strada del fiume, quando la sera diventava una bella principessa davanti la luna tra spigoli di nuvole, quando la città non aveva ancora acceso le luci artificiali e il tramonto inebriava i monti. Allora lungo la strada romana scendevano i pastori e il gregge e i cani. E il cielo era un paradiso di veli.
Là nel fango sono, dolcissime donne gelose del proprio grembo. Nello scenario macabro dell'orizzonte spianato il vento rantola disperatamente mentre sfilano nel Piave ancora donne incinte con ventre e seno maturi per il parto. E partoriscono, ma la luna ne fa subito il funerale. Dune insanguinate da feti esausti, mani che coprono il pallido ventre ormai freddo e in silenzio. Il fiume macina i corpi insignificanti dei neonati. La terra è morta, non ci sono vagiti tra le rovine della notte. Il dolore a goccia a goccia spegne il pianto, chiude il tempo. Si ferma il barrire delle cose, la notte è una culla dove madre e figlio si rincorrono.
Addio bambini. Non ci sono campane a festa per la vostra nascita. Il cielo è scoppiato sulla terra e ha composto la morte. Vivrete addormentati per secoli dentro il nulla del tempo né troveremo più traccia di voi.
Sogni intrappolati, nidi di case portati via dal vento.Tornano a vagire nel mio cuore le voci per poco, si spengono, sono consumate. Mi attraversa il senso del vuoto. Nel girone dei morti ci stanno anche loro, bimbi non nati o nati morti nell'autunno che s'addormenta al soffio dei venti e impregna ogni cosa come un'opera d'arte.Ora l'acqua riposa, non si vede nessuno. Nessuno accarezza il volto di questi piccoli, non ci sono dolcezze, non c'è tempo non c'è spazio. Annullati, alla deriva. Se avessimo vissuto un qualsiasi tipo di vita, come una volta, il tempo avrebbe portato la luce del sole, le conoscenze dell'oscurità, del bosco e delle montagne. E anche l'amore. E fiori e il gusto del caffè e degli amici. Ci sarebbe stato il corteggiamento, il pianto, il canto, le follie del quotidiano.
Fragili o forti, dolci o nervosi, tutti avrebbero conosciuto il segreto della terra, la fatica, il declino e i sogni nell'incredibile storia dei giorni. Invece sono gli immortali del niente, eclissati da una nube di cristallo già nel grembo. Qui la memoria è come un'urna: quando l'apri riappare il mistero sopra la paura.
Ti prego, Signore, rianima questi morti abbattuti nella vertigine dell'autunno. Ci sia pace in questa terra, per questo sangue.L'immagine della sera affiora nel sibilo del vento e il buio risorge per chiamare le stelle. Qui dorme la pace e la voce del fiume sazia la valle. «Papa', raccontami una storia o ancora la favola che mi piace tanto. Dai, papa', raccontami». E il buio stringe la sera per raccogliere tutte le stelle. «Dormi, ragazzo. Dormi, bimba. C'è la sorpresa, c'è la pace».
Quante favole non sono finite quella sera, che il padre o la madre inventavano per far prendere sonno al proprio bambino. E la storia è rimasta in sospeso sulle dune del Piave. «Bambini, non chiedete più nulla. La notte ora è immensa e fatta di violenza con il fango e le macerie. La vostra infanzia è leggenda». Ma i personaggi delle favole s'aggirano nelle stanze dei ricordi, ogni sera in viaggio a cercar sonno.
Verrà la fine della favola da uno sconosciuto narratore. Moriranno le paure, svanirà l'ansia. Verrà il vento della giustizia e angeli con spade d'oro puniranno i colpevoli, senza rancore e vendetta. Eppure vorrei proprio concludere quelle antiche storie prima che il giorno muoia e il vento mi sorprenda con i suoi ricordi.
Camminando sull'odore delle pietre verso la diga, tutto è steso appiattito fragrante di morte. Pietra dopo pietra, non c'è più terra né confine, solo il vento increspa il tepore dell'autunno cercando la forma del cielo, i meandri del fiume, le foglie del bosco.
Il mio corpo respira la polvere, le cose non rispondono, sono cenere senza coesione. Il sole è bello e con ostinazione sgrana calore sulla spianata prateria. Si accendono i ricordi materializzati dal dolore. Ho amato tanto i ricordi dolorosi scritti nel sonno, disegnati nella fantasia. Ma è stato meglio dire addio a tutte le cose.
Come un fuggitivo ho cercato un nuovo territorio diffidando di ogni pena, fiutando le cose per conquistare un nuovo silenzio. L'enigma del disastro dorme dentro di noi distillato dal tempo e il vento è la voce che cammina inumidita dalle domande di quanti si muovono sulla piana. Non risponde il vento.Io porto il dolore dentro case che non ci sono più, mi ritiro dietro finestre che non hanno senso, prendo la chiave di porte immaginarie e chiudo miserabili resti. L'acqua è venuta dal bordello della montagna con tremiti di luce per pochi rari minuti. Distrutta la chiesa, attòniti i corpi in volo. L'acqua è scesa fino al cuore, il pianto ha vegliato chi tardava a morire. Poi la luce si è spenta e tutto il paese è diventato una unica casa buia.
Nell'immenso cimitero la notte non finiva più di camminare, odore di pietre i morti e i vivi.A volte mi guardo le mani pallide come l'avorio, piene di rughe e le ossa deformate. Mani che hanno armato la ghiaia fino a farla cemento con il ferro e piano piano alzato il bianco muro di una diga immortale. Hanno anche raccolto tanti compagni caduti nella forra abissale. Sono state queste mani a uccidere duemila persone, proprio le mie mani, però si sono sciolte nell'olocausto dando dignità ai cadaveri spianati sulla terra. Stanche mani a forza di alzare pietre nella palude dei morti. Ma sono piene di orgoglio: ci sarà sempre l'errore e la pena nel cammino dei giorni.
Quando il sole lascia i miei occhi e dal cielo giunge il vento della danza notturna e l'oscurità versa i suoi palpiti dentro di me, accetto la sera per fermare il tempo della pace e ascoltare la corrente del fiume che abita questa valle.
La memoria del poco che resta della valle ricostruita. Le strade fatte sopra il fango e le ossa dei morti come un antico altare dove noi consumiamo i passi insieme a infinita gente per capire le cose accadute. La nuova chiesa con dentro il profumo dei santi e il Cristo sulla lucida croce davanti la catena dei monti sotto il sole o la pallida luna. L'oblio del Piave immobile ricomposto dopo la tragedia dove ogni notte vanno a morire i morti. Sui morti sono crollati gli alti palazzi signorili, le chiese, le case di sassi e tutto il bestiame. Le braccia dei morti si sono spezzate contro l'acqua, le bocche si sono riempite di fango sotto la terra rivoltata dall'onda e non hanno potuto urlare: «Signore, perdona questi avvenimenti».
Bruno Pittarello, nato nel 1946 a Treviso, ha abitato fin dal 1952 a Pirago, un'antica popolosa frazione di Longarone a ridosso del
torrente Maè. Dal padre, pensionato di guerra, ha preso la passione per boschi, valli, torrenti e animali che circondano tutto il
Longaronese, dalla madre invece l'amore per la poesia e il piacere
dello scrivere.
Il disastro del Vajont gli ha portato via tutto, risparmiandogli la famiglia comunque coinvolta brutalmente dall'onda del lago.
Scrive da sempre. Ha pubblicato raccolte di poesie tra cui 'Orme
perdute', insieme all'esperto di montagne bellunesi Giuliano Dal Mas, e 'Bracieri di voci'.
Amante in modo particolare delle forme d'arte bellunesi, ha diretto la creazione del museo "Percorso Artistico Bellunese", raccogliendo un centinaio di opere donate gratuitamente dagli artisti e gestite dal Comune di Soverzene (BL).
Ultimo suo lavoro la pubblicazione, tramite la Pro Loco di Longarone, del volume 'Vajont parole nuove'.