|

|
Il Sergente di Paolini alla guerra dei disperati
|

|

|

|
|

|

Una denuncia, 60 anni dopo
Marco Paolini e Mario Rigoni Stern hanno in comune l'origine. Sono veneti entrambi. Ma l'empatia va oltre.
Sta nel fatto che sono due schietti. Che vedono la vita con un'angolatura simile.
Che non hanno peli sulla lingua.
Nel 1953 Rigoni Stern pubblica "Il sergente nella neve" e non lascia spazio a eufemismi, soprattutto per l'epoca. Nel 2004 Marco Paolini, nato tre anni dopo il libro del conterraneo, porta nei teatri il racconto di quell'opera.
E non è più tempo di eufemismi, nè Paolini è abituato a utilizzarne.
Il risultato è come sempre un paio d'ore di intrattenimento piacevole e di approfondimento storico-sociale, a tratti veramente toccante, pure poetico. Perchè Paolini anche quando non è in forma - e nella prima di Artegna (Ud) dirà poi di non essere stato completamente soddisfatto - è sempre impagabile, sa come tenere incollate le persone alla poltroncina del teatro, trasmette in modo del tutto naturale le sue sensazioni.
Nel caso de "Il sergente", poi, supera il suo stesso teatro civile: non racconta fatti nuovi con quel suo modo da cantastorie arrabbiato, non denuncia, non si indigna. Ricorda: ricorda una storia passata, ma sempre valida e ancora vivida nella memoria di sopravvissuti e discendenti. Ricorda che la guerra è sempre un'infamia, ora come allora.
Ricorda - ma non è questa una denuncia? - che anche 60 anni fa ci fu un'ingiustizia, in Italia: mandare a morire migliaia di giovani del tutto inutilmente. E ricorda citando gli opliti di Senofonte, con quella loro strana assonanza con gli alpini - che la storia, vichianamente, si ripete.
Meno convincente il rapporto che Paolini instaura per la prima volta sul palco con un
secondo attore. Come pure i siparietti alla "Grande dittatore" in cui interpreta ora Hitler ora Mussolini. Ma gli servono per riportare la vicenda ai giorni nostri e per citare quell'odiosa "vespa" che del Duce ha fatto un ritratto da «bravo nonno».
(ls) Fonte: settimanale "Il Nuovo Friuli", sez. Culture, pag. 20, 21 Novembre 2004.
|

|
|

|

|

|
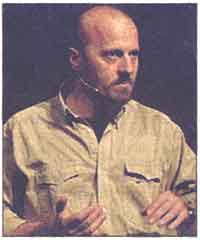
NON CI SONO orizzonti di gloria nella guerra che Marco Paolini ci viene a raccontare col suo nuovo spettacolo Il sergente.
Il Paolini di Vajont, di Ustica, questa volta accantona il teatro di inchiesta e di denuncia. Se c'è da parlare di guerra, ora che l'abbiamo così vicina e presente, sceglie di tornare indietro, andare giù in fondo dove i combattenti sono naufraghi, poveri uomini sperduti, contadini che sognano di «tornare a baita».
"Il sergente nella neve" di Mario Rigoni Stern, testimonianza potente e indimenticabile, ma anche lo "Anabasi" di Senofonte: con questi due libri in tasca Paolini parte per «andare a vedere» che cos'è il Don della ritirata. Mescola, ripensa, riferisce, ed ecco la «sua» guerra. Una scena spoglia, tre fondali a specchio; analogie che rimandano immagini deformate, una macchina da scrivere. Fedele al suo metodo artigiano, Paolini misura se stesso e la reazione del pubblico in questi giorni di prove. Lo spettacolo debutta il 16 [Novembre 2004, nota mia] al Piccolo Teatro di Milano, dodici repliche già tutte esaurite.
 Lui, intanto, aggiunge, toglie, corregge. Lui, intanto, aggiunge, toglie, corregge.
E fatica a rispondere alle domande su che cosa sia questo spettacolo ancora da plasmare, e da dove venga. Soprattutto alla domanda più ovvia: perchè raccontare la guerra? «No, in effetti non vorrei rispondere. Non vorrei più che altro, rispondere dichiarando un'intenzione. Buttare lì un'opinione, dire d'aver capito tutto. Per Mario Rigoni scrivere è stato un anticorpo alla disumanità. Ecco, forse quello che sto cercando è un anticorpo alla disumanità della condizione di spettatore».
È un'illusione, dice Paolini, credere di esser spettatori di una guerra lontana.
«Quando pensi di essere spettatore, sei vittima senza saperlo. Senza la coscienza che non puoi chiamarti fuori, che se rimuovi questa cosa dalla tua vita, stai già scivolando in una perdita». E si ritrova nella voglia di non arrendersi che era di Rigoni e dei suoi alpini: «Ma non come gesto di eroismo. Lui marciava nella neve portandosi in spalla il peso tremendo delle armi. I volantini russi dicevano: "Italiani, siete a 4 mila chilometri da casa, arrendetevi". Chi si arrendeva all'evidenza della realtà, alla stanchezza, chi rinunciava alle armi che aveva, a oliarle, pulirle e tenerle in efficienza, era finito. Io penso che la democrazia sia la nostra arma, quella che ha bisogno di manutenzione, e la dobbiamo curare».
Un teatro, questo del "Sergente", che secondo Paolini certo non è denuncia e nemmeno medicadiIlalia mento dell'anima: «Io credo che il teatro non sia terapia, e nemmeno sia antidoto. Penso con*tilluta alla possibilità di attingere all'esperienza, e che questo serva alla memoria, serva a prepararsi meglio ad affrontare le cose. Un teatro forse come addestramento, come istruzione». E il suo racconto è quello di Rigoni: una guerra di poveri cristi, di disgraziati, di contadini alle prese con altri contadini. Ma è anche, a riprova che nulla cambia davvero, quello di Senofonte. Era stato Elio Vittorini - 1953, per la prima edizione - a chiamare il libro di Rigoni «una piccola Anabasi dialettale».
 E nello spettacolo tornano pagine impressionanti dell'Anabasi di Senofonte, per analogia:
«Venivano abbandonati quei soldati a cui la neve aveva rovinato gli occhi e quelli a cui per il freddo eran andate in cancrena le dita dei piedi. Un modo di proteggere gli occhi dalla neve era marciare tenendo davanti agli occhi qualcosa di nero. Mentre un rimedio per i piedi era muoverli, muoverli, sciogliere i calzari perchè quelli che dormivano coi calzari legati avevano le cinghie che gli penetravano nei piedi e gli si gelavano le suole. E quindi molti dei soldati restavano indietro. E altri si mettevano seduti, e altri si rifiutavano di cominciare a camminare».
Alpino-Oplita: quasi un anagramma.
«Mi ha toccato l'epica di un'impresa disgraziata non eroica. Mi fa scattare un'orgoglio di identità. Niente di guerrescamente nobile, ma un disastro, un naufragio».
Un naufragio, quello degli alpini di Rigoni, che è da invasori, «una condizione disonorevole, fonte di vergogna». «Sapevo bene - scrive Rigoni - che cosa eravamo noi per loro». Loro, quei contadini che Paolini è andato a cercare sul Don. Un viaggio appena concluso, che forse diventerà un cortometraggio, e che lui racconta nello spettacolo. «Ho trovato dei vecchi che, allora, hanno vinto la guerra. Ma hanno facce da vinti. Quando dicevo di essere italiano e gli chiedevo della guerra, si scioglievano. Pensavano di aver di fronte qualcuno più disgraziato di loro. Come se ci avessero visto naufragare e ci avessero tirato su».
 Donne, per lo più, che ricordano bene quegli italiani disgraziati. «Non avevano vestiti abbastanza pesanti». Quello che cantava «mamma sono tanto felice...». Quello che piangeva sempre,«e le lacrime gli si gelavano sulla faccia». Gli imboscati, rintanati come cani a cuccia sotto i tavoli nelle isbe. Piangono anche loro, oggi, le vecchie donne che ricordano senza rabbia. Donne, per lo più, che ricordano bene quegli italiani disgraziati. «Non avevano vestiti abbastanza pesanti». Quello che cantava «mamma sono tanto felice...». Quello che piangeva sempre,«e le lacrime gli si gelavano sulla faccia». Gli imboscati, rintanati come cani a cuccia sotto i tavoli nelle isbe. Piangono anche loro, oggi, le vecchie donne che ricordano senza rabbia.
Ed è nella immensa pietà contadina russa che anche Rigoni trovava un appiglio per la speranza. Quando entra nell'isba e trova soldati russi intorno a una povera zuppa di pane e miglio. Chiede da mangiare, ne danno anche a lui. «Era una cosa molto semplice, anche i russi erano come me, lo sentivo. In quell'isba si era creata tra me e i soldati russi, e le donne e i bambini, un'armonia che non era un armistizio. Era qualcosa di molto più del rispetto che gli animali della foresta hanno l'uno per l'altro. Una volta tanto le circostanze avevano portato degli uomini a saper restare uomini». Se questo è successo una volta, scrive il sergente, «potrà tornare a succedere». Sì, tutto torna a succedere. La guerra, la pietà. E non è consolatorio questo Sergente di Paolini, non voleva esserlo. Una discesa sul fondo, «dalla quale forse torni su». In una scena porta la sola, la vera divisa della ritirata di Russia: una coperta sulla testa, la
divisa di tutti i profughi. Gliel'ha regalata una vecchia, sul Don, «perchè non si può fare un viaggio senza coperta».
Articolo di Fabrizio Ravelli, su "Repubblica" del 09/11/2004.
Tratto dal "Sergente nella neve" di Mario Rigoni Stern. Musiche di Uri Caine.
Dalla Russia con Paolini tragico e demenziale
di FRANCO QUADRI
ARRIVATO a narrare le grandi catastrofi dei nostri giorni dopo essere partito dai suoi diari di ragazzo, Marco Paolini ha anche un debole per gli scrittori della sua terra.
 Ora, dopo qualche spettacolo di denuncia un po' deludente, ha deciso di mischiare le carte e va a pescarsi un tema nella tragica ritirata di Russia che ispirò 'Il sergente nella neve' di Mario Rigoni Stern, col quale ha già girato un film prima di dedicargli questo lavoro, dove non riprende letteralmente il testo ma è lui a raccontare, rendendo allo scrittore una sorta d'omaggio. Alla personale reinvenzione del libro famoso aggiunge anche cronache di una sua recente ricognizione di confronto da lui effettuata sul Don e nei luoghi della tragedia, mentre non rinuncia a recuperare dalla grecità il parallelismo con la fuga di un esercito
dalla guerra condotto e narrato da Senofonte nell'Anabasi. Ora, dopo qualche spettacolo di denuncia un po' deludente, ha deciso di mischiare le carte e va a pescarsi un tema nella tragica ritirata di Russia che ispirò 'Il sergente nella neve' di Mario Rigoni Stern, col quale ha già girato un film prima di dedicargli questo lavoro, dove non riprende letteralmente il testo ma è lui a raccontare, rendendo allo scrittore una sorta d'omaggio. Alla personale reinvenzione del libro famoso aggiunge anche cronache di una sua recente ricognizione di confronto da lui effettuata sul Don e nei luoghi della tragedia, mentre non rinuncia a recuperare dalla grecità il parallelismo con la fuga di un esercito
dalla guerra condotto e narrato da Senofonte nell'Anabasi.
Ma se al centro del racconto restano gli episodi coloriti o desolati di un disastro per cui un
demenziale sogno di grandeur spedì alla morte nel gelo interi battaglioni, costretti dalla disorganizzazione a ricorrere all'arte di arrangiarsi, Paolini non costruisce il suo racconto con l'ordine pedante e gli schemi con cui indagò sul Petrolchimico qualche anno fa; qui gioca sulla frammentazione degli episodi e sovrappone i tempi, per cui le vicende del '42-'43 non seguono un ordine preciso e allo stesso tempo s'incrociano con la sua visita alla Russia di oggi, e non solo.
 Con o senza berretto, davanti a una grande carta geografica e a tre argentee strisce riflettenti, con un ragazzo (Marco Austeri) chiamato a volte in causa e occupato anche a fornire qualche nota che si aggiunge alle musiche di Uri Caine, Marco Paolini riversa le sue parole sul pubblico col gusto dell'improvvisatore, raramente legge qualche pezzo dal libro, mischia i tempi storici, accavalla lingua e dialetti, frastaglia il discorso e monta e smonta a suo modo l'azione, sottratta a una vera elencazione dei fatti. Con o senza berretto, davanti a una grande carta geografica e a tre argentee strisce riflettenti, con un ragazzo (Marco Austeri) chiamato a volte in causa e occupato anche a fornire qualche nota che si aggiunge alle musiche di Uri Caine, Marco Paolini riversa le sue parole sul pubblico col gusto dell'improvvisatore, raramente legge qualche pezzo dal libro, mischia i tempi storici, accavalla lingua e dialetti, frastaglia il discorso e monta e smonta a suo modo l'azione, sottratta a una vera elencazione dei fatti.
A compenso di qualche confusione che ne può nascere, la contemporaneità dei piani e dei modi narrativi aiuta a rivivere la storia come nostra, riportandoci tra angosce, orrori, disordini, malgoverni assai prossimi a quelli della Babele in cui viviamo.
Fonte: recensione di Franco Quadri, su Repubblica, (Cultura), 22 Novembre 2004, pag. N° 35
|

|

|

|
|

|
 A Tina Merlin, partigiana, giornalista, scrittrice
A Tina Merlin, partigiana, giornalista, scrittrice
"Oggi tuttavia non si può soltanto piangere, è tempo di imparare qualcosa". Era il 10 ottobre 1963 quando Tina Merlin scriveva queste parole sul suo giornale, l'Unità.
Il giorno prima sul Vajont era crollato, insieme al monte Toc, il mito della tecnologia come antidoto a ogni emigrazione, a ogni miseria, a ogni disperazione.
Tre anni prima, a Milano si processava L'Unità, o meglio la sua giornalista Tina Merlin, bellunese, rea di aver scritto sul giornale contro la SADE, azienda del monopolio elettrico in mano ai padroni di Porto Marghera, per la diga che si sta costruendo sù, al Vajont.
Lei e gli abitanti di Erto, il paese che s'affaccia sul bacino artificiale, accusavano la SADE di fare la diga in un posto sbagliato, pericoloso. Tina e gli ertani, spiega Renzo Franzin che Tina la conosceva bene così come seguì l'intera vicenda, verranno assolti perchè nell'articolo incriminato non si trovano notizie nè false, nè esagerate, nè tendenziose. Ma chi doveva fermare i lavori alla diga non lo fa. La storia sembra chiudersi, tre anni dopo, con un saldo di 2000 morti.
Ma chi era Tina Merlin? Ha scritto di lei Mario Rigoni Stern: "Tina Merlin non era scrittrice da rotocalchi, nè aveva padrini che contavano, nè titoli accademici".
Ed era una forza della natura e del pensiero. Forte e orgogliosa. Con la mente libera. La verità fa più paura della frana di una montagnadiceva.
A quarant'anni da quell'infame disastro e a dodici ormai dalla morte di quella donna che per prima - spesso sola ma con forza ineguagliabile - denunciò al mondo ciò che stava per accadere, a Tina Merlin sono stati dedicati un incontro e una mostra (Le radici del cielo. Tina Merlin: una donna, una voce libera) per tracciare di lei la storia di partigiana, giornalista e scrittrice.
Cenni biografici su Tina Merlin
Tina Merlin nasce a Trichiana (Belluno) il 19 agosto 1926.
Durante la guerra di liberazione è staffetta partigiana nella brigata "Garibaldi".
Dal 1951 al 1967 è corrispondente locale del quotidiano "L'Unità".
Esordisce come scrittrice nel 1957, con 'Menicà (Renzo Cortina Editore, Pavia), raccolta di racconti partigiani.
 Nello stesso periodo segue da vicino le vicende del Vajont, prima e dopo la catastrofe del 9 ottobre 1963 che costò la vita a duemila persone. Nello stesso periodo segue da vicino le vicende del Vajont, prima e dopo la catastrofe del 9 ottobre 1963 che costò la vita a duemila persone.
Segue le lotte degli operai tessili di Valdagno che documenta nel volume 'Avanguardia di classe e politica delle alleanze' (Editori Riuniti, Roma 1969) e dei ceramisti di Bassano che racconta nel volume 'Siamo tutti una famiglià (Odeonlibri Editrice, Vicenza1982).
Nel 1983, pubblica per le edizioni La Pietra di Milano 'Sulla pelle viva. Il caso del Vajont. Come si costruisce una catastrofe', in seguito ristampato da Il Cardo di Venezia e Cierre di Verona.
Collabora a varie riviste: Noi donne, Vie nuove, Rinascita, Patria indipendente, L'uomo e l'ambiente, di cui è stata direttrice; Veneto emigrazione, Vie nuove dell'agricoltura, Protagonisti.
Muore il 22 dicembre 1991.
Nel 1993, l'Associazione culturale a lei dedicata, sorta nel novembre 1992, con l'aiuto dello scrittore Mario Rigoni Stern, pubblica postumo per le Edizioni Il Poligrafo di Padova il volume autobiografico 'La casa sulla Marteniga'.
Fonte: www.pariopportunita.provincia.venezia.it
|

|
|

|

|

|
|

|
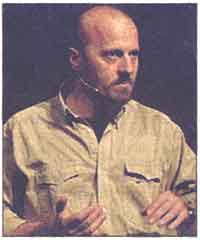



 Donne, per lo più, che ricordano bene quegli italiani disgraziati. «Non avevano vestiti abbastanza pesanti». Quello che cantava «mamma sono tanto felice...». Quello che piangeva sempre,«e le lacrime gli si gelavano sulla faccia». Gli imboscati, rintanati come cani a cuccia sotto i tavoli nelle isbe. Piangono anche loro, oggi, le vecchie donne che ricordano senza rabbia.
Donne, per lo più, che ricordano bene quegli italiani disgraziati. «Non avevano vestiti abbastanza pesanti». Quello che cantava «mamma sono tanto felice...». Quello che piangeva sempre,«e le lacrime gli si gelavano sulla faccia». Gli imboscati, rintanati come cani a cuccia sotto i tavoli nelle isbe. Piangono anche loro, oggi, le vecchie donne che ricordano senza rabbia. Ora, dopo qualche spettacolo di denuncia un po' deludente, ha deciso di mischiare le carte e va a pescarsi un tema nella tragica ritirata di Russia che ispirò 'Il sergente nella neve' di Mario Rigoni Stern, col quale ha già girato un film prima di dedicargli questo lavoro, dove non riprende letteralmente il testo ma è lui a raccontare, rendendo allo scrittore una sorta d'omaggio. Alla personale reinvenzione del libro famoso aggiunge anche cronache di una sua recente ricognizione di confronto da lui effettuata sul Don e nei luoghi della tragedia, mentre non rinuncia a recuperare dalla grecità il parallelismo con la fuga di un esercito
dalla guerra condotto e narrato da Senofonte nell'Anabasi.
Ora, dopo qualche spettacolo di denuncia un po' deludente, ha deciso di mischiare le carte e va a pescarsi un tema nella tragica ritirata di Russia che ispirò 'Il sergente nella neve' di Mario Rigoni Stern, col quale ha già girato un film prima di dedicargli questo lavoro, dove non riprende letteralmente il testo ma è lui a raccontare, rendendo allo scrittore una sorta d'omaggio. Alla personale reinvenzione del libro famoso aggiunge anche cronache di una sua recente ricognizione di confronto da lui effettuata sul Don e nei luoghi della tragedia, mentre non rinuncia a recuperare dalla grecità il parallelismo con la fuga di un esercito
dalla guerra condotto e narrato da Senofonte nell'Anabasi. Con o senza berretto, davanti a una grande carta geografica e a tre argentee strisce riflettenti, con un ragazzo (Marco Austeri) chiamato a volte in causa e occupato anche a fornire qualche nota che si aggiunge alle musiche di Uri Caine, Marco Paolini riversa le sue parole sul pubblico col gusto dell'improvvisatore, raramente legge qualche pezzo dal libro, mischia i tempi storici, accavalla lingua e dialetti, frastaglia il discorso e monta e smonta a suo modo l'azione, sottratta a una vera elencazione dei fatti.
Con o senza berretto, davanti a una grande carta geografica e a tre argentee strisce riflettenti, con un ragazzo (Marco Austeri) chiamato a volte in causa e occupato anche a fornire qualche nota che si aggiunge alle musiche di Uri Caine, Marco Paolini riversa le sue parole sul pubblico col gusto dell'improvvisatore, raramente legge qualche pezzo dal libro, mischia i tempi storici, accavalla lingua e dialetti, frastaglia il discorso e monta e smonta a suo modo l'azione, sottratta a una vera elencazione dei fatti. A Tina Merlin, partigiana, giornalista, scrittrice
A Tina Merlin, partigiana, giornalista, scrittrice
 Nello stesso periodo segue da vicino le vicende del Vajont, prima e dopo la catastrofe del 9 ottobre 1963 che costò la vita a duemila persone.
Nello stesso periodo segue da vicino le vicende del Vajont, prima e dopo la catastrofe del 9 ottobre 1963 che costò la vita a duemila persone.